Archivio del Tag ‘capitalismo’
-
Vaticanomics, l’Opus Dei a lezione dalla Goldman Sachs
 Il diavolo e l’acqua santa. Il denaro sterco del demonio. Gli pseudo-opposti che si incontrano e si suggeriscono regole di comportamento. Con tanti saluti alla nuova linea della Chiesa attenta alla povertà, con la quale Francesco I ha voluto caratterizzare il suo pontificato. La Pontificia Università Santa Croce, che dipende dall’Opus Dei, ha deciso che i suoi studenti, futuri sacerdoti, debbano conoscere l’economia e la finanza, per comprendere meglio il senso del proprio apostolato e dove esso debba indirizzarsi nel sociale. Fino a qui, niente di trascendentale. Non si vive di solo spirito e poi, come si dice in certi ambienti, il cibo materiale deve poter trasformarsi in cibo spirituale. Non sarà più sufficiente quindi agli studenti dell’Opera fondata da Escrivà de Balaguer essere in grado di maneggiare la teologia, la filosofia, il diritto canonico e la comunicazione. Da qui l’idea di creare un corso denominato “Economics for Ecclesiastic” grazie al quale, questo è l’intendimento, i futuri sacerdoti non si troveranno troppo isolati dal mondo reale.Il problema sta nella personalità del professore che erudirà le future tonache sul significato etico dell’economia e della finanza nel mondo contemporaneo. Sarà infatti Brian Griffiths of Fforestafch, un cognome impronunciabile che è tutto un programma, ad intrattenere gli studenti su “Le sfide etiche e culturali per la finanza contemporanea”. Il punto è che il signore in questione è stato vicepresidente esecutivo di Goldman Sachs International, ossia della banca di affari che nell’immaginario del cittadino medio Usa rappresenta il simbolo stesso della più schifosa speculazione che strozza i piccoli risparmiatori e crea le condizioni per portargli via la casa. In Italia, come in Europa, la Goldman Sachs è la banca che ha speculato a man bassa contro i titoli di Stato, i Bonos spagnoli e i Btp italiani, con l’intento di affossare l’euro. Insomma, Brian Griffiths of Fforestafch è un banchiere che vanta non poche responsabilità nell’aver contribuito ad aggravare una situazione interna, come quella italiana, già di per sé grave per l’altissimo debito pubblico.È quasi superfluo aggiungere che Griffiths è membro della Camera dei Lords (appartiene quindi alla nomenklatura inglese) ed è stato consigliere di Margareth Thatcher per le privatizzazioni e per deregolamentare il mercato interno. Si tratta di uno di quei tecnocrati che sostengono la creazione di un grande mercato globale senza vincoli di frontiere e di dazi doganali. Un mercato globale che implica la cancellazione degli Stati nazionali e la loro sottomissione ad un complesso di strutture sovranazionali, di fatto in mano all’Alta Finanza. Una strategia che il mondo cattolico dovrebbe teoricamente vedere con ostilità. Questo in teoria perché ci sono, e non sono pochi, banchieri cattolici che sognano lo stesso traguardo, sia pure con una attenzione paternalista verso i poveri e gli emarginati. E in Italia i banchieri legati all’Opus Dei sono molti e potenti, anche se spesso quasi sconosciuti al grande pubblico. Tra i più noti svetta Antonio Fazio, ex governatore della Banca d’Italia. In Spagna, fa parte dell’Opus Dei il presidente del Banco di Santander, Emilio Botin.Questo per dire che non esiste una finanza “laica” e una finanza “cattolica”, ma esiste soltanto una finanza che realizza affari e profitti e intende continuare a farli. Come dimostra l’enorme patrimonio mobiliare e immobiliare della chiesa cattolica e delle sue tante diramazioni. Ma nemmeno i protestanti scherzano, visto che Griffiths ha presieduto in passato il Lambeth Fund, controllato dall’arcivescovo di Canterbury. E allora questo connubio tra Opus Dei e Goldman Sachs trova la sua ragione di essere nel medesimo approccio universalista. Del resto il capitalismo liberista si è sempre fatto forte, basti vedere Max Weber, di una profonda impronta evangelica e biblica. Ma l’Opus Dei non è l’unica struttura in ambito cattolico a tenere buoni rapporti con certi ambienti e ad allevare futuri banchieri. Mario Draghi, anche lui un ex Goldman Sachs, ha studiato dai gesuiti. E questo non gli ha impedito di caratterizzare la sua attività nella direzione di rafforzare il potere delle banche e della finanza e al tempo stesso di impoverire i cittadini italiani ed europei, come sappiamo ormai a menadito.(Irene Sabeni, “L’etica di Opus Goldman Sachs Dei”, da “Il Nodo Gordiano” del 4 agosto 2014).
Il diavolo e l’acqua santa. Il denaro sterco del demonio. Gli pseudo-opposti che si incontrano e si suggeriscono regole di comportamento. Con tanti saluti alla nuova linea della Chiesa attenta alla povertà, con la quale Francesco I ha voluto caratterizzare il suo pontificato. La Pontificia Università Santa Croce, che dipende dall’Opus Dei, ha deciso che i suoi studenti, futuri sacerdoti, debbano conoscere l’economia e la finanza, per comprendere meglio il senso del proprio apostolato e dove esso debba indirizzarsi nel sociale. Fino a qui, niente di trascendentale. Non si vive di solo spirito e poi, come si dice in certi ambienti, il cibo materiale deve poter trasformarsi in cibo spirituale. Non sarà più sufficiente quindi agli studenti dell’Opera fondata da Escrivà de Balaguer essere in grado di maneggiare la teologia, la filosofia, il diritto canonico e la comunicazione. Da qui l’idea di creare un corso denominato “Economics for Ecclesiastic” grazie al quale, questo è l’intendimento, i futuri sacerdoti non si troveranno troppo isolati dal mondo reale.Il problema sta nella personalità del professore che erudirà le future tonache sul significato etico dell’economia e della finanza nel mondo contemporaneo. Sarà infatti Brian Griffiths of Fforestafch, un cognome impronunciabile che è tutto un programma, ad intrattenere gli studenti su “Le sfide etiche e culturali per la finanza contemporanea”. Il punto è che il signore in questione è stato vicepresidente esecutivo di Goldman Sachs International, ossia della banca di affari che nell’immaginario del cittadino medio Usa rappresenta il simbolo stesso della più schifosa speculazione che strozza i piccoli risparmiatori e crea le condizioni per portargli via la casa. In Italia, come in Europa, la Goldman Sachs è la banca che ha speculato a man bassa contro i titoli di Stato, i Bonos spagnoli e i Btp italiani, con l’intento di affossare l’euro. Insomma, Brian Griffiths of Fforestafch è un banchiere che vanta non poche responsabilità nell’aver contribuito ad aggravare una situazione interna, come quella italiana, già di per sé grave per l’altissimo debito pubblico.È quasi superfluo aggiungere che Griffiths è membro della Camera dei Lords (appartiene quindi alla nomenklatura inglese) ed è stato consigliere di Margareth Thatcher per le privatizzazioni e per deregolamentare il mercato interno. Si tratta di uno di quei tecnocrati che sostengono la creazione di un grande mercato globale senza vincoli di frontiere e di dazi doganali. Un mercato globale che implica la cancellazione degli Stati nazionali e la loro sottomissione ad un complesso di strutture sovranazionali, di fatto in mano all’Alta Finanza. Una strategia che il mondo cattolico dovrebbe teoricamente vedere con ostilità. Questo in teoria perché ci sono, e non sono pochi, banchieri cattolici che sognano lo stesso traguardo, sia pure con una attenzione paternalista verso i poveri e gli emarginati. E in Italia i banchieri legati all’Opus Dei sono molti e potenti, anche se spesso quasi sconosciuti al grande pubblico. Tra i più noti svetta Antonio Fazio, ex governatore della Banca d’Italia. In Spagna, fa parte dell’Opus Dei il presidente del Banco di Santander, Emilio Botin.Questo per dire che non esiste una finanza “laica” e una finanza “cattolica”, ma esiste soltanto una finanza che realizza affari e profitti e intende continuare a farli. Come dimostra l’enorme patrimonio mobiliare e immobiliare della chiesa cattolica e delle sue tante diramazioni. Ma nemmeno i protestanti scherzano, visto che Griffiths ha presieduto in passato il Lambeth Fund, controllato dall’arcivescovo di Canterbury. E allora questo connubio tra Opus Dei e Goldman Sachs trova la sua ragione di essere nel medesimo approccio universalista. Del resto il capitalismo liberista si è sempre fatto forte, basti vedere Max Weber, di una profonda impronta evangelica e biblica. Ma l’Opus Dei non è l’unica struttura in ambito cattolico a tenere buoni rapporti con certi ambienti e ad allevare futuri banchieri. Mario Draghi, anche lui un ex Goldman Sachs, ha studiato dai gesuiti. E questo non gli ha impedito di caratterizzare la sua attività nella direzione di rafforzare il potere delle banche e della finanza e al tempo stesso di impoverire i cittadini italiani ed europei, come sappiamo ormai a menadito.(Irene Sabeni, “L’etica di Opus Goldman Sachs Dei”, da “Il Nodo Gordiano” del 4 agosto 2014).Il diavolo e l’acqua santa. Il denaro sterco del demonio. Gli pseudo-opposti che si incontrano e si suggeriscono regole di comportamento. Con tanti saluti alla nuova linea della Chiesa attenta alla povertà, con la quale Francesco I ha voluto caratterizzare il suo pontificato. La Pontificia Università Santa Croce, che dipende dall’Opus Dei, ha deciso che i suoi studenti, futuri sacerdoti, debbano conoscere l’economia e la finanza, per comprendere meglio il senso del proprio apostolato e dove esso debba indirizzarsi nel sociale. Fino a qui, niente di trascendentale. Non si vive di solo spirito e poi, come si dice in certi ambienti, il cibo materiale deve poter trasformarsi in cibo spirituale. Non sarà più sufficiente quindi agli studenti dell’Opera fondata da Escrivà de Balaguer essere in grado di maneggiare la teologia, la filosofia, il diritto canonico e la comunicazione. Da qui l’idea di creare un corso denominato “Economics for Ecclesiastic” grazie al quale, questo è l’intendimento, i futuri sacerdoti non si troveranno troppo isolati dal mondo reale.
-
Paghiamo lavori inutili e sfruttiamo chi è davvero utile
 Nel lontano 1930, John Maynard Keynes prevedeva che entro la fine del secolo la tecnologia in Occidente sarebbe progredita al punto di regalarci una settimana lavorativa di appena 15 ore. Invece, è accaduto il contrario: «La tecnologia è stata arruolata per inventare nuovi modi di farci lavorare tutti di più», scrive l’antropologo David Graeber. E a tale scopo «sono stati creati lavori che sono di fatto inutili». Enormi schiere di persone, in Europa e Nord America, lavorano in ufficio, dove «trascorrono tutta la loro vita professionale eseguendo compiti che segretamente ritengono inutili». Graeber parla di «danni morali e spirituali», praticamente «una cicatrice sulla nostra coscienza collettiva», anche se non ne parla nessuno. Perché l’utopia promessa da Keynes non si è mai materializzata? «La spiegazione standard è che Keynes non aveva preventivato la mole dell’incremento del consumismo», ma per l’antropologo la verità è un’altra: l’élite capitalista sa benissimo che, una volta liberate dall’incombenza del lavoro full time, le masse cominciano a “pensare”, e a reclamare diritti per una vita diversa, specie se le macchine faticano al posto dell’uomo.«Dagli anni Venti in poi abbiamo assistito alla creazione di un’infinità di nuovi lavori e industrie, ma sono pochissimi quelli che hanno a che vedere con la produzione e la distribuzione di sushi, iPhone o scarpe da ginnastica costose», scrive Graeber in un post ripreso da “Megachip”. «Allora cosa sono esattamente questi nuovi lavori?». Durante il secolo scorso, il numero di lavoratori impiegati come domestici, nel settore industriale e in quello agricolo è crollato. Parallelamente, «le libere professioni, i lavori dirigenziali, d’ufficio, di vendita e di servizio» sono triplicati, passando da un quarto degli impieghi complessivi a tre quarti. «In altre parole, i lavori produttivi, esattamente come previsto, sono stati in gran parte sostituiti dall’automazione», anche calcolando gli operai cinesi e indiani. «Ma anziché consentire una significativa riduzione delle ore di lavoro per rendere la popolazione mondiale libera di dedicarsi ai propri progetti, piaceri e idee, abbiamo assistito all’esplosione non tanto del settore dei “servizi”, quanto di quello amministrativo».Sono nate nuove industrie come quella dei servizi finanziari o del telemarketing, mentre c’è stata un’espansione senza precedenti di settori come quello giuridico-aziendale, accademico, della amministrazione sanitaria, delle risorse umane e delle pubbliche relazioni. Senza contare le aziende che a queste industrie forniscono assistenza amministrativa, tecnica o relativa alla sicurezza, così come «l’esercito di attività secondarie (come i toelettatori di cani o i fattorini che consegnano pizze tutta la notte) che esistono soltanto perché le altre persone passano tanto tempo a lavorare in tutte le altre». Sono mestieri che Graeber propone di definire “lavori stupidi”: «È come se esistesse qualcuno che inventa lavori inutili solo per farci continuare a lavorare. E proprio qui sta il mistero: nel capitalismo, questo è esattamente quel che non dovrebbe succedere». Infatti, «l’ultima cosa che deve fare un’azienda desiderosa di profitti è sborsare soldi a lavoratori di cui non ha davvero bisogno. Eppure, non si sa perché, succede lo stesso».È vero, «le grandi aziende operano spesso tagli spietati», ma attenzione: «Licenziamenti e prepensionamenti colpiscono immancabilmente la classe delle persone che fabbricano, spostano, riparano e mantengono in funzione le cose». Per una strana alchimia che nessuno sa davvero spiegare, continua Graeber, «ultimamente il numero di passacarte salariati sembra aumentare, e sempre più lavoratori dipendenti si ritrovano – un po’ come i sovietici di una volta – a lavorare in teoria 40 se non 50 ore alla settimana, ma lavorandone di fatto 15 proprio come previsto da Keynes, perché il resto del loro tempo serve per organizzare o partecipare a seminari motivazionali, aggiornare i profili Facebook o scaricare roba». Per Graeber, la spiegazione non è economica: è morale e politica. «La classe dirigente si è resa conto che una popolazione felice, produttiva e con del tempo libero a disposizione è un pericolo mortale: pensate a quel che è cominciato a succedere quando negli anni Sessanta ci si è avvicinati a una vaga approssimazione di questa cosa». E l’idea che il lavoro sia un valore morale in sé, al punto da pensare che «chiunque non desideri sottomettersi a un’intensa disciplina lavorativa per la maggior parte delle sue ore di veglia non meriti niente», torna straordinariamente comoda a molti.Un amico poeta e musicista, racconta Graeber, dopo un paio di dischi che avevano «migliorato la vita di tante persone in tutto il mondo», è stato costretto – parole sue – a «imboccare la strada che sceglie in automatico tanta gente che non sa dove andare: la facoltà di giurisprudenza». Oggi lavora come avvocato aziendale per un importante studio di New York. «Lui per primo ammette di fare un lavoro del tutto privo di senso, che non fornisce nessun contributo al mondo e che, secondo lui, in realtà non dovrebbe esistere». Domanda: che razza di società è la nostra, che genera «una domanda estremamente limitata di poeti-musicisti talentuosi», a fronte di una domanda apparentemente infinita di specialisti in diritto aziendale? Risposta: se «la maggior parte della ricchezza disponibile la controlla l’1% della popolazione», allora quello che definiamo “mercato” rigetterà «ciò che loro, e nessun altro», non considerano utile o importante. Peggio ancora: chi fa lavori “stupidi” se ne rende perfettamente conto. «Credo di non aver mai conosciuto un avvocato aziendale che non pensasse di fare un lavoro stupido».Lo stesso vale per quasi tutte le nuove industrie: «Esiste un’intera classe di lavoratori salariati che, se li incontri a una festa e ammetti di fare un mestiere considerato interessante (l’antropologo, per esempio), si rifiuta anche soltanto di dirti che lavoro fa. Fategli bere due o tre drink, e si lanceranno in vere e proprie tirate su quanto inutile e stupido sia in realtà il loro lavoro», continua Graeber. «Stiamo parlando di una violenza psicologica profonda. Come si può anche solo cominciare a parlare di dignità del lavoro, quando in cuor suo una persona ritiene che il proprio lavoro non debba esistere?». Tuttavia, «il talento tutto particolare della nostra società» sta nel fatto che i suoi governanti hanno escogitato un modo per garantire che la frustrazione e la rabbia vengano indirizzate contro chi invece fa un lavoro sensato. Strana regola: «Più il lavoro di un individuo giova palesemente ad altre persone, minori sono le probabilità che questo lavoro venga pagato».Si domanda Graeber: che succederebbe se quest’intera classe di persone scomparisse? «Dite quel che volete di infermieri, spazzini e meccanici: è palese che, se dovessero sparire in una nuvola di fumo, gli effetti sarebbero immediati e catastrofici. Un mondo senza insegnanti e scaricatori di porto finirebbe presto nei guai, e anche un mondo senza scrittori di fantascienza o musicisti ska sarebbe evidentemente peggiore». Al contrario, «non è del tutto chiaro in che modo l’umanità soffrirebbe se dovessero svanire allo stesso modo tutti gli amministratori delegati di società d’investimenti, i lobbisti, gli addetti alle pubbliche relazioni, gli analisti assicurativi, i lavoratori del telemarketing, gli ufficiali giudiziari o i consulenti legali (molti sospettano che potrebbe significativamente migliorare)». Eppure, fatta salva una manciata di stimatissime eccezioni, come ad esempio i medici, «la regola resiste sorprendentemente bene». E, «cosa ancor più perversa, sembra circolare la diffusa convinzione che sia giusto così».Questo, aggiunge Graeber, è «uno dei punti di forza segreti dei populisti di destra», quelli che «fomentano il rancore contro i dipendenti della metropolitana che paralizzano Londra per il rinnovo del contratto», perché «il fatto stesso che i dipendenti della metropolitana siano in grado di paralizzare Londra è la riprova che il loro lavoro è necessario, ma a infastidire la gente sembra sia proprio questo». Cosa ancora più evidente negli Stati Uniti, dove i repubblicani «stanno riuscendo con molto successo a mobilitare il risentimento contro gli insegnanti o contro gli operai dell’industria dell’automobile», a causa di stipendi e benefit che sembrano eccessivi. È come se gli stessero dicendo: voi, che a quanto pare fate lavori veri, necessari, avete anche la faccia tosta di aspettarvi delle pensioni e un’assistenza sanitaria da classe media?«Se qualcuno avesse progettato un sistema del lavoro fatto su misura per salvaguardare il potere del capitale, non avrebbe potuto riuscirci meglio», conclude Graeber. «I lavoratori veri, quelli produttivi, vengono spremuti e sfruttati implacabilmente», mentre gli altri «si dividono tra un atterrito strato di disoccupati, disprezzato da tutti, e un più ampio strato di persone che in pratica vengono pagate per non fare nulla». Queste persone «ricoprono incarichi progettati per farle identificare con i punti di vista e le sensibilità della classe dirigente (manager, amministratori)», ma al tempo stesso «covano un segreto rancore nei confronti di chiunque faccia un lavoro provvisto di un chiaro e innegabile valore sociale». Non è un sistema progettato in modo conscio, è emerso da quasi un secolo di tentativi empirici. «Ma è anche l’unica spiegazione del perché, nonostante le nostre capacità tecnologiche, non lavoriamo tutti quanti solo tre o quattro ore al giorno».
Nel lontano 1930, John Maynard Keynes prevedeva che entro la fine del secolo la tecnologia in Occidente sarebbe progredita al punto di regalarci una settimana lavorativa di appena 15 ore. Invece, è accaduto il contrario: «La tecnologia è stata arruolata per inventare nuovi modi di farci lavorare tutti di più», scrive l’antropologo David Graeber. E a tale scopo «sono stati creati lavori che sono di fatto inutili». Enormi schiere di persone, in Europa e Nord America, lavorano in ufficio, dove «trascorrono tutta la loro vita professionale eseguendo compiti che segretamente ritengono inutili». Graeber parla di «danni morali e spirituali», praticamente «una cicatrice sulla nostra coscienza collettiva», anche se non ne parla nessuno. Perché l’utopia promessa da Keynes non si è mai materializzata? «La spiegazione standard è che Keynes non aveva preventivato la mole dell’incremento del consumismo», ma per l’antropologo la verità è un’altra: l’élite capitalista sa benissimo che, una volta liberate dall’incombenza del lavoro full time, le masse cominciano a “pensare”, e a reclamare diritti per una vita diversa, specie se le macchine faticano al posto dell’uomo.«Dagli anni Venti in poi abbiamo assistito alla creazione di un’infinità di nuovi lavori e industrie, ma sono pochissimi quelli che hanno a che vedere con la produzione e la distribuzione di sushi, iPhone o scarpe da ginnastica costose», scrive Graeber in un post ripreso da “Megachip”. «Allora cosa sono esattamente questi nuovi lavori?». Durante il secolo scorso, il numero di lavoratori impiegati come domestici, nel settore industriale e in quello agricolo è crollato. Parallelamente, «le libere professioni, i lavori dirigenziali, d’ufficio, di vendita e di servizio» sono triplicati, passando da un quarto degli impieghi complessivi a tre quarti. «In altre parole, i lavori produttivi, esattamente come previsto, sono stati in gran parte sostituiti dall’automazione», anche calcolando gli operai cinesi e indiani. «Ma anziché consentire una significativa riduzione delle ore di lavoro per rendere la popolazione mondiale libera di dedicarsi ai propri progetti, piaceri e idee, abbiamo assistito all’esplosione non tanto del settore dei “servizi”, quanto di quello amministrativo».Sono nate nuove industrie come quella dei servizi finanziari o del telemarketing, mentre c’è stata un’espansione senza precedenti di settori come quello giuridico-aziendale, accademico, della amministrazione sanitaria, delle risorse umane e delle pubbliche relazioni. Senza contare le aziende che a queste industrie forniscono assistenza amministrativa, tecnica o relativa alla sicurezza, così come «l’esercito di attività secondarie (come i toelettatori di cani o i fattorini che consegnano pizze tutta la notte) che esistono soltanto perché le altre persone passano tanto tempo a lavorare in tutte le altre». Sono mestieri che Graeber propone di definire “lavori stupidi”: «È come se esistesse qualcuno che inventa lavori inutili solo per farci continuare a lavorare. E proprio qui sta il mistero: nel capitalismo, questo è esattamente quel che non dovrebbe succedere». Infatti, «l’ultima cosa che deve fare un’azienda desiderosa di profitti è sborsare soldi a lavoratori di cui non ha davvero bisogno. Eppure, non si sa perché, succede lo stesso».È vero, «le grandi aziende operano spesso tagli spietati», ma attenzione: «Licenziamenti e prepensionamenti colpiscono immancabilmente la classe delle persone che fabbricano, spostano, riparano e mantengono in funzione le cose». Per una strana alchimia che nessuno sa davvero spiegare, continua Graeber, «ultimamente il numero di passacarte salariati sembra aumentare, e sempre più lavoratori dipendenti si ritrovano – un po’ come i sovietici di una volta – a lavorare in teoria 40 se non 50 ore alla settimana, ma lavorandone di fatto 15 proprio come previsto da Keynes, perché il resto del loro tempo serve per organizzare o partecipare a seminari motivazionali, aggiornare i profili Facebook o scaricare roba». Per Graeber, la spiegazione non è economica: è morale e politica. «La classe dirigente si è resa conto che una popolazione felice, produttiva e con del tempo libero a disposizione è un pericolo mortale: pensate a quel che è cominciato a succedere quando negli anni Sessanta ci si è avvicinati a una vaga approssimazione di questa cosa». E l’idea che il lavoro sia un valore morale in sé, al punto da pensare che «chiunque non desideri sottomettersi a un’intensa disciplina lavorativa per la maggior parte delle sue ore di veglia non meriti niente», torna straordinariamente comoda a molti.Un amico poeta e musicista, racconta Graeber, dopo un paio di dischi che avevano «migliorato la vita di tante persone in tutto il mondo», è stato costretto – parole sue – a «imboccare la strada che sceglie in automatico tanta gente che non sa dove andare: la facoltà di giurisprudenza». Oggi lavora come avvocato aziendale per un importante studio di New York. «Lui per primo ammette di fare un lavoro del tutto privo di senso, che non fornisce nessun contributo al mondo e che, secondo lui, in realtà non dovrebbe esistere». Domanda: che razza di società è la nostra, che genera «una domanda estremamente limitata di poeti-musicisti talentuosi», a fronte di una domanda apparentemente infinita di specialisti in diritto aziendale? Risposta: se «la maggior parte della ricchezza disponibile la controlla l’1% della popolazione», allora quello che definiamo “mercato” rigetterà «ciò che loro, e nessun altro», non considerano utile o importante. Peggio ancora: chi fa lavori “stupidi” se ne rende perfettamente conto. «Credo di non aver mai conosciuto un avvocato aziendale che non pensasse di fare un lavoro stupido».Lo stesso vale per quasi tutte le nuove industrie: «Esiste un’intera classe di lavoratori salariati che, se li incontri a una festa e ammetti di fare un mestiere considerato interessante (l’antropologo, per esempio), si rifiuta anche soltanto di dirti che lavoro fa. Fategli bere due o tre drink, e si lanceranno in vere e proprie tirate su quanto inutile e stupido sia in realtà il loro lavoro», continua Graeber. «Stiamo parlando di una violenza psicologica profonda. Come si può anche solo cominciare a parlare di dignità del lavoro, quando in cuor suo una persona ritiene che il proprio lavoro non debba esistere?». Tuttavia, «il talento tutto particolare della nostra società» sta nel fatto che i suoi governanti hanno escogitato un modo per garantire che la frustrazione e la rabbia vengano indirizzate contro chi invece fa un lavoro sensato. Strana regola: «Più il lavoro di un individuo giova palesemente ad altre persone, minori sono le probabilità che questo lavoro venga pagato».Si domanda Graeber: che succederebbe se quest’intera classe di persone scomparisse? «Dite quel che volete di infermieri, spazzini e meccanici: è palese che, se dovessero sparire in una nuvola di fumo, gli effetti sarebbero immediati e catastrofici. Un mondo senza insegnanti e scaricatori di porto finirebbe presto nei guai, e anche un mondo senza scrittori di fantascienza o musicisti ska sarebbe evidentemente peggiore». Al contrario, «non è del tutto chiaro in che modo l’umanità soffrirebbe se dovessero svanire allo stesso modo tutti gli amministratori delegati di società d’investimenti, i lobbisti, gli addetti alle pubbliche relazioni, gli analisti assicurativi, i lavoratori del telemarketing, gli ufficiali giudiziari o i consulenti legali (molti sospettano che potrebbe significativamente migliorare)». Eppure, fatta salva una manciata di stimatissime eccezioni, come ad esempio i medici, «la regola resiste sorprendentemente bene». E, «cosa ancor più perversa, sembra circolare la diffusa convinzione che sia giusto così».Questo, aggiunge Graeber, è «uno dei punti di forza segreti dei populisti di destra», quelli che «fomentano il rancore contro i dipendenti della metropolitana che paralizzano Londra per il rinnovo del contratto», perché «il fatto stesso che i dipendenti della metropolitana siano in grado di paralizzare Londra è la riprova che il loro lavoro è necessario, ma a infastidire la gente sembra sia proprio questo». Cosa ancora più evidente negli Stati Uniti, dove i repubblicani «stanno riuscendo con molto successo a mobilitare il risentimento contro gli insegnanti o contro gli operai dell’industria dell’automobile», a causa di stipendi e benefit che sembrano eccessivi. È come se gli stessero dicendo: voi, che a quanto pare fate lavori veri, necessari, avete anche la faccia tosta di aspettarvi delle pensioni e un’assistenza sanitaria da classe media?«Se qualcuno avesse progettato un sistema del lavoro fatto su misura per salvaguardare il potere del capitale, non avrebbe potuto riuscirci meglio», conclude Graeber. «I lavoratori veri, quelli produttivi, vengono spremuti e sfruttati implacabilmente», mentre gli altri «si dividono tra un atterrito strato di disoccupati, disprezzato da tutti, e un più ampio strato di persone che in pratica vengono pagate per non fare nulla». Queste persone «ricoprono incarichi progettati per farle identificare con i punti di vista e le sensibilità della classe dirigente (manager, amministratori)», ma al tempo stesso «covano un segreto rancore nei confronti di chiunque faccia un lavoro provvisto di un chiaro e innegabile valore sociale». Non è un sistema progettato in modo conscio, è emerso da quasi un secolo di tentativi empirici. «Ma è anche l’unica spiegazione del perché, nonostante le nostre capacità tecnologiche, non lavoriamo tutti quanti solo tre o quattro ore al giorno».Nel lontano 1930, John Maynard Keynes prevedeva che entro la fine del secolo la tecnologia in Occidente sarebbe progredita al punto di regalarci una settimana lavorativa di appena 15 ore. Invece, è accaduto il contrario: «La tecnologia è stata arruolata per inventare nuovi modi di farci lavorare tutti di più», scrive l’antropologo David Graeber. E a tale scopo «sono stati creati lavori che sono di fatto inutili». Enormi schiere di persone, in Europa e Nord America, lavorano in ufficio, dove «trascorrono tutta la loro vita professionale eseguendo compiti che segretamente ritengono inutili». Graeber parla di «danni morali e spirituali», praticamente «una cicatrice sulla nostra coscienza collettiva», anche se non ne parla nessuno. Perché l’utopia promessa da Keynes non si è mai materializzata? «La spiegazione standard è che Keynes non aveva preventivato la mole dell’incremento del consumismo», ma per l’antropologo la verità è un’altra: l’élite capitalista sa benissimo che, una volta liberate dall’incombenza del lavoro full time, le masse cominciano a “pensare”, e a reclamare diritti per una vita diversa, specie se le macchine faticano al posto dell’uomo.
-
Missione compiuta, l’Italia muore: la catastrofe in cifre
 Un paese in ginocchio, mutilato, raso al suolo dalla crisi inasprita dall’euro e dal regime di austerity imposto da Bruxelles per mantenere in vita la moneta unica. L’Italia sta letteralmente andando a pezzi: tutti se ne accorgono ogni giorno, mentre la disoccupazione dilaga, i consumi crollano, i negozi chiudono e le aziende licenziano. Ma il panorama si fa ancora più impressionante se si osservano, tutti insieme, i numeri della catastrofe. E’ quello che ha fatto il blog “Sollevazione”, pescando tutte le cifre ufficiali degli indicatori-chiave. Un bollettino di guerra, voce per voce. Produzione e ricchezza, industria e redditi, debito e risparmi. L’Italia in rosso, che sta precipando lontano dalla sua storia, senza neppure capire perché. Ognuno combatte, da solo, contro continui rovesci: non ci sono spiragli, non c’è alcuna “ripresa” nemmeno all’orizzonte. Ma nessuno racconta davvero l’assedio del panico, la paura sciorinata dai “crudi numeri”, che forse non fotograno «le dimensioni effettive del disastro economico e sociale che vive l’Italia», però «ci aiutano a comprenderlo».Secondo gli analisti di “Sollevazione”, la resa matematica dell’Italia rivelata dai conti – la lingua spietata del pallottoliere – permette anche di «capire come le politiche austeritarie per tenere in piedi l’euro, il sistema bancocratico e il capitalismo-casinò, abbiano affossato il nostro paese», il cui Pil ha perso 8,7 punti percentuali a partire dal 2007, inclusa la manipolazione dello spread che ha “armato” la gigantesca manomissione operata da Monti e Fornero, con la loro “spending review” e la riforma-suicidio delle pensioni. Un’agenda peraltro proseguita da Letta: tagliare la spesa, ben sapendo che il “risparmio” dello Stato manda in crisi il settore privato, facendo calare il gettito fiscale e quindi esplodere il debito pubblico. Matteo Renzi? Niente di nuovo: neoliberismo puro, a cominciare dal Jobs Act per precarizzare ulteriormente il lavoro. Aggravanti: la neutralizzazione delle ultime difese sociali garantite dalla Costituzione, come vuole l’élite finanziaria, e l’eliminazione fisica dell’opposizione attraverso una legge elettorale come l’Italicum, definita peggiore – per le sue restrizioni – di quella che permise a Mussolini di consolidare il neonato regime fascista.Tutto questo, mentre il paese soccombe ogni giorno: in sei anni, il Pil pro capite è calato di 9 punti (di 10, invece, il reddito reale disponibile per le famiglie). Stesse percentuali per la frana della ricchezza nazionale: -9% dal 2007 al 2013, pari a 843 miliardi di euro. C’era una volta l’Italia: nello stesso periodo, la produzione industriale è crollata addirittura del 25,5%. Sta andando in frantumi, grazie alla politica imposta da Berlino, il maggior competitore europeo della Germania. Tra il 2001 e in 2013, l’Italia ha perso 120.000 fabbriche. Sono cifre da scenario bellico, e non sono riguardano solo l’industria: ci sono anche le 75.000 imprese artigiane costrette a chiudere. Anno record per il fallimenti, l’infame 2013 delle “larghe intese”: qualcosa come 111.000 fallimenti, in appena dodici mesi. Contraccolpo catastrofico, la disoccupazione: dal 2001, con l’ingresso nell’Eurozona, l’industria italiana ha perso un milione e 160.000 posti di lavoro. Colpa anche dell’assenza di credito: nonostante ricevano denaro dalla Bce a tassi «prossimi allo zero», le banche continuano a finanziare le imprese con prestiti al 4,49%, mentre negli altri paesi dell’Eurozona l’interesse medio è al 3,8%.Anche così il lavoro si estingue alla velocità della luce. Dal 2007, la piaga della disoccupazione è più che raddoppiata: dal 6,1% al 12,7 attuale. «I disoccupati ufficiali sono 3 milioni e 300.000», rileva “Sollevazione”, ai quali vanno però aggiunti «altri 3 milioni di persone», che ormai non si rivolgono neppure più ai centri per l’impiego: i cosiddetti “sfiduciati” fanno salire a quasi 6 milioni e mezzo il totale dei disoccupati italiani, proprio mentre la Germania del super-export vede salire ai massimi storici la quota degli occupati. C’è anche il trucco, naturalmente: un tedesco su quattro accetta i mini-job da 450 euro al mese. E’ la strada aperta in Italia dal Jobs Act di Renzi, di fronte a una platea oceanica di giovani senza lavoro: il 43%, più del doppio dei ragazzi disoccupati nel 2007. Sta male, comunque, la stragrande maggioranza dei salari italiani: «Con uno stipendio netto di 21.374 dollari l’anno, l’Italia si colloca al 23esimo posto nella classifica Ocse: se la passano peggio solo i portoghesi e gli abitanti dei paesi dell’Europa orientale». A valanga, la mancanza di impiego si traduce in forte calo dei consumi familiari, tagliati di quasi il 10% solo negli ultimi due anni. A farne le spese è anche il risparmio, continuamente eroso per far fronte all’emergenza economica, mentre la super-tassazione disposta dall’Ue ha raggiunto per l’Italia il 44% del Pil.«Se si considera il periodo tra il 2011 e il 2012 – precisa “Sollevazione” – soltanto l’Ungheria, in Unione Europea, ha conosciuto un aumento delle tasse rispetto al Pil superiore a quello dell’Italia». E’ un circolo vizioso: imporre più tasse a chi già le paga, per tentare (inutilmente) di arginare il calo delle entrate, comunque – già oggi – superiori alla somma delle uscite: situazione che sarà ulteriormente aggravata dal Fiscal Compact e cronicizzata dall’inserimento del pareggio di bilancio nella Costituzione. In pratica, la fine dello Stato sociale e delle garanzie sui servizi vitali – scuola e sanità in primis, peraltro minacciate di privatizzazione forzata dal Ttip e dal Tisa, i trattati segreti euro-atlantici imposti dagli Usa, che Renzi preme per approvare in fretta. Cartina di tornasole di questa autentica catastrofe, il debito pubblico: era pari al 103,3% del Pil nel 2007, ma ha raggiunto il 132,9% nel 2013. «L’ultimo rilevamento di Bankitalia ci dice che il debito pubblico ha toccato a maggio 2014 un nuovo record storico: quota 2.166,3 miliardi, con un aumento di 20 miliardi sul mese precedente».Va in rosso il conto delle famiglie, nel paese che prima dell’avvento dell’euro era il più risparmiatore d’Europa: rispetto al Pil, dal 1998 al 2012 il debito privato delle imprese è passato dall’85 al 120%, quello delle banche dal 40 al 110%, quello delle famiglie dal 30 al 50%. Paradossalmente, osserva “Sollevazione”, «in questo periodo quello che è cresciuto meno è stato proprio il debito pubblico», mentre il debito aggregato – pubblico e privato – è letteralmente esploso, dal 275% ad oltre il 400%. Spaventose pure le sofferenze bancarie, cresciute di 100 miliardi dal 2007 al 2013, per un totale di 147,3 miliardi di euro. Ed ecco l’ultimo gradino della tragedia: la povertà. Un fantasma che mette paura: l’esercito dei nuovi poveri e il timore che crescano furti e rapine ha aumentato del 5,7% i denari lasciati in custodia alle banche, oltre 1,2 miliardi di euro. Secondo Eurostat, gli «individui a rischio povertà o esclusione sociale» nel 2008 erano in Italia il 25,3%, e sono diventati il 29,9% nel 2012. L’ Istat è ancora più preciso: «Un italiano su dieci è in povertà assoluta».Tra il 2012 e il 2013, spiega l’istituto di statistica, l’incidenza della povertà assoluta è aumentata dal 6,8 al 7,9%, coinvolgendo oltre 300.000 famiglie e 1 milione 206.000 persone in più rispetto all’anno precedente. «E’ povera, o quasi povera, una famiglia su cinque». Poi c’è la “povertà relativa”, quelle delle famiglie (sono quasi 3 milioni e mezzo) il cui portafoglio mensile è inferiore alla spesa media nazionale, 972 euro al mese. Sono famiglie che cercano di sopravvivere con meno di 800 euro al mese, che si riducono a meno di 750 nel Mezzogiorno, dove più evidenti sono le diseguaglianze che la “crisi” ha fatto esplodere. Nel 1992, l’Italia era un paese relativamente equilibrato: non c’era un abisso tra ricchi e poveri e la classe media era in ottima salute. Oggi, praticamente, è in via di estinzione e teme di sprofondare giorno per giorno verso la povertà. Nel 2013, l’Italia è risultato «il paese più diseguale dell’Unione Europea, dopo la Gran Bretagna». Solo che il Regno Unito non è ingabbiato dall’euro. Infatti, a Londra, economia e occupazione stanno decisamente meglio rispetto alla media dell’atroce Eurozona, di cui l’Italia – dopo la Grecia – è la vittima principale.
Un paese in ginocchio, mutilato, raso al suolo dalla crisi inasprita dall’euro e dal regime di austerity imposto da Bruxelles per mantenere in vita la moneta unica. L’Italia sta letteralmente andando a pezzi: tutti se ne accorgono ogni giorno, mentre la disoccupazione dilaga, i consumi crollano, i negozi chiudono e le aziende licenziano. Ma il panorama si fa ancora più impressionante se si osservano, tutti insieme, i numeri della catastrofe. E’ quello che ha fatto il blog “Sollevazione”, pescando tutte le cifre ufficiali degli indicatori-chiave. Un bollettino di guerra, voce per voce. Produzione e ricchezza, industria e redditi, debito e risparmi. L’Italia in rosso, che sta precipando lontano dalla sua storia, senza neppure capire perché. Ognuno combatte, da solo, contro continui rovesci: non ci sono spiragli, non c’è alcuna “ripresa” nemmeno all’orizzonte. Ma nessuno racconta davvero l’assedio del panico, la paura sciorinata dai “crudi numeri”, che forse non fotograno «le dimensioni effettive del disastro economico e sociale che vive l’Italia», però «ci aiutano a comprenderlo».Secondo gli analisti di “Sollevazione”, la resa matematica dell’Italia rivelata dai conti – la lingua spietata del pallottoliere – permette anche di «capire come le politiche austeritarie per tenere in piedi l’euro, il sistema bancocratico e il capitalismo-casinò, abbiano affossato il nostro paese», il cui Pil ha perso 8,7 punti percentuali a partire dal 2007, inclusa la manipolazione dello spread che ha “armato” la gigantesca manomissione operata da Monti e Fornero, con la loro “spending review” e la riforma-suicidio delle pensioni. Un’agenda peraltro proseguita da Letta: tagliare la spesa, ben sapendo che il “risparmio” dello Stato manda in crisi il settore privato, facendo calare il gettito fiscale e quindi esplodere il debito pubblico. Matteo Renzi? Niente di nuovo: neoliberismo puro, a cominciare dal Jobs Act per precarizzare ulteriormente il lavoro. Aggravanti: la neutralizzazione delle ultime difese sociali garantite dalla Costituzione, come vuole l’élite finanziaria, e l’eliminazione fisica dell’opposizione attraverso una legge elettorale come l’Italicum, definita peggiore – per le sue restrizioni – di quella che permise a Mussolini di consolidare il neonato regime fascista.Tutto questo, mentre il paese soccombe ogni giorno: in sei anni, il Pil pro capite è calato di 9 punti (di 10, invece, il reddito reale disponibile per le famiglie). Stesse percentuali per la frana della ricchezza nazionale: -9% dal 2007 al 2013, pari a 843 miliardi di euro. C’era una volta l’Italia: nello stesso periodo, la produzione industriale è crollata addirittura del 25,5%. Sta andando in frantumi, grazie alla politica imposta da Berlino, il maggior competitore europeo della Germania. Tra il 2001 e in 2013, l’Italia ha perso 120.000 fabbriche. Sono cifre da scenario bellico, e non sono riguardano solo l’industria: ci sono anche le 75.000 imprese artigiane costrette a chiudere. Anno record per il fallimenti, l’infame 2013 delle “larghe intese”: qualcosa come 111.000 fallimenti, in appena dodici mesi. Contraccolpo catastrofico, la disoccupazione: dal 2001, con l’ingresso nell’Eurozona, l’industria italiana ha perso un milione e 160.000 posti di lavoro. Colpa anche dell’assenza di credito: nonostante ricevano denaro dalla Bce a tassi «prossimi allo zero», le banche continuano a finanziare le imprese con prestiti al 4,49%, mentre negli altri paesi dell’Eurozona l’interesse medio è al 3,8%.Anche così il lavoro si estingue alla velocità della luce. Dal 2007, la piaga della disoccupazione è più che raddoppiata: dal 6,1% al 12,7 attuale. «I disoccupati ufficiali sono 3 milioni e 300.000», rileva “Sollevazione”, ai quali vanno però aggiunti «altri 3 milioni di persone», che ormai non si rivolgono neppure più ai centri per l’impiego: i cosiddetti “sfiduciati” fanno salire a quasi 6 milioni e mezzo il totale dei disoccupati italiani, proprio mentre la Germania del super-export vede salire ai massimi storici la quota degli occupati. C’è anche il trucco, naturalmente: un tedesco su quattro accetta i mini-job da 450 euro al mese. E’ la strada aperta in Italia dal Jobs Act di Renzi, di fronte a una platea oceanica di giovani senza lavoro: il 43%, più del doppio dei ragazzi disoccupati nel 2007. Sta male, comunque, la stragrande maggioranza dei salari italiani: «Con uno stipendio netto di 21.374 dollari l’anno, l’Italia si colloca al 23esimo posto nella classifica Ocse: se la passano peggio solo i portoghesi e gli abitanti dei paesi dell’Europa orientale». A valanga, la mancanza di impiego si traduce in forte calo dei consumi familiari, tagliati di quasi il 10% solo negli ultimi due anni. A farne le spese è anche il risparmio, continuamente eroso per far fronte all’emergenza economica, mentre la super-tassazione disposta dall’Ue ha raggiunto per l’Italia il 44% del Pil.«Se si considera il periodo tra il 2011 e il 2012 – precisa “Sollevazione” – soltanto l’Ungheria, in Unione Europea, ha conosciuto un aumento delle tasse rispetto al Pil superiore a quello dell’Italia». E’ un circolo vizioso: imporre più tasse a chi già le paga, per tentare (inutilmente) di arginare il calo delle entrate, comunque – già oggi – superiori alla somma delle uscite: situazione che sarà ulteriormente aggravata dal Fiscal Compact e cronicizzata dall’inserimento del pareggio di bilancio nella Costituzione. In pratica, la fine dello Stato sociale e delle garanzie sui servizi vitali – scuola e sanità in primis, peraltro minacciate di privatizzazione forzata dal Ttip e dal Tisa, i trattati segreti euro-atlantici imposti dagli Usa, che Renzi preme per approvare in fretta. Cartina di tornasole di questa autentica catastrofe, il debito pubblico: era pari al 103,3% del Pil nel 2007, ma ha raggiunto il 132,9% nel 2013. «L’ultimo rilevamento di Bankitalia ci dice che il debito pubblico ha toccato a maggio 2014 un nuovo record storico: quota 2.166,3 miliardi, con un aumento di 20 miliardi sul mese precedente».Va in rosso il conto delle famiglie, nel paese che prima dell’avvento dell’euro era il più risparmiatore d’Europa: rispetto al Pil, dal 1998 al 2012 il debito privato delle imprese è passato dall’85 al 120%, quello delle banche dal 40 al 110%, quello delle famiglie dal 30 al 50%. Paradossalmente, osserva “Sollevazione”, «in questo periodo quello che è cresciuto meno è stato proprio il debito pubblico», mentre il debito aggregato – pubblico e privato – è letteralmente esploso, dal 275% ad oltre il 400%. Spaventose pure le sofferenze bancarie, cresciute di 100 miliardi dal 2007 al 2013, per un totale di 147,3 miliardi di euro. Ed ecco l’ultimo gradino della tragedia: la povertà. Un fantasma che mette paura: l’esercito dei nuovi poveri e il timore che crescano furti e rapine ha aumentato del 5,7% i denari lasciati in custodia alle banche, oltre 1,2 miliardi di euro. Secondo Eurostat, gli «individui a rischio povertà o esclusione sociale» nel 2008 erano in Italia il 25,3%, e sono diventati il 29,9% nel 2012. L’ Istat è ancora più preciso: «Un italiano su dieci è in povertà assoluta».Tra il 2012 e il 2013, spiega l’istituto di statistica, l’incidenza della povertà assoluta è aumentata dal 6,8 al 7,9%, coinvolgendo oltre 300.000 famiglie e 1 milione 206.000 persone in più rispetto all’anno precedente. «E’ povera, o quasi povera, una famiglia su cinque». Poi c’è la “povertà relativa”, quelle delle famiglie (sono quasi 3 milioni e mezzo) il cui portafoglio mensile è inferiore alla spesa media nazionale, 972 euro al mese. Sono famiglie che cercano di sopravvivere con meno di 800 euro al mese, che si riducono a meno di 750 nel Mezzogiorno, dove più evidenti sono le diseguaglianze che la “crisi” ha fatto esplodere. Nel 1992, l’Italia era un paese relativamente equilibrato: non c’era un abisso tra ricchi e poveri e la classe media era in ottima salute. Oggi, praticamente, è in via di estinzione e teme di sprofondare giorno per giorno verso la povertà. Nel 2013, l’Italia è risultato «il paese più diseguale dell’Unione Europea, dopo la Gran Bretagna». Solo che il Regno Unito non è ingabbiato dall’euro. Infatti, a Londra, economia e occupazione stanno decisamente meglio rispetto alla media dell’atroce Eurozona, di cui l’Italia – dopo la Grecia – è la vittima principale.Un paese in ginocchio, mutilato, raso al suolo dalla crisi inasprita dall’euro e dal regime di austerity imposto da Bruxelles per mantenere in vita la moneta unica. L’Italia sta letteralmente andando a pezzi: tutti se ne accorgono ogni giorno, mentre la disoccupazione dilaga, i consumi crollano, i negozi chiudono e le aziende licenziano. Ma il panorama si fa ancora più impressionante se si osservano, tutti insieme, i numeri della catastrofe. E’ quello che ha fatto il blog “Sollevazione”, pescando tutte le cifre ufficiali degli indicatori-chiave. Un bollettino di guerra, voce per voce. Produzione e ricchezza, industria e redditi, debito e risparmi. L’Italia in rosso, che sta precipando lontano dalla sua storia, senza neppure capire perché. Ognuno combatte, da solo, contro continui rovesci: non ci sono spiragli, non c’è alcuna “ripresa” nemmeno all’orizzonte. Ma nessuno racconta davvero l’assedio del panico, la paura sciorinata dai “crudi numeri”, che forse non fotografano «le dimensioni effettive del disastro economico e sociale che vive l’Italia», però «ci aiutano a comprenderlo».
-
Meno democrazia: Renzi, il tecno-populista dell’élite
 L’Italia, paese di populisti e di populismi. Ne ha conosciuti ben tre (e mezzo), negli ultimi vent’anni, un record mondiale. Populismo: che è concetto classico della politica e della sociologia ma che tuttavia è un processo culturale prima che politico. E oggi economico prima che culturale e politico, nel senso che è appunto l’economia capitalista ad essere oggi un processo culturale prima che economico, producendo – prima delle merci e del denaro – le mappe concettuali, cognitive, relazionali, affettive necessarie per la navigazione nel mercato; trasformando quello che era il cittadino dell’illuminismo in lavoratore, merce, capitale umano – ovvero in mero homo oeconomicus. Tre populismi interi: Berlusconi, Grillo e Renzi. E il mezzo populismo della Lega. Tre padri politici invocati dal popolo perché lo sorreggano, lo portino da qualche parte, gli dicano cosa deve fare, perché questo stesso popolo si ritiene incapace (o non più desideroso) di assumersi la responsabilità di essere sovrano di se stesso.Effetto culturale, questo, dell’antipolitica capitalista, che per essere sovrano assoluto e culturalmente monopolista deve rimuovere ogni sovrano concorrente. Berlusconi: il populista che prometteva la modernizzazione neoliberale del paese. In realtà, un populismo del cambiare tutto per non cambiare nulla (soprattutto i suoi interessi personali e aziendali).Un populismo aziendalista, con la figura del padre/leader sostituita da quella dell’imprenditore che si è fatto da solo (o quasi), perfetta nell’esprimere il modello culturale che tutti dovevano apprendere: l’edonismo, il godimento immediato, la deresponsabilizzazione egoistica ed egotistica. Per legittimare – questa l’azione appunto culturale, pedagogica prima che economica – le retoriche neoliberiste dell’essere imprenditori di se stessi e della competizione come unica forma di vita.Bossi e la Lega: il mezzo populismo (non solo perché limitato a una parte del territorio), apparentemente il più classico dei populismi con il richiamo alla tradizione, ai simboli di terra e di sangue. All’essere padroni a casa nostra: da intendere però non come sovrani sulla nostra terra ma come padroni nel senso antico del capitalismo. Populismo da piccola impresa, da capitalismo molecolare come versione localistica dell’ordoliberalismo tedesco e della sua pedagogia per imporre il modello impresa all’intera società. Grillo: il populista contestatore, il teorico del net-populismo come forma perfetta della democrazia. Grillo come l’uomo del cambiamento ma incapace di cambiare (dice solo no) e forse populista anche di se stesso. E Matteo Renzi. Un populismo di tipo nuovo ma evoluzione dei precedenti. Perché anch’egli cerca il rapporto diretto con il popolo e lo invoca come propria totalizzante legittimazione. Perché aspira ad essere insieme Partito di Renzi e Partito della Nazione. Un partito-non-partito, tuttavia, ormai anch’esso trasversale – e quasi un non-luogo nel senso di Marc Augé: come un aeroporto, un supermercato, un luogo di consumo di politica.Un populismo che invoca il popolo contro le caste e il sindacato, salvando invece le oligarchie che lo sostengono come un sol uomo; che ha grandi mass-media schierati dalla sua parte e che gli consentono ciò che mai avrebbero consentito a Berlusconi; un populismo fideistico e teologico-politico (noi contro loro, noi il tutto che non accetta il due e il tre e il molteplice e gli eretici; noi il nuovo, gli altri il vecchio). Un populismo che vuole rottamare appunto il vecchio, ma che non rottama, non corregge (una volta si chiamava autocritica, ma il nuovo che avanza travolge anche la memoria) i molti errori del passato: il sì all’austerità, all’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Un populismo finalizzato alla modernizzazione dell’Italia – e ogni populismo è stato, storicamente, anche una via per la modernizzazione, facendo accettare al popolo, in nome del popolo, quelle trasformazioni che altrimenti non sarebbero state possibili per trasformare un paese e quel popolo. Per questo, quello di Renzi è un populismo tecnocratico: che produce quella modernizzazione neoliberista che Berlusconi non è riuscito a produrre e Grillo fatica a poter produrre.Un populismo nel nome della tecnocrazia, che la tecnocrazia ama; un populismo che trasforma (forse questa volta per davvero) il potere politico nel senso richiesto dalla tecnocrazia: meno democrazia (la riforma del Senato, le proposte di nuova legge elettorale); meno diritti sociali e quindi politici (diventati un costo); più decisionismo; meno partecipazione e più adattamento alla realtà immodificabile del mercato; meno cittadinanza attiva e più accettazione della ineluttabilità del reale. Perché le sue pratiche politiche – al di là delle apparenze e delle discussioni con Angela Merkel e di alcuni interventi comunque virtuosi – sono tutte dentro alla cultura della modernizzazione richiesta dall’ideologia neoliberista (flessibilità del lavoro, privatizzazioni, un nuovo modo di essere imprenditori di se stessi, riduzione ulteriore dello stato sociale, crescita invece di sviluppo, competizione invece di solidarietà); e la flessibilità sul Fiscal Compact (invece della sua abolizione, per evidente irrazionalità e surrealtà economica), pure invocata, è un pannicello caldo rispetto al nuovo new deal che sarebbe invece necessario (e urgente).Un populismo futurista, inoltre: nel nome della velocità, delle macchine, delle parole in libertà, dell’azione per l’azione. Il populismo di Renzi è dunque più di un classico neopopulismo, che ha dominato la scena per trent’anni coniugando populismo e neoliberismo, mercato e popolo, modernizzazione e impoverimento e disuguaglianze. E’ un neopopulismo tecnocratico – per altro discendenza diretta di quello neoliberista – che scardina ancor più di quello neoliberista le forme e le pratiche della democrazia; riduce a niente la società e la società civile; attacca il sindacato o lo rende inutile (in coerenza con le tecnocrazie globali); che spettacolarizza se stesso proponendosi come outsider, come rottura, come alternativa, in realtà portandoci nella società dello spettacolo della tecnocrazia. Una tecnocrazia che non si espone più direttamente con i noiosi e antipatici tecnici, ma con la fantasia e l’estro di un populismo mediatico e spettacolare, moderno e postmoderno insieme, dove twittare è più importante che ascoltare.(Lelio Demichelis, “Il populismo tecnocratico del rottamatore”, da “Sbilanciamoci” del 4 luglio 2014).
L’Italia, paese di populisti e di populismi. Ne ha conosciuti ben tre (e mezzo), negli ultimi vent’anni, un record mondiale. Populismo: che è concetto classico della politica e della sociologia ma che tuttavia è un processo culturale prima che politico. E oggi economico prima che culturale e politico, nel senso che è appunto l’economia capitalista ad essere oggi un processo culturale prima che economico, producendo – prima delle merci e del denaro – le mappe concettuali, cognitive, relazionali, affettive necessarie per la navigazione nel mercato; trasformando quello che era il cittadino dell’illuminismo in lavoratore, merce, capitale umano – ovvero in mero homo oeconomicus. Tre populismi interi: Berlusconi, Grillo e Renzi. E il mezzo populismo della Lega. Tre padri politici invocati dal popolo perché lo sorreggano, lo portino da qualche parte, gli dicano cosa deve fare, perché questo stesso popolo si ritiene incapace (o non più desideroso) di assumersi la responsabilità di essere sovrano di se stesso.Effetto culturale, questo, dell’antipolitica capitalista, che per essere sovrano assoluto e culturalmente monopolista deve rimuovere ogni sovrano concorrente. Berlusconi: il populista che prometteva la modernizzazione neoliberale del paese. In realtà, un populismo del cambiare tutto per non cambiare nulla (soprattutto i suoi interessi personali e aziendali).Un populismo aziendalista, con la figura del padre/leader sostituita da quella dell’imprenditore che si è fatto da solo (o quasi), perfetta nell’esprimere il modello culturale che tutti dovevano apprendere: l’edonismo, il godimento immediato, la deresponsabilizzazione egoistica ed egotistica. Per legittimare – questa l’azione appunto culturale, pedagogica prima che economica – le retoriche neoliberiste dell’essere imprenditori di se stessi e della competizione come unica forma di vita.Bossi e la Lega: il mezzo populismo (non solo perché limitato a una parte del territorio), apparentemente il più classico dei populismi con il richiamo alla tradizione, ai simboli di terra e di sangue. All’essere padroni a casa nostra: da intendere però non come sovrani sulla nostra terra ma come padroni nel senso antico del capitalismo. Populismo da piccola impresa, da capitalismo molecolare come versione localistica dell’ordoliberalismo tedesco e della sua pedagogia per imporre il modello impresa all’intera società. Grillo: il populista contestatore, il teorico del net-populismo come forma perfetta della democrazia. Grillo come l’uomo del cambiamento ma incapace di cambiare (dice solo no) e forse populista anche di se stesso. E Matteo Renzi. Un populismo di tipo nuovo ma evoluzione dei precedenti. Perché anch’egli cerca il rapporto diretto con il popolo e lo invoca come propria totalizzante legittimazione. Perché aspira ad essere insieme Partito di Renzi e Partito della Nazione. Un partito-non-partito, tuttavia, ormai anch’esso trasversale – e quasi un non-luogo nel senso di Marc Augé: come un aeroporto, un supermercato, un luogo di consumo di politica.Un populismo che invoca il popolo contro le caste e il sindacato, salvando invece le oligarchie che lo sostengono come un sol uomo; che ha grandi mass-media schierati dalla sua parte e che gli consentono ciò che mai avrebbero consentito a Berlusconi; un populismo fideistico e teologico-politico (noi contro loro, noi il tutto che non accetta il due e il tre e il molteplice e gli eretici; noi il nuovo, gli altri il vecchio). Un populismo che vuole rottamare appunto il vecchio, ma che non rottama, non corregge (una volta si chiamava autocritica, ma il nuovo che avanza travolge anche la memoria) i molti errori del passato: il sì all’austerità, all’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Un populismo finalizzato alla modernizzazione dell’Italia – e ogni populismo è stato, storicamente, anche una via per la modernizzazione, facendo accettare al popolo, in nome del popolo, quelle trasformazioni che altrimenti non sarebbero state possibili per trasformare un paese e quel popolo. Per questo, quello di Renzi è un populismo tecnocratico: che produce quella modernizzazione neoliberista che Berlusconi non è riuscito a produrre e Grillo fatica a poter produrre.Un populismo nel nome della tecnocrazia, che la tecnocrazia ama; un populismo che trasforma (forse questa volta per davvero) il potere politico nel senso richiesto dalla tecnocrazia: meno democrazia (la riforma del Senato, le proposte di nuova legge elettorale); meno diritti sociali e quindi politici (diventati un costo); più decisionismo; meno partecipazione e più adattamento alla realtà immodificabile del mercato; meno cittadinanza attiva e più accettazione della ineluttabilità del reale. Perché le sue pratiche politiche – al di là delle apparenze e delle discussioni con Angela Merkel e di alcuni interventi comunque virtuosi – sono tutte dentro alla cultura della modernizzazione richiesta dall’ideologia neoliberista (flessibilità del lavoro, privatizzazioni, un nuovo modo di essere imprenditori di se stessi, riduzione ulteriore dello stato sociale, crescita invece di sviluppo, competizione invece di solidarietà); e la flessibilità sul Fiscal Compact (invece della sua abolizione, per evidente irrazionalità e surrealtà economica), pure invocata, è un pannicello caldo rispetto al nuovo new deal che sarebbe invece necessario (e urgente).Un populismo futurista, inoltre: nel nome della velocità, delle macchine, delle parole in libertà, dell’azione per l’azione. Il populismo di Renzi è dunque più di un classico neopopulismo, che ha dominato la scena per trent’anni coniugando populismo e neoliberismo, mercato e popolo, modernizzazione e impoverimento e disuguaglianze. E’ un neopopulismo tecnocratico – per altro discendenza diretta di quello neoliberista – che scardina ancor più di quello neoliberista le forme e le pratiche della democrazia; riduce a niente la società e la società civile; attacca il sindacato o lo rende inutile (in coerenza con le tecnocrazie globali); che spettacolarizza se stesso proponendosi come outsider, come rottura, come alternativa, in realtà portandoci nella società dello spettacolo della tecnocrazia. Una tecnocrazia che non si espone più direttamente con i noiosi e antipatici tecnici, ma con la fantasia e l’estro di un populismo mediatico e spettacolare, moderno e postmoderno insieme, dove twittare è più importante che ascoltare.(Lelio Demichelis, “Il populismo tecnocratico del rottamatore”, da “Sbilanciamoci” del 4 luglio 2014).L’Italia, paese di populisti e di populismi. Ne ha conosciuti ben tre (e mezzo), negli ultimi vent’anni, un record mondiale. Populismo: che è concetto classico della politica e della sociologia ma che tuttavia è un processo culturale prima che politico. E oggi economico prima che culturale e politico, nel senso che è appunto l’economia capitalista ad essere oggi un processo culturale prima che economico, producendo – prima delle merci e del denaro – le mappe concettuali, cognitive, relazionali, affettive necessarie per la navigazione nel mercato; trasformando quello che era il cittadino dell’illuminismo in lavoratore, merce, capitale umano – ovvero in mero homo oeconomicus. Tre populismi interi: Berlusconi, Grillo e Renzi. E il mezzo populismo della Lega. Tre padri politici invocati dal popolo perché lo sorreggano, lo portino da qualche parte, gli dicano cosa deve fare, perché questo stesso popolo si ritiene incapace (o non più desideroso) di assumersi la responsabilità di essere sovrano di se stesso.
-
Temo una rivolta, perché guadagno mille volte più di voi
 «Probabilmente non mi conoscete, ma come voi sono uno degli 0,1%, un fiero capitalista. Ho fondato, co-fondato e finanziato più di 30 società di ogni genere, da cose piccole come il night club con cui ho cominciato a vent’anni, a giganti come Amazon.com di cui sono stato il primo investitore esterno. Poi ho fondato aQuantitative, una società di pubblicità su Internet che nel 2007 è stata venduta a Microsoft per 6,4 miliardi di dollari. In contanti. Insieme ad amici possediamo una nostra banca. Racconto tutto questo per dimostrarvi che per molti versi non sono molto diverso da voi. Come voi ho una visione ampia degli affari e del capitalismo. E come voi sono stato oscenamente ricompensato per il mio successo, con una vita che gli altri 99,9% di americani non possono nemmeno immaginare. Molteplici case, aereo personale, ecc». Comincia così una sorprendente lettera aperta, pubblicata qualche giorno fa dal sofisticato “Politico.com” e rilanciata da siti di economia & politica come “Business Insider” e “Zero Hedge”, ogni volta con un gran numero di lettori e apprezzamenti.Una lettera che è anche una analisi/denuncia del livello estremo raggiunto dalla disuguaglianza nell’odierno capitalismo. E un avviso: così non può continuare. Arriveranno i forconi, contro di noi. Nick Hanauer, 55 anni, nonni immigrati dalla Germania di Hitler, è un classico uomo d’affari americano, uno che si è fatto da sé. Americano anche nel piglio con cui si esprime. «Nel 1992 a Seattle vendevo cuscini fabbricati dall’impresa della mia famiglia a negozi in giro per il paese e Internet era una goffa novità alla quale ci si collegava a 300 baud. Ma già allora mi sono accorto abbastanza rapidamente che molti grandi magazzini miei clienti erano condannati. Ho capito che non appena Internet fosse diventata abbastanza veloce e affidabile – e quel tempo non era così lontano – tutti si sarebbero buttati a comprare on line come pazzi. Realizzare questo, vedere oltre l’orizzonte un po’ più in fretta di tanti altri, è stata la parte strategica del mio successo. La parte fortunata è stata invece l’avere un paio di amici, entrambi di grande talento, anche loro intrigati dalle potenzialità della rete. Uno è un tizio di cui non avrete certo sentito parlare, Jeff Tauber, l’altro era Jeff Bezos (il fondatore di Amazon ndr). Ero così eccitato dal potenziale del web che ho detto ai due Jeff che volevo investire in qualsiasi cosa avessero deciso di lanciare».«Il secondo Jeff – Bezos – mi chiamò per primo, e lo aiutai a sottoscrivere la sua piccola libreria start up. L’altro Jeff partì con un negozio on line chiamato Cybershop, ma quando la fiducia nelle vendite via Internet era ancora bassa; era troppo presto per la sua idea, la gente non era ancora pronta ad acquistare on line cose costose senza vederle di persona (a differenza di oggetti semplici come i libri, la cui qualità non cambia – questa è stata la carta vincente di Bezos). Cybershop non è andato lontano, è stato uno dei tanti fallimenti di imprese dot-com. Amazon è andato meglio. E io ora possiedo un maxi-yacht. Ma lasciatemi essere franco. Non sono la persona più intelligente che avete conosciuto, o quello capace di lavorare più sodo. Ero uno studente mediocre, non sono un tecnico – non so ho mai saputo scrivere una riga di software. Quel che mi è servito, credo, è una certa propensione al rischio e un’intuizione su quel che accadrà in futuro. Intuire dove le cose stanno andando è l’essenza dell’imprenditorialità. E cosa vedo oggi nel nostro futuro? Vedo dei forconi».«Mentre persone come voi e me prosperano oltre i sogni di ogni plutocrate nella storia, il resto del paese – il 99,9% – resta molto indietro e arretra. Il divario fra quelli che hanno e quelli che non hanno peggiora sempre di più. Nel 1980 l’1% in cima alla piramide controllava l’8% del reddito nazionale degli Stati Uniti. Il 50% più in basso si divideva il 18% delle ricchezze. Oggi l’1% più ricco si divide il 20%, e il 50% della popolazione solo il 12%. Ma il problema non è la disuguaglianza in sé, qualche misura è intrinseca a ogni economia capitalista che funzioni. Il problema è che la disuguaglianza è a livelli storicamente mai visti e peggiora di giorno in giorno. Il nostro paese sta diventando una società sempre meno capitalista e sempre più una società feudale. A meno che le nostre politiche non cambino drammaticamente, la classe media scomparirà, e torneremo indietro alla Francia del 18° secolo. Prima della Rivoluzione. Così ho un messaggio per i miei colleghi oscenamente ricchi, per tutti coloro che vivono nelle bolle dei nostri mondi circondati da cancellate: svegliatevi, gente. Non durerà. Se non si fa qualcosa per sanare le clamorose diseguaglianze in questa economia, i forconi ci saranno addosso».«Nessuna società può tollerare una tale disparità. Non ci sono esempi nella storia in cui si sia verificata una tale accumulazione di ricchezza e i forconi non siano arrivati. Dove c’è una società altamente disuguale o c’è uno Stato di polizia, o un’insurrezione. Non ci sono altre possibilità. Il punto non è se, ma quando. Molti di voi pensano che siamo speciali perché “questa è l’America”, pensiamo di essere immuni alla forze che hanno dato vita alla Primavera Araba o alle Rivoluzioni in Francia e in Russia. Molti fra i colleghi dello 0,1% sfuggono questo argomento, molti mi prendono per matto, altri vedono un ragazzino povero con un iPhone e pensano che l’ineguaglianza sia una finzione. Vivete nel mondo dei sogni, vi dico. Volete credere che se ci sarà qualche segnale di destabilizzazione, ci sarà tempo per reagire e organizzarsi. Ma non funziona così, come sa qualsiasi studente di storia. Le rivoluzioni, come le bancarotte, si manifestano per gradi e poi precipitano di colpo. Un giorno uno si dà fuoco e improvvisamente la gente è in strada, prima che ci si renda conto il paese brucia. E non c’è tempo per salire sul nostro Gulfstream e scappare in Nuova Zelanda. Succede così. E se l’ineguaglianza peggiorerà, succederà».Sembrano le parole dei ragazzi di “Occupy Wall Street”, movimento che pare scomparso nel nulla. Ma il nostro capitalista niente affatto pentito non parla così per paura quanto per interesse. Del paese, della società, ma anche degli stessi ultraricchi dello 0,1%, a quanto cerca di dimostrare nell’analisi che segue. La cui tesi si può riassumere nel titolo dato al post da “Business Insider” (foto di persone in fila negli anni ’30 della Grande Depressione): “Spiacenti, gente, ma i ricchi non creano occupazione”. Hanauer se la prende con il punto di vista “ortodosso” dell’economia politica, e ne smonta alcuni presupposti di fondo: «Sono i ricchi che creano occupazione? Falso. E’ come dire che il seme crea l’albero: magari ne è il presupposto, ma provate a piantare un seme su Marte o nel Sahara. Senza terra buona, acqua, nutrienti non spunterà nulla e il seme morirà. La retorica per cui l’America è grande per via di uomini come me e Steve Jobs è finzione. Se entrambi fossimo nati in Somalia o in Congo saremmo rimasti a vendere frutta all’angolo della strada».L’economia non è un’astrazione, ma un ecosistema complesso di persone reali fra loro interdipendenti. Se i lavoratori hanno più denaro, le imprese hanno più clienti e hanno bisogno di più impiegati. A creare posti di lavoro in ultima istanza sono i clienti, i consumatori, vale a dire la classe media. Non sono i ricchi, come vuole uno dei luoghi comuni dell’economia ortodossa, non sono gli imprenditori, che pure sono una parte importante del processo. La classe media è stata la causa, non la conseguenza, della prosperità goduta nel passato dagli Usa. Alzare il salario minimo costa posti di lavoro, per la legge della domanda e dell’offerta? Falso. Lo aveva ben capito Henry Ford che nel 1914 raddoppiò la paga ai suoi operai (a 5 dollari al giorno, equivalenti a 120 di oggi) affinché potessero permettersi di comprare le auto che producevano. Lo ha capito la città di Seattle, che ha alzato per legge il salario minimo a 15 dollari l’ora da 9 – che era già il 30% in più della media Usa. Risultato: Seattle è con San Francisco la città col tasso di occupazione più alto negli Usa, ed è in assoluto la città che cresce di più.Il problema con la nostra economia – chiosa “Business Insider” – è che quella che una volta era la nostra potente classe media è stata lasciata impoverire da decenni di tagli ai costi e salari stagnanti, e oggi porta a casa una quota molto minore di 30 anni fa, mentre gente come Hanauer e i suoi amici dell’1% si accaparravano fette sempre maggiori di ricchezza, anche dopo la crisi del 2008. Dal 2009 al 2012 il 95% dei guadagni è andato all’1% mentre il 99% è rimasto al palo. Negli ultimi tre decenni i compensi per i Ceo (amministratori delegati, direttori generali, alti dirigenti) sono cresciuti 127 volte più rapidamente di quelli di altre categorie. Dal 1950 il rapporto tra la paga di un Ceo e quella di un lavoratore è aumentato del 1.000%: i Ceo guadagnavano 30 volte il salario medio, oggi il loro stipendio vale 500 volte il secondo. E nessuno ha eliminato i propri alti dirigenti senior, li ha esternalizzati in Cina o ha automatizzato il loro lavoro. Al contrario, ce ne sono molti più di prima.Intanto la classe media veniva falcidiata da politiche fiscali favorevoli all’1%, dalla globalizzazione e da miglioramenti tecnologici senza controlli. Ma veniva strozzata anche dalla nostra ossessione per il profitto a breve termine, dall’ethos prevalente nel mondo degli affari per cui gli impiegati sono visti come “un costo” e le società tengono i loro salari più bassi possibile. E’ un bene per l’economia che i ricchi siano sempre più ricchi? Falso. Il punto è che la classe media spende quasi tutto quello che guadagna, e questa spesa diventa ricavo per società avviate, finanziate o possedute da persone come Hanauer. Ma oggi, con i salari bassi come mai grazie all’avidità e alle corte vedute dell’1%, la classe media non è più in grado di farlo, e ciò si ritorce contro l’economia reale e gli stessi imprenditori. In America infatti i più ricchi – imprenditori, investitori e società – oggi hanno così tanto denaro da non riuscire a spenderlo. Così, invece di ri-pomparlo nell’economia creando guadagni e salari, quel denaro resta in conti di investimento.«Io guadagno all’anno 1.000 volte l’americano medio, ma non compro mille volte più roba. La mia famiglia negli ultimi anni ha comprato tre automobili, non 3.000. Io ho acquistato qualche paio di pantaloni e qualche camicia all’anno, come molti altri americani. Ho comprato due paia dei migliori pantaloni di lana, quelli che il mio partner Mike chiama “pantaloni da manager”. Ma non avrei potuto acquistarne 1.000. Invece ho messo via il mio denaro extra là dove non fa molto bene al paese». Se i 9 milioni di dollari di Hanauer in più dei 10 milioni di guadagni annuali fossero andati a 9.000 famiglie invece che a lui, sarebbero stati pompati di nuovo nell’economia attraverso il consumo. E avrebbero creato più occupazione. Invece stanno nei conti bancari di Hanauer o investiti in società che non hanno abbastanza clienti potenziali a cui vendere. Hanauer stima che se la maggior parte delle famiglie americane portasse a casa la stessa quota di reddito nazionale di 30 anni fa, ogni famiglia avrebbe altri 10.000 dollari di reddito da spendere.Con famiglie più ricche, lo Stato potrebbe davvero diventare più snello, risparmiando su assistenza pubblica, cure mediche gratuite, buoni pasto (oggi fruiti da 44 milioni di cittadini). E anche i più ricchi se ne gioverebbero. Il messaggio finale: «Cari 1%, molti dei nostri compatrioti cominciano a credere che il problema sia il capitalismo in sé. Non sono d’accordo, e credo non lo siate neppure voi. Ma il capitalismo lasciato senza controlli tende alla concentrazione e al collasso. Ecco perché gli investimenti nella classe media funzionano, e i tagli delle tasse ai ricchi invece no. Bilanciare il potere dei lavoratori con quello dei miliardari alzando il salario minimo non è male per il capitalismo, è uno strumento indispensabile per rendere il capitalismo stabile e sostenibile», conclude Hanauer (all’inizio invero esortava a prendere esempio dalle riforme di Franklyn Delano Roosevelt, un po’ più ampie di così). «O possiamo star seduti, non fare nulla e goderci i nostri yacht. Aspettando i forconi».L’analisi di Hanauer riguarda anche l’Italia? Sì, per tre motivi. Perché le disuguaglianze ci sono anche da noi, sia pure meno accentuate che negli Usa; perché le tendenze in America si riflettono altrove, a cominciare dall’Europa; perché, al di là delle riforme indispensabili al nostro paese fermo da decenni, l’economia italiana fa parte del sistema economico globale. Un sistema che fra debiti enormi e disoccupazione vertiginosa non sta affatto bene, come oggi ricorda la Banca dei Regolamenti Internazionali, mentre un rapporto della Banca Mondiale invita esplicitamente a prepararsi per la prossima crisi. Hanauer parla sicuramente nell’interesse dell’economia reale, dei cittadini e delle imprese piccole e medie. Ma alle banche e alle grandi corporations i luoghi comuni dell’ortodossia vanno benissimo. Finanza e multinazionali, compresi i costruttori di armamenti, i colossi dell’high-tech, i giganti della farmaceutica o del web hanno clienti globali, si tratti dell’1% del pianeta (dove addirittura 85 iper-ricchi – non 8.500, né 850, proprio 85 – detengono tanta ricchezza quanta ne possiede la metà della popolazione della Terra) o della classe media che a livello planetario comunque emerge fra varie contraddizioni. E multinazionali e banche & finanza hanno anche le lobby più potenti capaci di “convincere” i politici a fare leggi e norme a loro più favorevoli. Non resta che attendere i forconi, allora, o aspettare la prossima crisi?(Maria Grazia Bruzzone, “Svegliatevi plutocrati, i forconi ci saranno addosso”, da “La Stampa” del 4 luglio 2014).
«Probabilmente non mi conoscete, ma come voi sono uno degli 0,1%, un fiero capitalista. Ho fondato, co-fondato e finanziato più di 30 società di ogni genere, da cose piccole come il night club con cui ho cominciato a vent’anni, a giganti come Amazon.com di cui sono stato il primo investitore esterno. Poi ho fondato aQuantitative, una società di pubblicità su Internet che nel 2007 è stata venduta a Microsoft per 6,4 miliardi di dollari. In contanti. Insieme ad amici possediamo una nostra banca. Racconto tutto questo per dimostrarvi che per molti versi non sono molto diverso da voi. Come voi ho una visione ampia degli affari e del capitalismo. E come voi sono stato oscenamente ricompensato per il mio successo, con una vita che gli altri 99,9% di americani non possono nemmeno immaginare. Molteplici case, aereo personale, ecc». Comincia così una sorprendente lettera aperta, pubblicata qualche giorno fa dal sofisticato “Politico.com” e rilanciata da siti di economia & politica come “Business Insider” e “Zero Hedge”, ogni volta con un gran numero di lettori e apprezzamenti.Una lettera che è anche una analisi/denuncia del livello estremo raggiunto dalla disuguaglianza nell’odierno capitalismo. E un avviso: così non può continuare. Arriveranno i forconi, contro di noi. Nick Hanauer, 55 anni, nonni immigrati dalla Germania di Hitler, è un classico uomo d’affari americano, uno che si è fatto da sé. Americano anche nel piglio con cui si esprime. «Nel 1992 a Seattle vendevo cuscini fabbricati dall’impresa della mia famiglia a negozi in giro per il paese e Internet era una goffa novità alla quale ci si collegava a 300 baud. Ma già allora mi sono accorto abbastanza rapidamente che molti grandi magazzini miei clienti erano condannati. Ho capito che non appena Internet fosse diventata abbastanza veloce e affidabile – e quel tempo non era così lontano – tutti si sarebbero buttati a comprare on line come pazzi. Realizzare questo, vedere oltre l’orizzonte un po’ più in fretta di tanti altri, è stata la parte strategica del mio successo. La parte fortunata è stata invece l’avere un paio di amici, entrambi di grande talento, anche loro intrigati dalle potenzialità della rete. Uno è un tizio di cui non avrete certo sentito parlare, Jeff Tauber, l’altro era Jeff Bezos (il fondatore di Amazon ndr). Ero così eccitato dal potenziale del web che ho detto ai due Jeff che volevo investire in qualsiasi cosa avessero deciso di lanciare».«Il secondo Jeff – Bezos – mi chiamò per primo, e lo aiutai a sottoscrivere la sua piccola libreria start up. L’altro Jeff partì con un negozio on line chiamato Cybershop, ma quando la fiducia nelle vendite via Internet era ancora bassa; era troppo presto per la sua idea, la gente non era ancora pronta ad acquistare on line cose costose senza vederle di persona (a differenza di oggetti semplici come i libri, la cui qualità non cambia – questa è stata la carta vincente di Bezos). Cybershop non è andato lontano, è stato uno dei tanti fallimenti di imprese dot-com. Amazon è andato meglio. E io ora possiedo un maxi-yacht. Ma lasciatemi essere franco. Non sono la persona più intelligente che avete conosciuto, o quello capace di lavorare più sodo. Ero uno studente mediocre, non sono un tecnico – non so ho mai saputo scrivere una riga di software. Quel che mi è servito, credo, è una certa propensione al rischio e un’intuizione su quel che accadrà in futuro. Intuire dove le cose stanno andando è l’essenza dell’imprenditorialità. E cosa vedo oggi nel nostro futuro? Vedo dei forconi».«Mentre persone come voi e me prosperano oltre i sogni di ogni plutocrate nella storia, il resto del paese – il 99,9% – resta molto indietro e arretra. Il divario fra quelli che hanno e quelli che non hanno peggiora sempre di più. Nel 1980 l’1% in cima alla piramide controllava l’8% del reddito nazionale degli Stati Uniti. Il 50% più in basso si divideva il 18% delle ricchezze. Oggi l’1% più ricco si divide il 20%, e il 50% della popolazione solo il 12%. Ma il problema non è la disuguaglianza in sé, qualche misura è intrinseca a ogni economia capitalista che funzioni. Il problema è che la disuguaglianza è a livelli storicamente mai visti e peggiora di giorno in giorno. Il nostro paese sta diventando una società sempre meno capitalista e sempre più una società feudale. A meno che le nostre politiche non cambino drammaticamente, la classe media scomparirà, e torneremo indietro alla Francia del 18° secolo. Prima della Rivoluzione. Così ho un messaggio per i miei colleghi oscenamente ricchi, per tutti coloro che vivono nelle bolle dei nostri mondi circondati da cancellate: svegliatevi, gente. Non durerà. Se non si fa qualcosa per sanare le clamorose diseguaglianze in questa economia, i forconi ci saranno addosso».«Nessuna società può tollerare una tale disparità. Non ci sono esempi nella storia in cui si sia verificata una tale accumulazione di ricchezza e i forconi non siano arrivati. Dove c’è una società altamente disuguale o c’è uno Stato di polizia, o un’insurrezione. Non ci sono altre possibilità. Il punto non è se, ma quando. Molti di voi pensano che siamo speciali perché “questa è l’America”, pensiamo di essere immuni alla forze che hanno dato vita alla Primavera Araba o alle Rivoluzioni in Francia e in Russia. Molti fra i colleghi dello 0,1% sfuggono questo argomento, molti mi prendono per matto, altri vedono un ragazzino povero con un iPhone e pensano che l’ineguaglianza sia una finzione. Vivete nel mondo dei sogni, vi dico. Volete credere che se ci sarà qualche segnale di destabilizzazione, ci sarà tempo per reagire e organizzarsi. Ma non funziona così, come sa qualsiasi studente di storia. Le rivoluzioni, come le bancarotte, si manifestano per gradi e poi precipitano di colpo. Un giorno uno si dà fuoco e improvvisamente la gente è in strada, prima che ci si renda conto il paese brucia. E non c’è tempo per salire sul nostro Gulfstream e scappare in Nuova Zelanda. Succede così. E se l’ineguaglianza peggiorerà, succederà».Sembrano le parole dei ragazzi di “Occupy Wall Street”, movimento che pare scomparso nel nulla. Ma il nostro capitalista niente affatto pentito non parla così per paura quanto per interesse. Del paese, della società, ma anche degli stessi ultraricchi dello 0,1%, a quanto cerca di dimostrare nell’analisi che segue. La cui tesi si può riassumere nel titolo dato al post da “Business Insider” (foto di persone in fila negli anni ’30 della Grande Depressione): “Spiacenti, gente, ma i ricchi non creano occupazione”. Hanauer se la prende con il punto di vista “ortodosso” dell’economia politica, e ne smonta alcuni presupposti di fondo: «Sono i ricchi che creano occupazione? Falso. E’ come dire che il seme crea l’albero: magari ne è il presupposto, ma provate a piantare un seme su Marte o nel Sahara. Senza terra buona, acqua, nutrienti non spunterà nulla e il seme morirà. La retorica per cui l’America è grande per via di uomini come me e Steve Jobs è finzione. Se entrambi fossimo nati in Somalia o in Congo saremmo rimasti a vendere frutta all’angolo della strada».L’economia non è un’astrazione, ma un ecosistema complesso di persone reali fra loro interdipendenti. Se i lavoratori hanno più denaro, le imprese hanno più clienti e hanno bisogno di più impiegati. A creare posti di lavoro in ultima istanza sono i clienti, i consumatori, vale a dire la classe media. Non sono i ricchi, come vuole uno dei luoghi comuni dell’economia ortodossa, non sono gli imprenditori, che pure sono una parte importante del processo. La classe media è stata la causa, non la conseguenza, della prosperità goduta nel passato dagli Usa. Alzare il salario minimo costa posti di lavoro, per la legge della domanda e dell’offerta? Falso. Lo aveva ben capito Henry Ford che nel 1914 raddoppiò la paga ai suoi operai (a 5 dollari al giorno, equivalenti a 120 di oggi) affinché potessero permettersi di comprare le auto che producevano. Lo ha capito la città di Seattle, che ha alzato per legge il salario minimo a 15 dollari l’ora da 9 – che era già il 30% in più della media Usa. Risultato: Seattle è con San Francisco la città col tasso di occupazione più alto negli Usa, ed è in assoluto la città che cresce di più.Il problema con la nostra economia – chiosa “Business Insider” – è che quella che una volta era la nostra potente classe media è stata lasciata impoverire da decenni di tagli ai costi e salari stagnanti, e oggi porta a casa una quota molto minore di 30 anni fa, mentre gente come Hanauer e i suoi amici dell’1% si accaparravano fette sempre maggiori di ricchezza, anche dopo la crisi del 2008. Dal 2009 al 2012 il 95% dei guadagni è andato all’1% mentre il 99% è rimasto al palo. Negli ultimi tre decenni i compensi per i Ceo (amministratori delegati, direttori generali, alti dirigenti) sono cresciuti 127 volte più rapidamente di quelli di altre categorie. Dal 1950 il rapporto tra la paga di un Ceo e quella di un lavoratore è aumentato del 1.000%: i Ceo guadagnavano 30 volte il salario medio, oggi il loro stipendio vale 500 volte il secondo. E nessuno ha eliminato i propri alti dirigenti senior, li ha esternalizzati in Cina o ha automatizzato il loro lavoro. Al contrario, ce ne sono molti più di prima.Intanto la classe media veniva falcidiata da politiche fiscali favorevoli all’1%, dalla globalizzazione e da miglioramenti tecnologici senza controlli. Ma veniva strozzata anche dalla nostra ossessione per il profitto a breve termine, dall’ethos prevalente nel mondo degli affari per cui gli impiegati sono visti come “un costo” e le società tengono i loro salari più bassi possibile. E’ un bene per l’economia che i ricchi siano sempre più ricchi? Falso. Il punto è che la classe media spende quasi tutto quello che guadagna, e questa spesa diventa ricavo per società avviate, finanziate o possedute da persone come Hanauer. Ma oggi, con i salari bassi come mai grazie all’avidità e alle corte vedute dell’1%, la classe media non è più in grado di farlo, e ciò si ritorce contro l’economia reale e gli stessi imprenditori. In America infatti i più ricchi – imprenditori, investitori e società – oggi hanno così tanto denaro da non riuscire a spenderlo. Così, invece di ri-pomparlo nell’economia creando guadagni e salari, quel denaro resta in conti di investimento.«Io guadagno all’anno 1.000 volte l’americano medio, ma non compro mille volte più roba. La mia famiglia negli ultimi anni ha comprato tre automobili, non 3.000. Io ho acquistato qualche paio di pantaloni e qualche camicia all’anno, come molti altri americani. Ho comprato due paia dei migliori pantaloni di lana, quelli che il mio partner Mike chiama “pantaloni da manager”. Ma non avrei potuto acquistarne 1.000. Invece ho messo via il mio denaro extra là dove non fa molto bene al paese». Se i 9 milioni di dollari di Hanauer in più dei 10 milioni di guadagni annuali fossero andati a 9.000 famiglie invece che a lui, sarebbero stati pompati di nuovo nell’economia attraverso il consumo. E avrebbero creato più occupazione. Invece stanno nei conti bancari di Hanauer o investiti in società che non hanno abbastanza clienti potenziali a cui vendere. Hanauer stima che se la maggior parte delle famiglie americane portasse a casa la stessa quota di reddito nazionale di 30 anni fa, ogni famiglia avrebbe altri 10.000 dollari di reddito da spendere.Con famiglie più ricche, lo Stato potrebbe davvero diventare più snello, risparmiando su assistenza pubblica, cure mediche gratuite, buoni pasto (oggi fruiti da 44 milioni di cittadini). E anche i più ricchi se ne gioverebbero. Il messaggio finale: «Cari 1%, molti dei nostri compatrioti cominciano a credere che il problema sia il capitalismo in sé. Non sono d’accordo, e credo non lo siate neppure voi. Ma il capitalismo lasciato senza controlli tende alla concentrazione e al collasso. Ecco perché gli investimenti nella classe media funzionano, e i tagli delle tasse ai ricchi invece no. Bilanciare il potere dei lavoratori con quello dei miliardari alzando il salario minimo non è male per il capitalismo, è uno strumento indispensabile per rendere il capitalismo stabile e sostenibile», conclude Hanauer (all’inizio invero esortava a prendere esempio dalle riforme di Franklyn Delano Roosevelt, un po’ più ampie di così). «O possiamo star seduti, non fare nulla e goderci i nostri yacht. Aspettando i forconi».L’analisi di Hanauer riguarda anche l’Italia? Sì, per tre motivi. Perché le disuguaglianze ci sono anche da noi, sia pure meno accentuate che negli Usa; perché le tendenze in America si riflettono altrove, a cominciare dall’Europa; perché, al di là delle riforme indispensabili al nostro paese fermo da decenni, l’economia italiana fa parte del sistema economico globale. Un sistema che fra debiti enormi e disoccupazione vertiginosa non sta affatto bene, come oggi ricorda la Banca dei Regolamenti Internazionali, mentre un rapporto della Banca Mondiale invita esplicitamente a prepararsi per la prossima crisi. Hanauer parla sicuramente nell’interesse dell’economia reale, dei cittadini e delle imprese piccole e medie. Ma alle banche e alle grandi corporations i luoghi comuni dell’ortodossia vanno benissimo. Finanza e multinazionali, compresi i costruttori di armamenti, i colossi dell’high-tech, i giganti della farmaceutica o del web hanno clienti globali, si tratti dell’1% del pianeta (dove addirittura 85 iper-ricchi – non 8.500, né 850, proprio 85 – detengono tanta ricchezza quanta ne possiede la metà della popolazione della Terra) o della classe media che a livello planetario comunque emerge fra varie contraddizioni. E multinazionali e banche & finanza hanno anche le lobby più potenti capaci di “convincere” i politici a fare leggi e norme a loro più favorevoli. Non resta che attendere i forconi, allora, o aspettare la prossima crisi?(Maria Grazia Bruzzone, “Svegliatevi plutocrati, i forconi ci saranno addosso”, da “La Stampa” del 4 luglio 2014).«Probabilmente non mi conoscete, ma come voi sono uno degli 0,1%, un fiero capitalista. Ho fondato, co-fondato e finanziato più di 30 società di ogni genere, da cose piccole come il night club con cui ho cominciato a vent’anni, a giganti come Amazon.com di cui sono stato il primo investitore esterno. Poi ho fondato aQuantitative, una società di pubblicità su Internet che nel 2007 è stata venduta a Microsoft per 6,4 miliardi di dollari. In contanti. Insieme ad amici possediamo una nostra banca. Racconto tutto questo per dimostrarvi che per molti versi non sono molto diverso da voi. Come voi ho una visione ampia degli affari e del capitalismo. E come voi sono stato oscenamente ricompensato per il mio successo, con una vita che gli altri 99,9% di americani non possono nemmeno immaginare. Molteplici case, aereo personale, ecc». Comincia così una sorprendente lettera aperta, pubblicata qualche giorno fa dal sofisticato “Politico.com” e rilanciata da siti di economia & politica come “Business Insider” e “Zero Hedge”, ogni volta con un gran numero di lettori e apprezzamenti.
-
L’Aspen: rivolte senza rivoluzione, non ci fanno paura
 Per fortuna le nostre sono proteste senza un vero progetto politico, capace di cambiare le cose e costruire un’alternativa sociale basata sulla giustizia. Lo dichiara l’Aspen Institute, influente think-tank dell’oligarchia mondiale, che in Italia annovera tra i suoi dirigenti personaggi come Enrico Letta e Giulio Tremonti. Finanziato da fondazioni come Rockefeller, Ford e Carnegie Corporation, l’Aspen lavora per «la creazione di un terreno comune di comprensione approfondita in uno scenario non ideologizzato». Originale l’ultimo studio commissionato al bulgaro Ivan Krastev, presidente del “Centro di strategie liberali” di Sofia e tipico esponente di quella “nuova classe dirigente” dell’Est europeo cresciuta a forza di commissioni internazionali, liberismo e “formazione liberale delle leadership”. Lo studio «fornisce lo sguardo dei “padroni del globo” nel trattare le rivolte degli ultimi anni», come se fossimo giunti alla fine di un’epoca fondata sui diritti.«L’unica “ideologia” che conquista cuore e menti, di fronte al feticcio meccanico del capitalismo disincantato attuale, resta tristemente la religione», scrive Dante Barontini su “Contropiano”. «Ma le rivolte nascono dalla crisi economica, dal peggioramento delle condizioni di vita, dalla confusa sensazione che “non ci sia futuro”, e tantomeno “miglioramento”». L’ideologia «arriva dopo, come “spiegazione” e promessa». Per questo «siamo arrivati, come mondo, ad un punto limite: e nessuno sa dove sia costruibile il passaggio epocale ad un altro modello di vita». All’Aspen, aggiunge Barontini, non interessa ovviamente “superare” il capitalismo: «La posizione “ideologica” è dunque saldamente conservatrice, ma questo non ha mai impedito ai padroni del mondo di guardare in faccia ai problemi reali per trovare anche ciò che serve alla conservazione». Lo sguardo di Krastev coglie momenti rilevanti, comuni a paesi lontani fra loro, per intercettare lo “spirito del tempo” e ovviamente neutralizzare la richiesta di cambianento.Per conto dell’Aspen, il bulgaro Krastev «analizza i movimenti di rivolta come da un osservatorio satellitare, disinteressandosi dei dettagli» e andando al sodo. Dice: «Le proteste differivano, ma gli slogan erano incredibilmente simili: ai quattro angoli del globo i manifestanti si scagliavano contro la corruzione delle élite, le crescenti diseguaglianze economiche, la mancanza di solidarietà e di giustizia sociale e il disprezzo per la dignità umana». Ma aggiunge: «I manifestanti, a differenza dei loro padri rivoluzionari, non mirano a un rovesciamento violento dell’ordine costituito». La nuova generazione degli “indignados” – di Grecia e Spagna, Italia e Ucraina, Brasile e Portogallo – non ci pensa proprio a “cambiare il sistema”: «Non possiede le conoscenze di base, le categorie, la cultura per poter pensare che questo “sistema” sia rovesciabile; non è insomma in grado di immaginare un altro realistico modo di vivere». Soprattutto, aggiunge Barontini, «è ai margini del pensiero politico, non dentro».Per Krastev, «si tratta di una rivoluzione senza ideologia e senza scopi definiti: in mancanza di alternative politiche, si risolve in uno scoppio di indignazione morale». Una febbre passeggera, che non spaventa affatto il potere. Lo studioso bulgaro, continua “Contropiano”, sembra profondamente consapevole del fatto che la gestione del mondo è troppo complessa per lasciarla decidere a opinioni labili, poco consapevoli e altamente disinformate («insomma, a libere elezioni»). Ed è perfettamente a suo agio nell’affontare in modo ironico il mantra dei “social network” come mezzo d’elezione delle nuove proteste planetarie: «I nuovi movimenti si concepiscono come reti, nella convinzione che queste possano avere la meglio sulla gerarchia: l’onnipotente rete è l’arma organizzativa d’elezione, allo stesso modo in cui il piccolo ma disciplinato partito rivoluzionario era l’arma d’elezione dei comunisti».E qui, osserva Barontini, scatta l’ironia crudele di chi è seduto in una lussuosa suite nel cielo del capitale nei confronti delle formiche formicolanti sulla superficie o nelle viscere della terra: «Uno che sa benissimo che “la rete” ha dei gestori, dei proprietari, dei sorveglianti». E lo sa ovviamente anche Krastev, che dice: «I governi hanno appreso in fretta a esercitare il controllo e la manipolazione nell’universo digitale. “Caro utente, sei stato schedato come partecipante a una massiccia turbativa dell’ordine pubblico”: questo il messaggio che i manifestanti ucraini si sono ritrovati sul cellulare a metà gennaio, nel momento esatto in cui la legislazione anti-dimostrazioni veniva approvata dal Parlamento. La stessa tecnologia che aveva portato la gente in strada l’ammoniva di tornarsene a casa». Gli attivisti di Occupy Wall Street sono stati trattati con forse più irritante sufficienza dall’establishment Usa: il pacchetto dei profili Facebook dei “sensibilizzati al movimento” è stato valutato 25 milioni di dollari. E qualche multinazionale delle vendite online o della pubblicità mirata – oltre che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti – se l’è certamente comprato.Negli Stati Uniti o in Spagna, prosegue Barontini, gli esecutivi hanno prontamente riconosciuto la legittimità delle preoccupazioni espresse dai manifestanti e hanno dato mostra di ascoltare la piazza. Le proteste non hanno inciso sulle politiche dei governi; piuttosto, hanno cambiato il modo in cui questi comunicano ciò che fanno. Chiaro, no? «Un governo furbo non spiana le proteste popolari a manganellate, ma le “rintontonisce de bucie”. O, come si dice adesso, “cambia la comunicazione”». Il quasi-conflitto di oggi è pressoché innocuo, «molto più “potabile” della guerra rivoluzionaria novecentesca». Chiarisce Krastev: «Oggi, il sistema non interessa quasi più a nessuno. La rivoluzione attuale non è fatta di lettori; gli odierni studenti radicali si preoccupano solo di come essi stessi vivono il sistema, non della sua natura e dei meccanismi che lo governano. Non pensando in termini di gruppi sociali, questi ragazzi hanno un’esperienza comune, ma mancano di un’identità collettiva», in assenza di cultura politica.Riflettendo sulle proteste di São Paulo dell’estate scorsa, il ricercatore brasiliano Pablo Ortellado ha osservato che in tutto il Brasile i manifestanti protestavano sulla scorta di due messaggi simultanei e tra loro contraddittori: “Il governo non ci rappresenta” e “Vogliamo servizi pubblici migliori”. Era una protesta di consumatori radicali, più che di rivoluzionari utopici. Così, quando le condizioni di vita diventano intollerabili, chi oggi protesta «è portato a ritenere che ci sia una “ingiustizia” (dei ladri, una “casta”) che fa funzionare in modo distorto o inefficace un meccanismo altrimenti “buono”», sottolinea “Contropiano”. «I manifestanti sono individui esasperati: amano stare insieme e combattere insieme, ma non hanno un progetto collettivo», sostiene Krastev. «Diffidano delle istituzioni, ma non sono interessati a prendere il potere: sono una miscela tra un desiderio genuino di comunità e un incoercibile individualismo».I manifestanti di oggi, in fondo, si comportano come “consumatori” insoddisfatti. E così, l’arretramento politico dell’attuale società “ribelle” è tale che l’analista dell’Aspen «affonda il coltello nella piaga con autentica gioia», spiegando che «le proteste del XXI secolo somigliano, per alcuni versi, a quelle medioevali», quando le persone «non scendevano in piazza con l’ambizione di rovesciare il re o di sostituirlo con un altro a loro più gradito», ma si limitavano a manifestare «per obbligare il sovrano a fare qualcosa in loro favore, o per impedirgli di far loro del male». L’etica del rigetto può essere radicale e totale, come il rifiuto del capitalismo globale di Occupy Wall Street, oppure modesta e localistica, come le proteste contro la nuova stazione ferroviaria di Stoccarda. «Ma il principio è lo stesso: le proteste possono riuscire o fallire, ma ciò che ne definisce il profilo politico è un generalizzato “no”. Per essere gridato, questo “no” non ha più bisogno di leader o istituzioni: bastano telefonini e social network». Il potere ne ride apertamente, sapendo benissimo come aggirare e manipolare la protesta, mentre il neoliberismo totalitario dell’élite sta mandando in pensione la vecchia democrazia liberale, con elezioni ormai svuotate di senso e Stati senza più sovranità.«Per molti aspetti – chiosa l’analista dell’Aspen – le odierne proteste di massa sono atti in cerca di concetti, pratica senza teoria. Sono l’espressione più plateale della convinzione diffusa che le élite non governino nell’interesse del popolo e che l’elettorato ha perso il controllo sugli eletti». Ma oltre le manifestazioni non si va mai, aggiunge Barontini: «Proteste impolitiche, strumenti organizzativi affidati alla Rete, assenza di identità collettiva e progetto politico, legami reciproci labili… Una contestazione con queste caratteristiche non ha possibilità di mettere in crisi il potere. Basta un cerino di violenza – controllato da una mente politica (posizionata nel satellite iperuranio della finanza globale, per cui conto Krastev scrive) – per “far sciogliere come neve al sole” piazze anche più di grandi di Tahrir, al di là delle buone intenzioni o dell’estrazione sociale di chi le riempie». Nessuno progetta alternative al capitalismo globalizzato. «L’unica cosa di cui abbia timore questo potere è il sempre possibile riaffacciarsi del “comunismo”, il diavolo di San Pietroburgo, il soffio liberatore degli anni ‘60 e ‘70, dal Vietnam al ‘68, dal ‘77 a L’Avana». Krastev alla fine diventa esplicito: le proteste, come le elezioni, servono a tenere il più lontano possibile la rivoluzione, la promessa di un futuro radicalmente diverso. «Il “laureato senza futuro” non è il nuovo proletario», perché «confonde “ideologia” e “visione del mondo”». E il cambiamento continua a non apparire all’orizzonte.
Per fortuna le nostre sono proteste senza un vero progetto politico, capace di cambiare le cose e costruire un’alternativa sociale basata sulla giustizia. Lo dichiara l’Aspen Institute, influente think-tank dell’oligarchia mondiale, che in Italia annovera tra i suoi dirigenti personaggi come Enrico Letta e Giulio Tremonti. Finanziato da fondazioni come Rockefeller, Ford e Carnegie Corporation, l’Aspen lavora per «la creazione di un terreno comune di comprensione approfondita in uno scenario non ideologizzato». Originale l’ultimo studio commissionato al bulgaro Ivan Krastev, presidente del “Centro di strategie liberali” di Sofia e tipico esponente di quella “nuova classe dirigente” dell’Est europeo cresciuta a forza di commissioni internazionali, liberismo e “formazione liberale delle leadership”. Lo studio «fornisce lo sguardo dei “padroni del globo” nel trattare le rivolte degli ultimi anni», come se fossimo giunti alla fine di un’epoca fondata sui diritti.«L’unica “ideologia” che conquista cuore e menti, di fronte al feticcio meccanico del capitalismo disincantato attuale, resta tristemente la religione», scrive Dante Barontini su “Contropiano”. «Ma le rivolte nascono dalla crisi economica, dal peggioramento delle condizioni di vita, dalla confusa sensazione che “non ci sia futuro”, e tantomeno “miglioramento”». L’ideologia «arriva dopo, come “spiegazione” e promessa». Per questo «siamo arrivati, come mondo, ad un punto limite: e nessuno sa dove sia costruibile il passaggio epocale ad un altro modello di vita». All’Aspen, aggiunge Barontini, non interessa ovviamente “superare” il capitalismo: «La posizione “ideologica” è dunque saldamente conservatrice, ma questo non ha mai impedito ai padroni del mondo di guardare in faccia ai problemi reali per trovare anche ciò che serve alla conservazione». Lo sguardo di Krastev coglie momenti rilevanti, comuni a paesi lontani fra loro, per intercettare lo “spirito del tempo” e ovviamente neutralizzare la richiesta di cambianento.Per conto dell’Aspen, il bulgaro Krastev «analizza i movimenti di rivolta come da un osservatorio satellitare, disinteressandosi dei dettagli» e andando al sodo. Dice: «Le proteste differivano, ma gli slogan erano incredibilmente simili: ai quattro angoli del globo i manifestanti si scagliavano contro la corruzione delle élite, le crescenti diseguaglianze economiche, la mancanza di solidarietà e di giustizia sociale e il disprezzo per la dignità umana». Ma aggiunge: «I manifestanti, a differenza dei loro padri rivoluzionari, non mirano a un rovesciamento violento dell’ordine costituito». La nuova generazione degli “indignados” – di Grecia e Spagna, Italia e Ucraina, Brasile e Portogallo – non ci pensa proprio a “cambiare il sistema”: «Non possiede le conoscenze di base, le categorie, la cultura per poter pensare che questo “sistema” sia rovesciabile; non è insomma in grado di immaginare un altro realistico modo di vivere». Soprattutto, aggiunge Barontini, «è ai margini del pensiero politico, non dentro».Per Krastev, «si tratta di una rivoluzione senza ideologia e senza scopi definiti: in mancanza di alternative politiche, si risolve in uno scoppio di indignazione morale». Una febbre passeggera, che non spaventa affatto il potere. Lo studioso bulgaro, continua “Contropiano”, sembra profondamente consapevole del fatto che la gestione del mondo è troppo complessa per lasciarla decidere a opinioni labili, poco consapevoli e altamente disinformate («insomma, a libere elezioni»). Ed è perfettamente a suo agio nell’affontare in modo ironico il mantra dei “social network” come mezzo d’elezione delle nuove proteste planetarie: «I nuovi movimenti si concepiscono come reti, nella convinzione che queste possano avere la meglio sulla gerarchia: l’onnipotente rete è l’arma organizzativa d’elezione, allo stesso modo in cui il piccolo ma disciplinato partito rivoluzionario era l’arma d’elezione dei comunisti».E qui, osserva Barontini, scatta l’ironia crudele di chi è seduto in una lussuosa suite nel cielo del capitale nei confronti delle formiche formicolanti sulla superficie o nelle viscere della terra: «Uno che sa benissimo che “la rete” ha dei gestori, dei proprietari, dei sorveglianti». E lo sa ovviamente anche Krastev, che dice: «I governi hanno appreso in fretta a esercitare il controllo e la manipolazione nell’universo digitale. “Caro utente, sei stato schedato come partecipante a una massiccia turbativa dell’ordine pubblico”: questo il messaggio che i manifestanti ucraini si sono ritrovati sul cellulare a metà gennaio, nel momento esatto in cui la legislazione anti-dimostrazioni veniva approvata dal Parlamento. La stessa tecnologia che aveva portato la gente in strada l’ammoniva di tornarsene a casa». Gli attivisti di Occupy Wall Street sono stati trattati con forse più irritante sufficienza dall’establishment Usa: il pacchetto dei profili Facebook dei “sensibilizzati al movimento” è stato valutato 25 milioni di dollari. E qualche multinazionale delle vendite online o della pubblicità mirata – oltre che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti – se l’è certamente comprato.Negli Stati Uniti o in Spagna, prosegue Barontini, gli esecutivi hanno prontamente riconosciuto la legittimità delle preoccupazioni espresse dai manifestanti e hanno dato mostra di ascoltare la piazza. Le proteste non hanno inciso sulle politiche dei governi; piuttosto, hanno cambiato il modo in cui questi comunicano ciò che fanno. Chiaro, no? «Un governo furbo non spiana le proteste popolari a manganellate, ma le “rintontonisce de bucie”. O, come si dice adesso, “cambia la comunicazione”». Il quasi-conflitto di oggi è pressoché innocuo, «molto più “potabile” della guerra rivoluzionaria novecentesca». Chiarisce Krastev: «Oggi, il sistema non interessa quasi più a nessuno. La rivoluzione attuale non è fatta di lettori; gli odierni studenti radicali si preoccupano solo di come essi stessi vivono il sistema, non della sua natura e dei meccanismi che lo governano. Non pensando in termini di gruppi sociali, questi ragazzi hanno un’esperienza comune, ma mancano di un’identità collettiva», in assenza di cultura politica.Riflettendo sulle proteste di São Paulo dell’estate scorsa, il ricercatore brasiliano Pablo Ortellado ha osservato che in tutto il Brasile i manifestanti protestavano sulla scorta di due messaggi simultanei e tra loro contraddittori: “Il governo non ci rappresenta” e “Vogliamo servizi pubblici migliori”. Era una protesta di consumatori radicali, più che di rivoluzionari utopici. Così, quando le condizioni di vita diventano intollerabili, chi oggi protesta «è portato a ritenere che ci sia una “ingiustizia” (dei ladri, una “casta”) che fa funzionare in modo distorto o inefficace un meccanismo altrimenti “buono”», sottolinea “Contropiano”. «I manifestanti sono individui esasperati: amano stare insieme e combattere insieme, ma non hanno un progetto collettivo», sostiene Krastev. «Diffidano delle istituzioni, ma non sono interessati a prendere il potere: sono una miscela tra un desiderio genuino di comunità e un incoercibile individualismo».I manifestanti di oggi, in fondo, si comportano come “consumatori” insoddisfatti. E così, l’arretramento politico dell’attuale società “ribelle” è tale che l’analista dell’Aspen «affonda il coltello nella piaga con autentica gioia», spiegando che «le proteste del XXI secolo somigliano, per alcuni versi, a quelle medioevali», quando le persone «non scendevano in piazza con l’ambizione di rovesciare il re o di sostituirlo con un altro a loro più gradito», ma si limitavano a manifestare «per obbligare il sovrano a fare qualcosa in loro favore, o per impedirgli di far loro del male». L’etica del rigetto può essere radicale e totale, come il rifiuto del capitalismo globale di Occupy Wall Street, oppure modesta e localistica, come le proteste contro la nuova stazione ferroviaria di Stoccarda. «Ma il principio è lo stesso: le proteste possono riuscire o fallire, ma ciò che ne definisce il profilo politico è un generalizzato “no”. Per essere gridato, questo “no” non ha più bisogno di leader o istituzioni: bastano telefonini e social network». Il potere ne ride apertamente, sapendo benissimo come aggirare e manipolare la protesta, mentre il neoliberismo totalitario dell’élite sta mandando in pensione la vecchia democrazia liberale, con elezioni ormai svuotate di senso e Stati senza più sovranità.«Per molti aspetti – chiosa l’analista dell’Aspen – le odierne proteste di massa sono atti in cerca di concetti, pratica senza teoria. Sono l’espressione più plateale della convinzione diffusa che le élite non governino nell’interesse del popolo e che l’elettorato ha perso il controllo sugli eletti». Ma oltre le manifestazioni non si va mai, aggiunge Barontini: «Proteste impolitiche, strumenti organizzativi affidati alla Rete, assenza di identità collettiva e progetto politico, legami reciproci labili… Una contestazione con queste caratteristiche non ha possibilità di mettere in crisi il potere. Basta un cerino di violenza – controllato da una mente politica (posizionata nel satellite iperuranio della finanza globale, per cui conto Krastev scrive) – per “far sciogliere come neve al sole” piazze anche più di grandi di Tahrir, al di là delle buone intenzioni o dell’estrazione sociale di chi le riempie». Nessuno progetta alternative al capitalismo globalizzato. «L’unica cosa di cui abbia timore questo potere è il sempre possibile riaffacciarsi del “comunismo”, il diavolo di San Pietroburgo, il soffio liberatore degli anni ‘60 e ‘70, dal Vietnam al ‘68, dal ‘77 a L’Avana». Krastev alla fine diventa esplicito: le proteste, come le elezioni, servono a tenere il più lontano possibile la rivoluzione, la promessa di un futuro radicalmente diverso. «Il “laureato senza futuro” non è il nuovo proletario», perché «confonde “ideologia” e “visione del mondo”». E il cambiamento continua a non apparire all’orizzonte.Per fortuna le nostre sono proteste senza un vero progetto politico, capace di cambiare le cose e costruire un’alternativa sociale basata sulla giustizia. Lo dichiara l’Aspen Institute, influente think-tank dell’oligarchia mondiale, che in Italia annovera tra i suoi dirigenti personaggi come Enrico Letta e Giulio Tremonti. Finanziato da fondazioni come Rockefeller, Ford e Carnegie Corporation, l’Aspen lavora per «la creazione di un terreno comune di comprensione approfondita in uno scenario non ideologizzato». Originale l’ultimo studio commissionato al bulgaro Ivan Krastev, presidente del “Centro di strategie liberali” di Sofia e tipico esponente di quella “nuova classe dirigente” dell’Est europeo cresciuta a forza di commissioni internazionali, liberismo e “formazione liberale delle leadership”. Lo studio «fornisce lo sguardo dei “padroni del globo” nel trattare le rivolte degli ultimi anni», come se fossimo giunti alla fine di un’epoca fondata sui diritti.
-
Guido Rossi: conta solo il denaro, la democrazia è finita
 omo del regime economico, non solo italiano ma europeo, che ci condiziona dagli anni ‘80», da quando cioè i mercati sono diventati «il valore di riferimento», e il denaro «la misura di tutte le cose». Tutto è denaro, quindi ogni bene pubblico è privatizzabile. Con tanti saluti allo Stato di diritto.C’è un sistema ideologico alla base delle politiche economiche, accusa Rossi in un editoriale sul “Sole 24 Ore” ripreso da “Micromega”: «Un erroneo concetto di libertà ha fatto sì che le scuole, gli ospedali e persino le prigioni possano essere privatizzate a scopo di lucro. E se così è, perché non dovrebbe essere, allo stesso scopo, privatizzato anche ogni ufficio pubblico?». Questo sistema, continua Rossi, ha creato due conseguenze parallele: «Le ineguaglianze, delle quali ha dato un’impareggiabile recente documentazione il tanto discusso libro di Thomas Piketty “Le capital au XXI siècle”», e naturalmente «la corruzione, sia nel settore pubblico sia in quello privato». Secondo la “London Review of Books”, che parla di “Disastro italiano”, l’Italia in Europa non è un caso anomalo, ma piuttosto una sorta di concentrato, visto che «la manipolazione da parte dei poteri esecutivi nei confronti dei legislativi e la generale involuzione e crisi delle classi politiche causano un silenzioso deficit di democrazia, alimentato da una quasi assoluta scarsità di mezzi di informazione indipendenti e con un aumento della corruzione».Un panorama impressionante in tutti i paesi: dalla Germania di Helmut Kohl, indiscusso cancelliere per 16 anni, che ricevette due milioni di marchi tedeschi in fondi neri, «rifiutandosi di rivelare il nome dei donatori per timore che emergessero i favori che avevano ricevuto in cambio», alla Francia di un altro super-potente, il presidente Jacques Chirac, in sella per 12 anni, che a fine mandato (cessata l’immunità) fu accusato di abuso d’ufficio, peculato e conflitto di interessi. Clamoroso, ancora in Germania, il governo del socialdemocratico Gerhard Schröder, che garantì un prestito da un milione di euro a Gazprom per creare una pipeline nel Baltico, «poche settimane prima che lo stesso cancelliere, terminato il mandato, diventasse consulente di Gazprom a un compenso molto maggiore di quello fino a quel momento ricevuto per governare il paese». Dalla Grecia alla Spagna non si salva nessuno. Spiccano, in Gran Bretagna, i favori elargiti alla Faith Foundation di Tony Blair, il rottamatore della sinistra inglese.«Le diseguaglianze dovute all’abnorme concentrazione in poche mani della ricchezza e le varie forme di corruzione sono indissolubilmente legate», sottolinea Guido Rossi, e costituiscono «la conseguenza principale e più grave dell’intreccio ormai inevitabile fra politica ed economia». Non è un caso che questo intreccio, nelle ideologie contemporanee, diventi inestricabile, al punto che le stesse istituzioni politiche ancora formalmente democratiche «diventino a loro volta causa ed effetto delle diseguaglianze e della corruzione». Non ne sono immuni neppure gli Usa, dove si sta erodendo una Costituzione nata per «assicurare l’indipendenza del governo federale da chiunque non fosse il solo popolo», secondo le famose parole di James Madison. Nel suo libro-denuncia del 2011 sulla “Repubblica perduta” (“Republic, Lost: How Money Corrupts Congress – And a Plan to Stop It”), Lawrence Lessig spiega che la “gift economy” americana prevede uno scambio corruttivo fatto di «favori e rapporti», innescando un conflitto istituzionale che minaccia la democrazia americana, secondo il grande filosofo Ronald Dworkin. Nel 2010 e poi il 2 aprile 2014, infatti, la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto costituzionale di «finanziare candidati e campagne elettorali senza limiti alle somme di denaro profuse».Di conseguenza, secondo Lessig, il denaro «è diventato il problema della politica americana e la radice di ogni altro male, che avvelena la fiducia del cittadino nel governo e nella democrazia, divenuta una sorta di sciarada». Così, osserva Rossi, emerge «un virus distruttivo delle democrazie, che induce i tre poteri dello Stato a confrontarsi fra loro nel tentativo di combattere senza successo la corruzione pubblica, che anche quando viene individuata rimane senza sanzione», confermando l’intreccio tra politica e affari. «Né i grandi banchieri né i politici corrotti sono di norma puniti con la reclusione, perché entrambi sono, secondo l’espressione americana, “too big to jail” (troppo importanti per la galera)». E’ così che, lentamente, soccombe il potere che più di ogni altro dovrebbe combattere le disuguaglianze: la giustizia. La mondializzazione tende a privatizzare anche quella: «Le sanzioni contro la corruzione internazionale delle grandi multinazionali globalizzate sono comminate con il versamento di cospicue somme di danaro, attraverso accordi con organismi del potere esecutivo e delle agenzie indipendenti (Doj, Sec), con una giustizia negoziata e privatizzata, secondo la perversa ideologia in voga».In questo modo, «la repressione della corruzione delle grandi società viene definita al di fuori delle autorità giurisdizionali, attraverso una collaborazione interna e un’autodichiarazione di colpevolezza da parte delle società che, pur di evitare la giustizia penale, pericolosa sotto ogni aspetto, anche quello reputazionale, preferiscono dichiararsi colpevoli e collaborare utilizzando complessi sistemi di indagini interne». Si chiamano “accordi di giustizia”, e sono semplici trattative. Senza più una vera giustizia, la corruzione pubblica e privata incoraggiata dalla deregulation continua a dilagare, senza freni, assumendo forme «di apparente legalità, difficilmente sanzionabili». Così, per Rossi, «la lotta contro le disuguaglianze e le corruzioni, pubbliche e private, illegali o elusive, deve essere ormai considerata il principale obiettivo per far sopravvivere le società che le corrette idee del passato, prima della loro disgregazione, ci avevano consegnato attraverso la tutela dei diritti dei cittadini».
omo del regime economico, non solo italiano ma europeo, che ci condiziona dagli anni ‘80», da quando cioè i mercati sono diventati «il valore di riferimento», e il denaro «la misura di tutte le cose». Tutto è denaro, quindi ogni bene pubblico è privatizzabile. Con tanti saluti allo Stato di diritto.C’è un sistema ideologico alla base delle politiche economiche, accusa Rossi in un editoriale sul “Sole 24 Ore” ripreso da “Micromega”: «Un erroneo concetto di libertà ha fatto sì che le scuole, gli ospedali e persino le prigioni possano essere privatizzate a scopo di lucro. E se così è, perché non dovrebbe essere, allo stesso scopo, privatizzato anche ogni ufficio pubblico?». Questo sistema, continua Rossi, ha creato due conseguenze parallele: «Le ineguaglianze, delle quali ha dato un’impareggiabile recente documentazione il tanto discusso libro di Thomas Piketty “Le capital au XXI siècle”», e naturalmente «la corruzione, sia nel settore pubblico sia in quello privato». Secondo la “London Review of Books”, che parla di “Disastro italiano”, l’Italia in Europa non è un caso anomalo, ma piuttosto una sorta di concentrato, visto che «la manipolazione da parte dei poteri esecutivi nei confronti dei legislativi e la generale involuzione e crisi delle classi politiche causano un silenzioso deficit di democrazia, alimentato da una quasi assoluta scarsità di mezzi di informazione indipendenti e con un aumento della corruzione».Un panorama impressionante in tutti i paesi: dalla Germania di Helmut Kohl, indiscusso cancelliere per 16 anni, che ricevette due milioni di marchi tedeschi in fondi neri, «rifiutandosi di rivelare il nome dei donatori per timore che emergessero i favori che avevano ricevuto in cambio», alla Francia di un altro super-potente, il presidente Jacques Chirac, in sella per 12 anni, che a fine mandato (cessata l’immunità) fu accusato di abuso d’ufficio, peculato e conflitto di interessi. Clamoroso, ancora in Germania, il governo del socialdemocratico Gerhard Schröder, che garantì un prestito da un milione di euro a Gazprom per creare una pipeline nel Baltico, «poche settimane prima che lo stesso cancelliere, terminato il mandato, diventasse consulente di Gazprom a un compenso molto maggiore di quello fino a quel momento ricevuto per governare il paese». Dalla Grecia alla Spagna non si salva nessuno. Spiccano, in Gran Bretagna, i favori elargiti alla Faith Foundation di Tony Blair, il rottamatore della sinistra inglese.«Le diseguaglianze dovute all’abnorme concentrazione in poche mani della ricchezza e le varie forme di corruzione sono indissolubilmente legate», sottolinea Guido Rossi, e costituiscono «la conseguenza principale e più grave dell’intreccio ormai inevitabile fra politica ed economia». Non è un caso che questo intreccio, nelle ideologie contemporanee, diventi inestricabile, al punto che le stesse istituzioni politiche ancora formalmente democratiche «diventino a loro volta causa ed effetto delle diseguaglianze e della corruzione». Non ne sono immuni neppure gli Usa, dove si sta erodendo una Costituzione nata per «assicurare l’indipendenza del governo federale da chiunque non fosse il solo popolo», secondo le famose parole di James Madison. Nel suo libro-denuncia del 2011 sulla “Repubblica perduta” (“Republic, Lost: How Money Corrupts Congress – And a Plan to Stop It”), Lawrence Lessig spiega che la “gift economy” americana prevede uno scambio corruttivo fatto di «favori e rapporti», innescando un conflitto istituzionale che minaccia la democrazia americana, secondo il grande filosofo Ronald Dworkin. Nel 2010 e poi il 2 aprile 2014, infatti, la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto costituzionale di «finanziare candidati e campagne elettorali senza limiti alle somme di denaro profuse».Di conseguenza, secondo Lessig, il denaro «è diventato il problema della politica americana e la radice di ogni altro male, che avvelena la fiducia del cittadino nel governo e nella democrazia, divenuta una sorta di sciarada». Così, osserva Rossi, emerge «un virus distruttivo delle democrazie, che induce i tre poteri dello Stato a confrontarsi fra loro nel tentativo di combattere senza successo la corruzione pubblica, che anche quando viene individuata rimane senza sanzione», confermando l’intreccio tra politica e affari. «Né i grandi banchieri né i politici corrotti sono di norma puniti con la reclusione, perché entrambi sono, secondo l’espressione americana, “too big to jail” (troppo importanti per la galera)». E’ così che, lentamente, soccombe il potere che più di ogni altro dovrebbe combattere le disuguaglianze: la giustizia. La mondializzazione tende a privatizzare anche quella: «Le sanzioni contro la corruzione internazionale delle grandi multinazionali globalizzate sono comminate con il versamento di cospicue somme di danaro, attraverso accordi con organismi del potere esecutivo e delle agenzie indipendenti (Doj, Sec), con una giustizia negoziata e privatizzata, secondo la perversa ideologia in voga».In questo modo, «la repressione della corruzione delle grandi società viene definita al di fuori delle autorità giurisdizionali, attraverso una collaborazione interna e un’autodichiarazione di colpevolezza da parte delle società che, pur di evitare la giustizia penale, pericolosa sotto ogni aspetto, anche quello reputazionale, preferiscono dichiararsi colpevoli e collaborare utilizzando complessi sistemi di indagini interne». Si chiamano “accordi di giustizia”, e sono semplici trattative. Senza più una vera giustizia, la corruzione pubblica e privata incoraggiata dalla deregulation continua a dilagare, senza freni, assumendo forme «di apparente legalità, difficilmente sanzionabili». Così, per Rossi, «la lotta contro le disuguaglianze e le corruzioni, pubbliche e private, illegali o elusive, deve essere ormai considerata il principale obiettivo per far sopravvivere le società che le corrette idee del passato, prima della loro disgregazione, ci avevano consegnato attraverso la tutela dei diritti dei cittadini».Plutocrazia, tutto il potere all’élite dei più ricchi. Se ormai conta solo il denaro – ed è quello a decidere chi sale e chi scende, chi vince e chi perde – possiamo dire addio alla politica, alla giustizia e alla stessa democrazia dei diritti. La corruzione dilagante? E’ solo una naturale conseguenza, in un mondo degradato dallo strapotere del denaro, immense ricchezze nelle mani di pochi oligarchi. Ne è convinto Guido Rossi, economista italiano e storico “controllore” della Consob, l’agenzia di vigilanza borsistica. La corruzione dilagante, che ha ormai «permeato tutta la vita politica, economica e sociale del nostro paese», segnando l’evidente «declino dell’ordine e delle istituzioni politiche», è un vero e proprio «sintomo del regime economico, non solo italiano ma europeo, che ci condiziona dagli anni ‘80», da quando cioè i mercati sono diventati «il valore di riferimento», e il denaro «la misura di tutte le cose». Tutto è denaro, quindi ogni bene pubblico è privatizzabile. Con tanti saluti allo Stato di diritto.
-
Il futuro secondo Arrighi: dopo di noi la Cina o il caos
 Sono tre i possibili esiti per la crisi terminale della “fase americana” nel sistema-mondo: un impero a guida occidentale, virando a dominio la strapotenza militare che i pur declinanti Stati Uniti continuano a mantenere; una società di mercato globale imperniata sull’Asia orientale; e infine l’orrore di un “caos sistemico” come liquidazione di qualsivoglia forma di governance. Giovanni Arrighi ne parla nel post-scriptum de “Il lungo XX secolo”, appena ripubblicato da “Il Saggiatore”, provando a delineare il futuro del pianeta. Fino alla sua morte, nel 2009, Arrighi aveva insegnato alla State University di New York e cooperato al Fernand Braudel Center, diretto da Immanuel Wallerstein. Obiettivo dell’autore, rileva Pierfranco Pellizzetti su “Micromega”, è quello di smontare la teorizzazione di un “eterno ritorno” che connoterebbe le dinamiche del capitalismo, con una fase di creazione di ricchezza (industria e scambi), una “crisi spia” (economia in recessione), un passaggio alla finanziarizzazione (accumulazione al posto della produzione) e la “crisi terminale”, con lo spostamento della centralità geoeconomica.Il valore di un’analisi, scrive Pellizzetti, scaturisce anche dai riflessi che induce, tenendo conto delle coordinate temporali: parole in controtendenza, nell’epoca in cui «un’intellighenzia embedded della restaurazione NeoLib propugnava le tesi pericolose quanto autolesionistiche del “Nuovo Secolo Americano”, poi insabbiate in Iraq e disperse tra le giogaie afgane. Il karakiri dell’Occidente». Il testo, ora tornato in libreria dopo la prima edizione del 1994, «fornisce strumenti particolarmente utili per posizionare in una giusta prospettiva la fine dell’unilaterialismo americano, che era emerso nel dopo Guerra Fredda; tra il crollo del muro di Berlino (1989) e quello delle Torri Gemelle (2001)». Per Pellizzetti, è la questione aperta – quindi attualissima – di un mondo ormai multipolare e senza più un centro. «Un mondo dove si sono determinate rotture sistemiche che reclamano nuove categorie di analisi; e che magari suonano campane a morto per lo stesso ordine capitalistico», quello che «ha egemonizzato i tempi del mondo per l’ultimo mezzo millennio e che potrebbe persino essere giunto a una fase terminale».“Il lungo XX secolo” rilegge la nostra storia recente in tre fasi distinte. La prima è quella dell’espansione finanziaria della fine del XIX e degli inizi del XX secolo, nel corso della quale «furono distrutte le strutture del ‘vecchio’ regime britannico e furono create quelle del ‘nuovo’ regime statunitense». La seconda è quella dell’espansione materiale degli anni ‘50 e ‘60, durante la quale «il dominio del ‘nuovo’ regime statunitense si tradusse in un’espansione del commercio e della produzione di dimensioni mondiali». Terza fase, l’attuale espansione finanziaria, in cui «vengono distrutte le strutture del ‘vecchio’ regime statunitense e vengono presumibilmente create quelle di un ‘nuovo’ regime». Esito finale: «L’arresto della ciclicità capitalistica, quasi come un auspicio», annota Pellizzetti. Un auspicio «lasciato sottinteso, eppure individuabile tra le pieghe della riflessione di Arrighi: il superamento di un ordine che si puntella – al tempo – sull’esclusione e sullo sfruttamento».Come lo stesso Arrighi scriveva sulla “New Left Review” del 1991, «i due processi sono distinti ma complementari», dal momento che «processi di sfruttamento forniscono agli Stati ricchi e ai loro agenti i mezzi per iniziare e mantenere processi di esclusione», che a loro volta «generano la povertà necessaria per indurre i governanti e i cittadini degli Stati relativamente poveri a cercare continuamente di rientrare in una divisione del lavoro mondiale strutturata secondo condizioni favorevoli agli Stati ricchi». Insieme all’importante trilogia di Wallerstein sul sistema-mondo (“Il sistema mondiale dell’economia moderna”, pubblicato da “Il Mulino”), il testo di Arrighi è il contributo più significativo della scuola nata sulle due sponde dell’Atlantico, conclude Pellizzetti. «Essenziale per una profonda ritaratura degli schemi concettuali che guidano la riflessione sulla crisi economica globale, a fronte della palese incapacità del pensiero dominante di interpretarne le cause, macroeconomiche e dunque sistemiche». “Il lungo XX secolo” ne mette a fuoco gli aspetti più significativi: in particolare, l’inarrestabile processo di finanziarizzazione (produzione di denaro a mezzo denaro) quale idealtipico sbocco di lungo periodo dell’economia “reale”, e le conseguenze che ne derivano per nuovi cicli di accumulazione capitalistica. Il finale è aperto: la fine del capitalismo potrebbe essere già in corso, ma il “regime” che verrà non sappiamo se sarà ancora guidato dall’Occidente o dalla Cina, a meno che il mondo non precipiti in un caos non più governabile.
Sono tre i possibili esiti per la crisi terminale della “fase americana” nel sistema-mondo: un impero a guida occidentale, virando a dominio la strapotenza militare che i pur declinanti Stati Uniti continuano a mantenere; una società di mercato globale imperniata sull’Asia orientale; e infine l’orrore di un “caos sistemico” come liquidazione di qualsivoglia forma di governance. Giovanni Arrighi ne parla nel post-scriptum de “Il lungo XX secolo”, appena ripubblicato da “Il Saggiatore”, provando a delineare il futuro del pianeta. Fino alla sua morte, nel 2009, Arrighi aveva insegnato alla State University di New York e cooperato al Fernand Braudel Center, diretto da Immanuel Wallerstein. Obiettivo dell’autore, rileva Pierfranco Pellizzetti su “Micromega”, è quello di smontare la teorizzazione di un “eterno ritorno” che connoterebbe le dinamiche del capitalismo, con una fase di creazione di ricchezza (industria e scambi), una “crisi spia” (economia in recessione), un passaggio alla finanziarizzazione (accumulazione al posto della produzione) e la “crisi terminale”, con lo spostamento della centralità geoeconomica.Il valore di un’analisi, scrive Pellizzetti, scaturisce anche dai riflessi che induce, tenendo conto delle coordinate temporali: parole in controtendenza, nell’epoca in cui «un’intellighenzia embedded della restaurazione NeoLib propugnava le tesi pericolose quanto autolesionistiche del “Nuovo Secolo Americano”, poi insabbiate in Iraq e disperse tra le giogaie afgane. Il karakiri dell’Occidente». Il testo, ora tornato in libreria dopo la prima edizione del 1994, «fornisce strumenti particolarmente utili per posizionare in una giusta prospettiva la fine dell’unilaterialismo americano, che era emerso nel dopo Guerra Fredda; tra il crollo del muro di Berlino (1989) e quello delle Torri Gemelle (2001)». Per Pellizzetti, è la questione aperta – quindi attualissima – di un mondo ormai multipolare e senza più un centro. «Un mondo dove si sono determinate rotture sistemiche che reclamano nuove categorie di analisi; e che magari suonano campane a morto per lo stesso ordine capitalistico», quello che «ha egemonizzato i tempi del mondo per l’ultimo mezzo millennio e che potrebbe persino essere giunto a una fase terminale».“Il lungo XX secolo” rilegge la nostra storia recente in tre fasi distinte. La prima è quella dell’espansione finanziaria della fine del XIX e degli inizi del XX secolo, nel corso della quale «furono distrutte le strutture del ‘vecchio’ regime britannico e furono create quelle del ‘nuovo’ regime statunitense». La seconda è quella dell’espansione materiale degli anni ‘50 e ‘60, durante la quale «il dominio del ‘nuovo’ regime statunitense si tradusse in un’espansione del commercio e della produzione di dimensioni mondiali». Terza fase, l’attuale espansione finanziaria, in cui «vengono distrutte le strutture del ‘vecchio’ regime statunitense e vengono presumibilmente create quelle di un ‘nuovo’ regime». Esito finale: «L’arresto della ciclicità capitalistica, quasi come un auspicio», annota Pellizzetti. Un auspicio «lasciato sottinteso, eppure individuabile tra le pieghe della riflessione di Arrighi: il superamento di un ordine che si puntella – al tempo – sull’esclusione e sullo sfruttamento».Come lo stesso Arrighi scriveva sulla “New Left Review” del 1991, «i due processi sono distinti ma complementari», dal momento che «processi di sfruttamento forniscono agli Stati ricchi e ai loro agenti i mezzi per iniziare e mantenere processi di esclusione», che a loro volta «generano la povertà necessaria per indurre i governanti e i cittadini degli Stati relativamente poveri a cercare continuamente di rientrare in una divisione del lavoro mondiale strutturata secondo condizioni favorevoli agli Stati ricchi». Insieme all’importante trilogia di Wallerstein sul sistema-mondo (“Il sistema mondiale dell’economia moderna”, pubblicato da “Il Mulino”), il testo di Arrighi è il contributo più significativo della scuola nata sulle due sponde dell’Atlantico, conclude Pellizzetti. «Essenziale per una profonda ritaratura degli schemi concettuali che guidano la riflessione sulla crisi economica globale, a fronte della palese incapacità del pensiero dominante di interpretarne le cause, macroeconomiche e dunque sistemiche». “Il lungo XX secolo” ne mette a fuoco gli aspetti più significativi: in particolare, l’inarrestabile processo di finanziarizzazione (produzione di denaro a mezzo denaro) quale idealtipico sbocco di lungo periodo dell’economia “reale”, e le conseguenze che ne derivano per nuovi cicli di accumulazione capitalistica. Il finale è aperto: la fine del capitalismo potrebbe essere già in corso, ma il “regime” che verrà non sappiamo se sarà ancora guidato dall’Occidente o dalla Cina, a meno che il mondo non precipiti in un caos non più governabile.Sono tre i possibili esiti per la crisi terminale della “fase americana” nel sistema-mondo: un impero a guida occidentale, virando a dominio la strapotenza militare che i pur declinanti Stati Uniti continuano a mantenere; una società di mercato globale imperniata sull’Asia orientale; e infine l’orrore di un “caos sistemico” come liquidazione di qualsivoglia forma di governance. Giovanni Arrighi ne parla nel post-scriptum de “Il lungo XX secolo”, appena ripubblicato da “Il Saggiatore”, provando a delineare il futuro del pianeta. Fino alla sua morte, nel 2009, Arrighi aveva insegnato alla State University di New York e cooperato al Fernand Braudel Center, diretto da Immanuel Wallerstein. Obiettivo dell’autore, rileva Pierfranco Pellizzetti su “Micromega”, è quello di smontare la teorizzazione di un “eterno ritorno” che connoterebbe le dinamiche del capitalismo, con una fase di creazione di ricchezza (industria e scambi), una “crisi spia” (economia in recessione), un passaggio alla finanziarizzazione (accumulazione al posto della produzione) e la “crisi terminale”, con lo spostamento della centralità geoeconomica.
-
Monbiot: di crescita si muore, stiamo esaurendo la Terra
 Immaginiamo che nel 3030 avanti Cristo tutte le ricchezze del popolo egiziano potessero entrare in un metro cubo, e supponiamo che questa ricchezza sia cresciuta del 4,5% all’anno: quanto sarebbe diventata grande al tempo della battaglia di Azio, tre milleni dopo? Dieci volte il volume delle piramidi? Tutta la sabbia del Sahara? L’Oceano Atlantico? Il volume di tutto il pianeta? Macché. Secondo il banchiere Jeremy Grantham, avremmo avuto bisogno di 2.5 miliardi di miliardi di sistemi solari. «Una volta compreso il significato e le proporzioni di questa conclusione – dice George Monbiot – non dovreste metterci molto ad arrivare alla paradossale posizione che l’unica salvezza sta nel crollo del sistema». Matematico: «Per continuare a far funzionare il sistema attuale dovremmo distruggerci da soli, ma se il sistema non funziona sarà il sistema stesso a distruggerci: questa è la spirale che abbiamo creato».Non possiamo certo ignorare il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità, l’esaurimento di acqua, suolo, minerali e petrolio. Ma anche se, per miracolo, tutti questi problemi dovessero svanire, scrive Monbiot in un post ripreso da “Come Don Chisciotte”, la semplice regola della “crescita composta” rende comunque impossibile la continuità del sistema. L’attuale crescita economica? E’ un artificio, dovuto all’uso dei combustibili fossili. «Prima che si cominciassero a estrarre grandi quantità di carbone, ogni aumento della produzione industriale coincideva con una flessione della produzione agricola, come avvenne quando il carbone e la forza motore necessari per far espandere l’industria ridussero la quantità di terreno disponibile per la coltivazione di cibo. Ogni rivoluzione industriale ha causato il crollo della situazione precedente, perché la stessa crescita non poteva essere più sostenuta. Ma il carbone ha rotto questo ciclo e ha reso possibile – per qualche centinaio di anni – quel fenomeno che oggi chiamiamo crescita sostenibile».Secondo Monbiot, a scatenare il progresso (e le sue patologie moderne: guerra totale, concentrazione della ricchezza globale, distruzione del pianeta) non sono stati né il capitalismo né il comunismo: è stato il carbone, seguito dal petrolio e dal gas. Il filo conduttore di questa espansione? L’ideologia della crescita. E ora che si stanno esaurendo le riserve accessibili, «dobbiamo saccheggiare gli angoli più nascosti del pianeta pur di sostenere la nostra proposta impraticabile». Mentre gli scienziati annunciano il crollo della calotta antartica occidentale, il governo ecuadoriano decide di consentire la trivellazione petrolifera del parco nazionale Yasuni. Il povero Ecuador, che ha chiesto 3,6 miliardi di dollari, ha invece ricevuto solo 13 milioni. Risultato: «Petroamazonas, una compagnia con un medagliere pieno di record di distruzione e rovina, ora potrà entrare in uno dei luoghi dove esiste la maggior concentrazione di biodiversità del pianeta, dove si dice che un ettaro di foresta pluviale contenga più specie di quante ne esistano nell’intero continente nordamericano».Piove sul bagnato: i petrolieri inglesi della Soco sperano di riuscire a penetrare nel Virunga, il più antico parco nazionale africano, in Congo. Il Virunga, sottolinea Monbiot, è una delle ultime roccaforti dei gorilla di montagna e degli okapi, degli scimpanzé e degli elefanti delle foreste. In Gran Bretagna, dove è stato appena idendificato un probabile giacimento di 4.4 miliardi di barili di “shale oil”, «il governo fantastica di trasformare una verdeggiante periferia in un nuovo Delta del Niger: a tal fine sta cambiando le leggi anti-dispersione per consentire la perforazione del terreno senza nessun consenso ma offrendo ricche tangenti alla popolazione del posto». Tutto vano, in ogni caso: «Lo sfruttamento di queste nuove riserve non risolverà comunque niente», dice Monbiot: «Non metteranno fine alla nostra fame di risorse, la esarbeceranno solamente».Si sta infatti avvicinando il pericolo maggiore: «La traiettoria della crescita composta (scalare) mostra che l’isterilimento del pianeta è appena iniziato. Quando il volume dell’economia globale si espande, in tutto il mondo qualsiasi cosa contenga materiale concentrato, insolito, prezioso, sarà scoperta e sfruttata, le sue risorse saranno estratte e disperse», con buona pace delle ultime meraviglie del mondo. Qualcuno, aggiunge Monbiot, ha provato a risolvere questa “equazione impossibile” con il mito della dematerializzazione, sostenendo cioè che i processi stanno diventando più efficienti e gli oggetti sempre più piccoli. Errore: «Non c’è nessun segnale che questo stia accadendo veramente. La produzione di minerale di ferro è aumentata del 180% in 10 anni. I dati commerciali delle Forest Industries dicono che il consumo di carta globale è ad un livello record e continuerà a crescere». Paradossale: «Se nell’era digitale non riusciamo nemmeno a ridurre il consumo di carta, che speranza possiamo avere per le altre materie prime?».Sembra che nessuno se ne accorga, ma una superficie sempre più vasta del pianeta viene utilizzata per le estrazioni di materiali che servono a produrre oggetti inutili, merci di lusso o destinate a trasformarsi istantaneamente in rifiuti. «Forse è sorprendente che le nostre fantasie di colonizzare lo spazio – che ci fanno capire che potremmo esportare i problemi invece di risolverli – stanno riemergendo». Secondo il filosofo Michael Rowan, l’inevitabilità della “crescita scalare” significa che, se fosse sostenibile la crescita globale prevista lo scorso anno per il 2014 (3.1%), «anche se miracolosamente riducessino il consumo di materie prime del 90%, ritarderemmo l’inevitabile di solo 75 anni». Morale: «L’efficentamento non serve a nulla se la crescita continua. Il fallimento inevitabile di una società basata sulla crescita e sulla distruzione dei sistemi viventi della Terra sono i fatti che opprimono la nostra esistenza. Come risultato, non se ne parla quasi mai». E’ il tabù del ventunesimo secolo, blindato dalla disinformazione.
Immaginiamo che nel 3030 avanti Cristo tutte le ricchezze del popolo egiziano potessero entrare in un metro cubo, e supponiamo che questa ricchezza sia cresciuta del 4,5% all’anno: quanto sarebbe diventata grande al tempo della battaglia di Azio, tre milleni dopo? Dieci volte il volume delle piramidi? Tutta la sabbia del Sahara? L’Oceano Atlantico? Il volume di tutto il pianeta? Macché. Secondo il banchiere Jeremy Grantham, avremmo avuto bisogno di 2.5 miliardi di miliardi di sistemi solari. «Una volta compreso il significato e le proporzioni di questa conclusione – dice George Monbiot – non dovreste metterci molto ad arrivare alla paradossale posizione che l’unica salvezza sta nel crollo del sistema». Matematico: «Per continuare a far funzionare il sistema attuale dovremmo distruggerci da soli, ma se il sistema non funziona sarà il sistema stesso a distruggerci: questa è la spirale che abbiamo creato».Non possiamo certo ignorare il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità, l’esaurimento di acqua, suolo, minerali e petrolio. Ma anche se, per miracolo, tutti questi problemi dovessero svanire, scrive Monbiot in un post ripreso da “Come Don Chisciotte”, la semplice regola della “crescita composta” rende comunque impossibile la continuità del sistema. L’attuale crescita economica? E’ un artificio, dovuto all’uso dei combustibili fossili. «Prima che si cominciassero a estrarre grandi quantità di carbone, ogni aumento della produzione industriale coincideva con una flessione della produzione agricola, come avvenne quando il carbone e la forza motore necessari per far espandere l’industria ridussero la quantità di terreno disponibile per la coltivazione di cibo. Ogni rivoluzione industriale ha causato il crollo della situazione precedente, perché la stessa crescita non poteva essere più sostenuta. Ma il carbone ha rotto questo ciclo e ha reso possibile – per qualche centinaio di anni – quel fenomeno che oggi chiamiamo crescita sostenibile».Secondo Monbiot, a scatenare il progresso (e le sue patologie moderne: guerra totale, concentrazione della ricchezza globale, distruzione del pianeta) non sono stati né il capitalismo né il comunismo: è stato il carbone, seguito dal petrolio e dal gas. Il filo conduttore di questa espansione? L’ideologia della crescita. E ora che si stanno esaurendo le riserve accessibili, «dobbiamo saccheggiare gli angoli più nascosti del pianeta pur di sostenere la nostra proposta impraticabile». Mentre gli scienziati annunciano il crollo della calotta antartica occidentale, il governo ecuadoriano decide di consentire la trivellazione petrolifera del parco nazionale Yasuni. Il povero Ecuador, che ha chiesto 3,6 miliardi di dollari, ha invece ricevuto solo 13 milioni. Risultato: «Petroamazonas, una compagnia con un medagliere pieno di record di distruzione e rovina, ora potrà entrare in uno dei luoghi dove esiste la maggior concentrazione di biodiversità del pianeta, dove si dice che un ettaro di foresta pluviale contenga più specie di quante ne esistano nell’intero continente nordamericano».Piove sul bagnato: i petrolieri inglesi della Soco sperano di riuscire a penetrare nel Virunga, il più antico parco nazionale africano, in Congo. Il Virunga, sottolinea Monbiot, è una delle ultime roccaforti dei gorilla di montagna e degli okapi, degli scimpanzé e degli elefanti delle foreste. In Gran Bretagna, dove è stato appena idendificato un probabile giacimento di 4.4 miliardi di barili di “shale oil”, «il governo fantastica di trasformare una verdeggiante periferia in un nuovo Delta del Niger: a tal fine sta cambiando le leggi anti-dispersione per consentire la perforazione del terreno senza nessun consenso ma offrendo ricche tangenti alla popolazione del posto». Tutto vano, in ogni caso: «Lo sfruttamento di queste nuove riserve non risolverà comunque niente», dice Monbiot: «Non metteranno fine alla nostra fame di risorse, la esarbeceranno solamente».Si sta infatti avvicinando il pericolo maggiore: «La traiettoria della crescita composta (scalare) mostra che l’isterilimento del pianeta è appena iniziato. Quando il volume dell’economia globale si espande, in tutto il mondo qualsiasi cosa contenga materiale concentrato, insolito, prezioso, sarà scoperta e sfruttata, le sue risorse saranno estratte e disperse», con buona pace delle ultime meraviglie del mondo. Qualcuno, aggiunge Monbiot, ha provato a risolvere questa “equazione impossibile” con il mito della dematerializzazione, sostenendo cioè che i processi stanno diventando più efficienti e gli oggetti sempre più piccoli. Errore: «Non c’è nessun segnale che questo stia accadendo veramente. La produzione di minerale di ferro è aumentata del 180% in 10 anni. I dati commerciali delle Forest Industries dicono che il consumo di carta globale è ad un livello record e continuerà a crescere». Paradossale: «Se nell’era digitale non riusciamo nemmeno a ridurre il consumo di carta, che speranza possiamo avere per le altre materie prime?».Sembra che nessuno se ne accorga, ma una superficie sempre più vasta del pianeta viene utilizzata per le estrazioni di materiali che servono a produrre oggetti inutili, merci di lusso o destinate a trasformarsi istantaneamente in rifiuti. «Forse è sorprendente che le nostre fantasie di colonizzare lo spazio – che ci fanno capire che potremmo esportare i problemi invece di risolverli – stanno riemergendo». Secondo il filosofo Michael Rowan, l’inevitabilità della “crescita scalare” significa che, se fosse sostenibile la crescita globale prevista lo scorso anno per il 2014 (3.1%), «anche se miracolosamente riducessino il consumo di materie prime del 90%, ritarderemmo l’inevitabile di solo 75 anni». Morale: «L’efficentamento non serve a nulla se la crescita continua. Il fallimento inevitabile di una società basata sulla crescita e sulla distruzione dei sistemi viventi della Terra sono i fatti che opprimono la nostra esistenza. Come risultato, non se ne parla quasi mai». E’ il tabù del ventunesimo secolo, blindato dalla disinformazione.Immaginiamo che nel 3030 avanti Cristo tutte le ricchezze del popolo egiziano potessero entrare in un metro cubo, e supponiamo che questa ricchezza sia cresciuta del 4,5% all’anno: quanto sarebbe diventata grande al tempo della battaglia di Azio, tre milleni dopo? Dieci volte il volume delle piramidi? Tutta la sabbia del Sahara? L’Oceano Atlantico? Il volume di tutto il pianeta? Macché. Secondo il banchiere Jeremy Grantham, avremmo avuto bisogno di 2.5 miliardi di miliardi di sistemi solari. «Una volta compreso il significato e le proporzioni di questa conclusione – dice George Monbiot – non dovreste metterci molto ad arrivare alla paradossale posizione che l’unica salvezza sta nel crollo del sistema». Matematico: «Per continuare a far funzionare il sistema attuale dovremmo distruggerci da soli, ma se il sistema non funziona sarà il sistema stesso a distruggerci: questa è la spirale che abbiamo creato».
-
Io borghese di merda e tutti noi scarafaggi da schiacciare
 «Ma tu non eri di sinistra?», mi chiedeva con preoccupazione un mio follower twittarolo stamattina. Il fatto è, caro, che prima di tutto io sono una borghese di merda, e proprio per questo a vent’anni ero comunista. Non c’è da stupirsene perché sono i borghesi che scelgono la bandiera rossa senza averne la necessità. Marx, Lenin, Trockij, Che Guevara, Fidel Castro, erano tutti borghesi, perché è la borghesia che, quando l’élite esagera, che si tratti di incipriati aristocratici e pretacci o di latifondisti, capitalisti e padroni delle ferriere, fa le rivoluzioni. Sono stata di sinistra per un lungo tempo, prima che saltassero tutte le regole su chi dovesse stare dalla parte del popolo e chi invece doveva vendersi al Capitale. Perché qualcosa è successo, darling. Più o meno attorno al Sessantotto. E’ stato un processo lungo e difficile da allora, ma sta giungendo a compimento. La più grande operazione di pulizia sociale della storia. La fine della lotta di classe con la proclamazione del Capitale come vincitore. With a little help from his friends.Ti spiego il mio percorso. Sono una borghese, dicevo, e la mia è la classe media che, ad un certo punto, nel secolo scorso, è riuscita storicamente ad inglobare emancipandola anche tanta parte della classe operaia. Merito delle lotte dei borghesi dalla coscienza infelice di cui sopra, condotte assieme agli operai, certo, ma anche di un capitalismo che pensava che estendere la ricchezza a fasce più ampie della popolazione, facendo diventare i proletari classe media, significava più merci vendute, più profitti e più benessere per tutti. Il famigerato moltiplicatore. Ma già, Henry Ford era un nazifascista anche se pensava che aumentando il salario ai suoi operai questi avrebbero potuto comperare il modello T che fabbricavano. Quello della mia gioventù sembra un mondo perduto ed estinto; una meraviglia, sai, in confronto a quello di oggi. E sono sicura che te ne ricordi, perché non sei di primo pelo neppure tu.Uno stipendio in famiglia bastava a condurre una vita più che dignitosa dove non ti mancava nulla di veramente necessario. Esisteva ancora il concetto di superfluo e per quello c’era il «no, non ce lo possiamo permettere». Quel no ti aiutava a crescere e a capire che, una volta grande, te lo saresti guadagnato con il tuo lavoro, perché il lavoro ci sarebbe stato, secondo quello che avevi studiato e imparato a fare. Perfino con uno stipendio solo, con i risparmi (allora si riusciva a mettere da parte qualcosa ogni mese), la famiglia riusciva a comperarsi la casa dove viveva e, se lavoravano tutti e due i genitori, ci si comperava magari un’altra casa, al mare o in campagna o in montagna. Perché allora esistevano ancora le ferie e le vacanze non duravano meno di venti giorni. Per le malattie c’era il welfare, ad una certa età arrivavano la pensione e la liquidazione con la quale ti potevi togliere qualche sfizio in più o farti la casetta di cui sopra, perché i nonni non erano costretti a mantenere nipoti disoccupati.Erano i tempi in cui l’Italia stava diventando, pur tra corruzione, mafia e caste, e sottoposta a sovranità limitata come paese sconfitto, la quinta potenza industriale del mondo. Non erano tutte rose e fiori? Certo, c’erano come sempre i poveri e lo sfruttamento, il mondo era diviso in classi. C’erano la crisi petrolifera, il terrorismo di Stato, le bombe, le guerre imperialiste. Poi arrivò la shock economy, prima dal Sudamerica (però così lontano da noi) e poi nel mondo anglosassone, con i primi vagiti del dominio finanziario sulle nostre vite; ma la speranza di un futuro migliore non mancava, nessuno pensava che, pur lavorando da rompersi la schiena, da vecchio sarebbe stato povero e abbandonato perché gli avrebbero portato via tutto. Non avevamo nulla da perdere, casomai ci sarebbe stato ancora qualcosa da ottenere. Il muro nero della depressione, dell’assenza di un futuro o dell’angoscia data dal pensiero di che cosa sarà il nostro futuro in balia della povertà non esisteva e nessuno sarebbe stato in grado di immaginarlo, a meno che non fosse vissuto al di là di qualche Cortina di Ferro.Soprattutto, nessuno si sarebbe mai immaginato che il benessere ottenuto in base alle lotte sindacali, nato dal sangue degli operai e di quei borghesi empatici e simboleggiato in maniera sacra dalla democrazia, dato ormai per acquisito perché certificato nella Costituzione, sarebbe stato possibile toglierlo al popolo per consegnarlo ad un’élite intenzionata a redistribuire la ricchezza esistente verso l’alto, accaparrandosela tutta e creando un mondo dove l’1% ha tutto e il 99% quasi nulla, senza più democrazia. Un mondo nuovo ma tremendamente simile al Medioevo che, per essere realizzato, ormai lo sappiamo, nei trent’anni previsti per il suo compimento non potrà che finire con l’eliminazione fisica della classe media, magari sostituita da carne da macello proveniente dal terzo mondo, da impiegare per la pulitura dei cessi dove andranno a sedersi i culi imperiali.Credo che, se qualcuno allora, negli anni sessanta-settanta, avesse visto un’anteprima del futuro, ovvero dei giorni nostri, lo avrebbe considerato il peggiore incubo mai vissuto e nessuno avrebbe potuto immaginare che coloro che si sarebbero offerti spontaneamente per farlo avverare sarebbero stati i partiti di sinistra, quelli più tradizionalmente (allora) vicini al popolo. Eccoci, caro, al perché io non sono più comunista, non sono più di sinistra, anzi non sono niente, sono solo una borghese di merda ma molto, molto incazzata. Sono incazzata e mi difenderò fino all’ultimo perché vogliono farmi fuori. Vogliono portarmi via ciò che la mia famiglia mi ha lasciato, affinché, assieme a ciò che mi guadagno con il mio lavoro, potessi avere una vecchiaia serena senza dover dipendere da nessuno. Penso a me stessa, certo. Gli altri hanno smesso di pensare a me.Ti pare impossibile che l’orrendo scenario che ti ho descritto possa realizzarsi? Cosa ti stanno ripetendo giorno e notte, tutti i giorni e a tutte le ore, caro amico? Che quel mondo che ti ho descritto e che abbiamo vissuto, che ci ha permesso di crescere ed arrivare fin qui dobbiamo scordarcelo perché NON POSSIAMO PIU’ PERMETTERCELO. E, di grazia, ti stai chiedendo il PERCHE’? Perché le risorse mondiali sono limitate? Per quello basterebbe uno sviluppo più responsabile. Basterebbe quella cosa che si chiama progresso e che nasce dall’ingegno di persone molto creative in ogni epoca e che in poco più di cento anni ci hanno dato l’elettricità, la mobilità di persone e merci e la comunicazione. Progresso che serve da sempre a migliorare la vita delle persone e a renderla più facile. Basterebbe tendere a realizzare uno di quei mondi futuribili ideali che nessun romanzo di fantascienza ha più il coraggio di immaginare.Il nostro benessere non possiamo più permettercelo perché ciò che abbiamo lo vuole qualcun altro, e non sono certo coloro che non hanno nulla ma quelli che hanno già tutto. Vedi, in fondo, da borghese di merda, con queste parole sto pensando anche a te, sto cercando di avvertirti del pericolo, anche se non meriteresti affatto di essere salvato. Non sono direttamente le élite che ti annunciano la fine del tuo diritto al benessere perché un domani conterà solo il loro, perché la scusa delle risorse limitate è un’occasione ghiotta per fare un po’ di pulizia sociale e vincere la Lotta di Classe. Te lo fanno dire dai loro servi. Quelli che si sentono superiori perché non sono razzisti ma democratici, a favore delle minoranze, antifascisti, ammiratori dell’Europa e della serietà teutonica, progressisti, internazionalisti, contro tutte le diversità perché devoti all’OMOLOGAZIONE. Che si sentono importanti perché con il 99% possono masturbarsi sulle grandi cifre e non si accorgono che la loro maggioranza è destinata a diventare il Soylent Green. Sono quelli che ogni mattina ringraziano non si sa chi per non essersi svegliati trasformati in scarafaggi piccoloborghesi.Quando tutto iniziò, con i primi attacchi ai diritti sociali acquisiti e l’avvento della dittatura del mercato, avrebbero dovuto riconoscere subito il progetto reazionario e revanchista dell’élite. Certo avrebbero dovuto difendere il benessere generale, le conquiste ottenute fino a quel momento e la democrazia, distinguendo tra capitalismo accettabile e capitalismo disumano, alleandosi con quella borghesia di merda che però sa fare le rivoluzioni e che un minimo di riconoscenza se la meriterebbe. Invece, pur di non rinnegare la lotta antiborghese di principio, hanno ascoltato le sirene della globalizzazione travestita da internazionalismo ed hanno scelto l’omologazione nel concime, il “semo tutti uguali” come materia organica anfibia, per potere essere ancora più merda della borghesia e in fondo distinguersi. Perché in fondo sono dei neoaristocratici pure loro. Si sono alleati con il Capitale contro il resto del mondo e di fatto contro loro stessi. Perché credono di appartenere ad un corpo speciale e privilegiato per essersi guadagnati con il tradimento l’onore di poter dare il colpo di grazia all’odiata borghesia (rinnegando Marx, Lenin e gli altri che ho nominato) ma sono anche loro feccia destinata a soccombere. Li tengono per ultimi per compostarli meglio. Concimeranno con onore i giardini degli ingiusti di Elysium.(Barbara Tampieri, “Io sono una borghese di merda”, da “Il blog di Lameduck” del 29 maggio 2014, ripreso da “Come Don Chisciotte).
«Ma tu non eri di sinistra?», mi chiedeva con preoccupazione un mio follower twittarolo stamattina. Il fatto è, caro, che prima di tutto io sono una borghese di merda, e proprio per questo a vent’anni ero comunista. Non c’è da stupirsene perché sono i borghesi che scelgono la bandiera rossa senza averne la necessità. Marx, Lenin, Trockij, Che Guevara, Fidel Castro, erano tutti borghesi, perché è la borghesia che, quando l’élite esagera, che si tratti di incipriati aristocratici e pretacci o di latifondisti, capitalisti e padroni delle ferriere, fa le rivoluzioni. Sono stata di sinistra per un lungo tempo, prima che saltassero tutte le regole su chi dovesse stare dalla parte del popolo e chi invece doveva vendersi al Capitale. Perché qualcosa è successo, darling. Più o meno attorno al Sessantotto. E’ stato un processo lungo e difficile da allora, ma sta giungendo a compimento. La più grande operazione di pulizia sociale della storia. La fine della lotta di classe con la proclamazione del Capitale come vincitore. With a little help from his friends.Ti spiego il mio percorso. Sono una borghese, dicevo, e la mia è la classe media che, ad un certo punto, nel secolo scorso, è riuscita storicamente ad inglobare emancipandola anche tanta parte della classe operaia. Merito delle lotte dei borghesi dalla coscienza infelice di cui sopra, condotte assieme agli operai, certo, ma anche di un capitalismo che pensava che estendere la ricchezza a fasce più ampie della popolazione, facendo diventare i proletari classe media, significava più merci vendute, più profitti e più benessere per tutti. Il famigerato moltiplicatore. Ma già, Henry Ford era un nazifascista anche se pensava che aumentando il salario ai suoi operai questi avrebbero potuto comperare il modello T che fabbricavano. Quello della mia gioventù sembra un mondo perduto ed estinto; una meraviglia, sai, in confronto a quello di oggi. E sono sicura che te ne ricordi, perché non sei di primo pelo neppure tu.Uno stipendio in famiglia bastava a condurre una vita più che dignitosa dove non ti mancava nulla di veramente necessario. Esisteva ancora il concetto di superfluo e per quello c’era il «no, non ce lo possiamo permettere». Quel no ti aiutava a crescere e a capire che, una volta grande, te lo saresti guadagnato con il tuo lavoro, perché il lavoro ci sarebbe stato, secondo quello che avevi studiato e imparato a fare. Perfino con uno stipendio solo, con i risparmi (allora si riusciva a mettere da parte qualcosa ogni mese), la famiglia riusciva a comperarsi la casa dove viveva e, se lavoravano tutti e due i genitori, ci si comperava magari un’altra casa, al mare o in campagna o in montagna. Perché allora esistevano ancora le ferie e le vacanze non duravano meno di venti giorni. Per le malattie c’era il welfare, ad una certa età arrivavano la pensione e la liquidazione con la quale ti potevi togliere qualche sfizio in più o farti la casetta di cui sopra, perché i nonni non erano costretti a mantenere nipoti disoccupati.Erano i tempi in cui l’Italia stava diventando, pur tra corruzione, mafia e caste, e sottoposta a sovranità limitata come paese sconfitto, la quinta potenza industriale del mondo. Non erano tutte rose e fiori? Certo, c’erano come sempre i poveri e lo sfruttamento, il mondo era diviso in classi. C’erano la crisi petrolifera, il terrorismo di Stato, le bombe, le guerre imperialiste. Poi arrivò la shock economy, prima dal Sudamerica (però così lontano da noi) e poi nel mondo anglosassone, con i primi vagiti del dominio finanziario sulle nostre vite; ma la speranza di un futuro migliore non mancava, nessuno pensava che, pur lavorando da rompersi la schiena, da vecchio sarebbe stato povero e abbandonato perché gli avrebbero portato via tutto. Non avevamo nulla da perdere, casomai ci sarebbe stato ancora qualcosa da ottenere. Il muro nero della depressione, dell’assenza di un futuro o dell’angoscia data dal pensiero di che cosa sarà il nostro futuro in balia della povertà non esisteva e nessuno sarebbe stato in grado di immaginarlo, a meno che non fosse vissuto al di là di qualche Cortina di Ferro.Soprattutto, nessuno si sarebbe mai immaginato che il benessere ottenuto in base alle lotte sindacali, nato dal sangue degli operai e di quei borghesi empatici e simboleggiato in maniera sacra dalla democrazia, dato ormai per acquisito perché certificato nella Costituzione, sarebbe stato possibile toglierlo al popolo per consegnarlo ad un’élite intenzionata a redistribuire la ricchezza esistente verso l’alto, accaparrandosela tutta e creando un mondo dove l’1% ha tutto e il 99% quasi nulla, senza più democrazia. Un mondo nuovo ma tremendamente simile al Medioevo che, per essere realizzato, ormai lo sappiamo, nei trent’anni previsti per il suo compimento non potrà che finire con l’eliminazione fisica della classe media, magari sostituita da carne da macello proveniente dal terzo mondo, da impiegare per la pulitura dei cessi dove andranno a sedersi i culi imperiali.Credo che, se qualcuno allora, negli anni sessanta-settanta, avesse visto un’anteprima del futuro, ovvero dei giorni nostri, lo avrebbe considerato il peggiore incubo mai vissuto e nessuno avrebbe potuto immaginare che coloro che si sarebbero offerti spontaneamente per farlo avverare sarebbero stati i partiti di sinistra, quelli più tradizionalmente (allora) vicini al popolo. Eccoci, caro, al perché io non sono più comunista, non sono più di sinistra, anzi non sono niente, sono solo una borghese di merda ma molto, molto incazzata. Sono incazzata e mi difenderò fino all’ultimo perché vogliono farmi fuori. Vogliono portarmi via ciò che la mia famiglia mi ha lasciato, affinché, assieme a ciò che mi guadagno con il mio lavoro, potessi avere una vecchiaia serena senza dover dipendere da nessuno. Penso a me stessa, certo. Gli altri hanno smesso di pensare a me.Ti pare impossibile che l’orrendo scenario che ti ho descritto possa realizzarsi? Cosa ti stanno ripetendo giorno e notte, tutti i giorni e a tutte le ore, caro amico? Che quel mondo che ti ho descritto e che abbiamo vissuto, che ci ha permesso di crescere ed arrivare fin qui dobbiamo scordarcelo perché NON POSSIAMO PIU’ PERMETTERCELO. E, di grazia, ti stai chiedendo il PERCHE’? Perché le risorse mondiali sono limitate? Per quello basterebbe uno sviluppo più responsabile. Basterebbe quella cosa che si chiama progresso e che nasce dall’ingegno di persone molto creative in ogni epoca e che in poco più di cento anni ci hanno dato l’elettricità, la mobilità di persone e merci e la comunicazione. Progresso che serve da sempre a migliorare la vita delle persone e a renderla più facile. Basterebbe tendere a realizzare uno di quei mondi futuribili ideali che nessun romanzo di fantascienza ha più il coraggio di immaginare.Il nostro benessere non possiamo più permettercelo perché ciò che abbiamo lo vuole qualcun altro, e non sono certo coloro che non hanno nulla ma quelli che hanno già tutto. Vedi, in fondo, da borghese di merda, con queste parole sto pensando anche a te, sto cercando di avvertirti del pericolo, anche se non meriteresti affatto di essere salvato. Non sono direttamente le élite che ti annunciano la fine del tuo diritto al benessere perché un domani conterà solo il loro, perché la scusa delle risorse limitate è un’occasione ghiotta per fare un po’ di pulizia sociale e vincere la Lotta di Classe. Te lo fanno dire dai loro servi. Quelli che si sentono superiori perché non sono razzisti ma democratici, a favore delle minoranze, antifascisti, ammiratori dell’Europa e della serietà teutonica, progressisti, internazionalisti, contro tutte le diversità perché devoti all’OMOLOGAZIONE. Che si sentono importanti perché con il 99% possono masturbarsi sulle grandi cifre e non si accorgono che la loro maggioranza è destinata a diventare il Soylent Green. Sono quelli che ogni mattina ringraziano non si sa chi per non essersi svegliati trasformati in scarafaggi piccoloborghesi.Quando tutto iniziò, con i primi attacchi ai diritti sociali acquisiti e l’avvento della dittatura del mercato, avrebbero dovuto riconoscere subito il progetto reazionario e revanchista dell’élite. Certo avrebbero dovuto difendere il benessere generale, le conquiste ottenute fino a quel momento e la democrazia, distinguendo tra capitalismo accettabile e capitalismo disumano, alleandosi con quella borghesia di merda che però sa fare le rivoluzioni e che un minimo di riconoscenza se la meriterebbe. Invece, pur di non rinnegare la lotta antiborghese di principio, hanno ascoltato le sirene della globalizzazione travestita da internazionalismo ed hanno scelto l’omologazione nel concime, il “semo tutti uguali” come materia organica anfibia, per potere essere ancora più merda della borghesia e in fondo distinguersi. Perché in fondo sono dei neoaristocratici pure loro. Si sono alleati con il Capitale contro il resto del mondo e di fatto contro loro stessi. Perché credono di appartenere ad un corpo speciale e privilegiato per essersi guadagnati con il tradimento l’onore di poter dare il colpo di grazia all’odiata borghesia (rinnegando Marx, Lenin e gli altri che ho nominato) ma sono anche loro feccia destinata a soccombere. Li tengono per ultimi per compostarli meglio. Concimeranno con onore i giardini degli ingiusti di Elysium.(Barbara Tampieri, “Io sono una borghese di merda”, da “Il blog di Lameduck” del 29 maggio 2014, ripreso da “Come Don Chisciotte).«Ma tu non eri di sinistra?», mi chiedeva con preoccupazione un mio follower twittarolo stamattina. Il fatto è, caro, che prima di tutto io sono una borghese di merda, e proprio per questo a vent’anni ero comunista. Non c’è da stupirsene perché sono i borghesi che scelgono la bandiera rossa senza averne la necessità. Marx, Lenin, Trockij, Che Guevara, Fidel Castro, erano tutti borghesi, perché è la borghesia che, quando l’élite esagera, che si tratti di incipriati aristocratici e pretacci o di latifondisti, capitalisti e padroni delle ferriere, fa le rivoluzioni. Sono stata di sinistra per un lungo tempo, prima che saltassero tutte le regole su chi dovesse stare dalla parte del popolo e chi invece doveva vendersi al Capitale. Perché qualcosa è successo, darling. Più o meno attorno al Sessantotto. E’ stato un processo lungo e difficile da allora, ma sta giungendo a compimento. La più grande operazione di pulizia sociale della storia. La fine della lotta di classe con la proclamazione del Capitale come vincitore. With a little help from his friends.
-
Internet per ricchi: i loro contenuti, veloci e costosi
 «Immaginate un’autostrada con la corsia di sorpasso riservata ai soli proprietari di Mercedes e Bmw. Perché nel prezzo d’acquisto delle loro auto è incluso quel privilegio. Oppure, forse peggio ancora, la corsia veloce riservata a un paio di società multinazionali che gestiscono flotte di Tir, e hanno comprato quel diritto a farli circolare molto più in fretta di voi». Questo, avverte Federico Rampini, può accadere ben presto per la più importante di tutte le autostrade: Internet. La Rete da cui transita l’informazione, la comunicazione, ormai quasi ogni servizio essenziale, avrà qualità e servizi diversi. «Due velocità, per ricchi e poveri. È questa la conseguenza di una nuova normativa che sta per prendere forma negli Stati Uniti, la nazione che ha dato al mondo l’infrastruttura portante dell’èra digitale». Associazioni dei consumatori in rivolta, col mondo dei media dalla loro parte «nel denunciare la fine imminente di un principio che sembrava sacro: la Net Neutrality, la neutralità della Rete».Da un quarto di secolo, dalla nascita di Internet, il digitale ha avuto una sua ideologia egualitaria, l’idea cioè che Internet fosse potenzialmente “il grande livellatore”, che l’accesso alla conoscenza potesse abbattere barriere e diseguaglianze? Ora, scrive Rampini in un reportage su “Repubblica” ripreso da “Micromega”, il principio stesso che siamo tutti uguali quando ci colleghiamo online, sta vacillando. «La novità non sarà visibile a occhio nudo, anzi sarà ben nascosta per l’utente medio». Infatti non si parla di tariffe differenziate per chi vuole accesso alla banda larga, a una connessione Internet più veloce e potente, differenziazioni peraltro già diffuse grazie al ruolo sempre più dominante degli smartphone come strumento di accesso a Internet. La battaglia che si è aperta riguarda l’altra estremità della Rete: i colossi che l’alimentano di contenuti, e gli altri colossi che gestiscono l’infrastruttura stessa.In America – e quindi, a cascata, nel mondo intero – è uno scontro fra titani: da una parte le telecom (Comcast, Verizon, At&t, TimeWarner) che quasi sempre sono anche i gestori della cable-tv e degli accessi Internet, e dall’altra Google con la sua filiale YouTube, il numero uno dei servizi di videostreaming Netflix, la Walt Disney, Microsoft con Skype, Apple con iTunes. «Sono questi ultimi – scrive Rampini – i colossi che distribuiscono contenuti: informazione, comunicazione, spettacolo, musica». La “santa alleanza” delle telecom preme da anni sulle authority Usa, per spuntare il diritto a far pagare di più questi maxiutenti. «L’argomento ha una sua logica: se Google con YouTube “occupa” una parte consistente della banda larga, chi gestisce l’infrastruttura vuole fargli pagare questo volume di traffico da smaltire ad alta velocità». La posizione delle telecom ha fatto breccia, e ora la svolta viene data per certa. “Presto avremo le corsie veloci per il traffico online”, intitola il “New York Times”.Fin qui, aggiunge Rampini, sembra una contesa tra i big del capitalismo americano: la posta in gioco, in apparenza, è solo una redistribuzione di guadagni fra di loro. Ma non la pensa affatto così un paladino degli utenti online, Todd O’Boyle, che dirige la Common Cause’s Media and Democracy Reform Initiative. Secondo O’Boyle, «agli americani fu promesso fin dalle origini un Internet senza caselli né pedaggi atostradali, senza corsie preferenziali, senza censure statali o private; se passano queste nuove regole la promessa sarà tradita». È dello stesso parere un altro difensore dei consumatori, Michael Weinberg dell’associazione Public Knowledge: «Si va verso una discriminazione commerciale, l’opposto della neutralità di Internet che si fonda sulla non-discriminazione».In che modo sarebbero colpiti i consumatori, gli utenti finali? «Anzitutto – spiega Rampini – se vince la lobby delle telecom e quindi conquista il diritto di prelevare tariffe diverse da Google e Amazon, non c’è da illudersi su chi pagherà il conto: sempre noi, perché ovviamente grandi gruppi come Google e Amazon scaricheranno il sovrapprezzo sull’utente finale». Altre conseguenze dannose sono addirittura più subdole, aggiunge il corrispondente di “Repubblica”: «È ovvio che in cambio della tariffa superiore, i big dell’economia digitale avranno diritto a un servizio migliore. È una distorsione piena di pericoli. Anzitutto perché noi stessi non ci accorgeremo, quando navighiamo in Rete, che alcuni giganti del commercio online o “aggregatori d’informazione” arrivano a noi molto più velocemente coi loro contenuti. Crederemo di andare su Internet in cerca di qualcosa, in realtà sarà “qualcosa” a trovare noi molto a scapito di altri contenuti forse migliori e più utili».Infine, una «minaccia enorme» incombe sui piccoli operatori: aziende locali, startup, giovani con idee innovative, creatori di contenuto originale (filmati, musiche, informazione, e-book). Per i loro siti, «l’accesso al pubblico finale sarà tutto in salita, perché verranno confinati nelle corsie lente, superati dalle colonne di Tir che trasportano i servizi di YouTube, Amazon, Netflix, Skype, Ebay, Disney». Le nuove regole, ribadisce Weinberg, imporranno un prezzo d’ingresso e quindi una barriera d’entrata, contro l’innovazione. Se fosse esistito un Internet a due velocità fin dalle origini, forse Microsoft avrebbe impedito l’emergere di rivali come Apple? Una delle forze della Silicon Valley è stata la “distruzione creatrice” che sconvolge periodicamente le gerarchie di potere, con dei ventenni che inventano una nuova azienda e sfidano i giganti già esistenti. Finita la Net neutrality, in una Rete a due velocità vinceranno sempre gli stessi?Uno scontro simile, conclude Rampini, si sta riproducendo in Europa. L’inglese Vodafone e la tedesca Deutsche Telekom imitano le loro sorelle americane: vogliono far pagare a Google e Netflix una tariffa superiore per l’uso intenso delle infrastrutture, inondate di video-streaming. Argomento insidioso: sostengono che, in mancanza di adegaumenti tariffari, non avrebbero incentivi a investire per modernizzare la Rete, facendo perdere terreno all’Europa rispetto agli Usa e all’Asia. Poi la trasparenza: le “corsie preferenziali” di fatto esisterebbero già, perché gli operatori di telefonia e Internet favoriscono più o meno occultamente l’accesso alle proprie consociate e filiali, per esempio boicottando Skype in Europa o rallentando vistosamente i film di Netflix per chi cerca di scaricarli dalla rete TimeWarner che ha la sua offerta di videonoleggio concorrente. Sancire l’esistenza della “corsia veloce” alla luce del sole renderebbe le cose più trasparenti? Finora l’Ue ha scelto di difendere la neutralità di Internet. Per il giurista americano Tim Wu, se si abbandona la neutralità «anche Internet diventerà omologato ad ogni altro aspetto della società americana: sarà diseguale, e per ciò stesso una minaccia alla nostra prosperità nel lungo termine».
«Immaginate un’autostrada con la corsia di sorpasso riservata ai soli proprietari di Mercedes e Bmw. Perché nel prezzo d’acquisto delle loro auto è incluso quel privilegio. Oppure, forse peggio ancora, la corsia veloce riservata a un paio di società multinazionali che gestiscono flotte di Tir, e hanno comprato quel diritto a farli circolare molto più in fretta di voi». Questo, avverte Federico Rampini, può accadere ben presto per la più importante di tutte le autostrade: Internet. La Rete da cui transita l’informazione, la comunicazione, ormai quasi ogni servizio essenziale, avrà qualità e servizi diversi. «Due velocità, per ricchi e poveri. È questa la conseguenza di una nuova normativa che sta per prendere forma negli Stati Uniti, la nazione che ha dato al mondo l’infrastruttura portante dell’èra digitale». Associazioni dei consumatori in rivolta, col mondo dei media dalla loro parte «nel denunciare la fine imminente di un principio che sembrava sacro: la Net Neutrality, la neutralità della Rete».Da un quarto di secolo, dalla nascita di Internet, il digitale ha avuto una sua ideologia egualitaria, l’idea cioè che Internet fosse potenzialmente “il grande livellatore”, che l’accesso alla conoscenza potesse abbattere barriere e diseguaglianze? Ora, scrive Rampini in un reportage su “Repubblica” ripreso da “Micromega”, il principio stesso che siamo tutti uguali quando ci colleghiamo online, sta vacillando. «La novità non sarà visibile a occhio nudo, anzi sarà ben nascosta per l’utente medio». Infatti non si parla di tariffe differenziate per chi vuole accesso alla banda larga, a una connessione Internet più veloce e potente, differenziazioni peraltro già diffuse grazie al ruolo sempre più dominante degli smartphone come strumento di accesso a Internet. La battaglia che si è aperta riguarda l’altra estremità della Rete: i colossi che l’alimentano di contenuti, e gli altri colossi che gestiscono l’infrastruttura stessa.In America – e quindi, a cascata, nel mondo intero – è uno scontro fra titani: da una parte le telecom (Comcast, Verizon, At&t, TimeWarner) che quasi sempre sono anche i gestori della cable-tv e degli accessi Internet, e dall’altra Google con la sua filiale YouTube, il numero uno dei servizi di videostreaming Netflix, la Walt Disney, Microsoft con Skype, Apple con iTunes. «Sono questi ultimi – scrive Rampini – i colossi che distribuiscono contenuti: informazione, comunicazione, spettacolo, musica». La “santa alleanza” delle telecom preme da anni sulle authority Usa, per spuntare il diritto a far pagare di più questi maxiutenti. «L’argomento ha una sua logica: se Google con YouTube “occupa” una parte consistente della banda larga, chi gestisce l’infrastruttura vuole fargli pagare questo volume di traffico da smaltire ad alta velocità». La posizione delle telecom ha fatto breccia, e ora la svolta viene data per certa. “Presto avremo le corsie veloci per il traffico online”, intitola il “New York Times”.Fin qui, aggiunge Rampini, sembra una contesa tra i big del capitalismo americano: la posta in gioco, in apparenza, è solo una redistribuzione di guadagni fra di loro. Ma non la pensa affatto così un paladino degli utenti online, Todd O’Boyle, che dirige la Common Cause’s Media and Democracy Reform Initiative. Secondo O’Boyle, «agli americani fu promesso fin dalle origini un Internet senza caselli né pedaggi atostradali, senza corsie preferenziali, senza censure statali o private; se passano queste nuove regole la promessa sarà tradita». È dello stesso parere un altro difensore dei consumatori, Michael Weinberg dell’associazione Public Knowledge: «Si va verso una discriminazione commerciale, l’opposto della neutralità di Internet che si fonda sulla non-discriminazione».In che modo sarebbero colpiti i consumatori, gli utenti finali? «Anzitutto – spiega Rampini – se vince la lobby delle telecom e quindi conquista il diritto di prelevare tariffe diverse da Google e Amazon, non c’è da illudersi su chi pagherà il conto: sempre noi, perché ovviamente grandi gruppi come Google e Amazon scaricheranno il sovrapprezzo sull’utente finale». Altre conseguenze dannose sono addirittura più subdole, aggiunge il corrispondente di “Repubblica”: «È ovvio che in cambio della tariffa superiore, i big dell’economia digitale avranno diritto a un servizio migliore. È una distorsione piena di pericoli. Anzitutto perché noi stessi non ci accorgeremo, quando navighiamo in Rete, che alcuni giganti del commercio online o “aggregatori d’informazione” arrivano a noi molto più velocemente coi loro contenuti. Crederemo di andare su Internet in cerca di qualcosa, in realtà sarà “qualcosa” a trovare noi molto a scapito di altri contenuti forse migliori e più utili».Infine, una «minaccia enorme» incombe sui piccoli operatori: aziende locali, startup, giovani con idee innovative, creatori di contenuto originale (filmati, musiche, informazione, e-book). Per i loro siti, «l’accesso al pubblico finale sarà tutto in salita, perché verranno confinati nelle corsie lente, superati dalle colonne di Tir che trasportano i servizi di YouTube, Amazon, Netflix, Skype, Ebay, Disney». Le nuove regole, ribadisce Weinberg, imporranno un prezzo d’ingresso e quindi una barriera d’entrata, contro l’innovazione. Se fosse esistito un Internet a due velocità fin dalle origini, forse Microsoft avrebbe impedito l’emergere di rivali come Apple? Una delle forze della Silicon Valley è stata la “distruzione creatrice” che sconvolge periodicamente le gerarchie di potere, con dei ventenni che inventano una nuova azienda e sfidano i giganti già esistenti. Finita la Net neutrality, in una Rete a due velocità vinceranno sempre gli stessi?Uno scontro simile, conclude Rampini, si sta riproducendo in Europa. L’inglese Vodafone e la tedesca Deutsche Telekom imitano le loro sorelle americane: vogliono far pagare a Google e Netflix una tariffa superiore per l’uso intenso delle infrastrutture, inondate di video-streaming. Argomento insidioso: sostengono che, in mancanza di adegaumenti tariffari, non avrebbero incentivi a investire per modernizzare la Rete, facendo perdere terreno all’Europa rispetto agli Usa e all’Asia. Poi la trasparenza: le “corsie preferenziali” di fatto esisterebbero già, perché gli operatori di telefonia e Internet favoriscono più o meno occultamente l’accesso alle proprie consociate e filiali, per esempio boicottando Skype in Europa o rallentando vistosamente i film di Netflix per chi cerca di scaricarli dalla rete TimeWarner che ha la sua offerta di videonoleggio concorrente. Sancire l’esistenza della “corsia veloce” alla luce del sole renderebbe le cose più trasparenti? Finora l’Ue ha scelto di difendere la neutralità di Internet. Per il giurista americano Tim Wu, se si abbandona la neutralità «anche Internet diventerà omologato ad ogni altro aspetto della società americana: sarà diseguale, e per ciò stesso una minaccia alla nostra prosperità nel lungo termine».«Immaginate un’autostrada con la corsia di sorpasso riservata ai soli proprietari di Mercedes e Bmw. Perché nel prezzo d’acquisto delle loro auto è incluso quel privilegio. Oppure, forse peggio ancora, la corsia veloce riservata a un paio di società multinazionali che gestiscono flotte di Tir, e hanno comprato quel diritto a farli circolare molto più in fretta di voi». Questo, avverte Federico Rampini, può accadere ben presto per la più importante di tutte le autostrade: Internet. La Rete da cui transita l’informazione, la comunicazione, ormai quasi ogni servizio essenziale, avrà qualità e servizi diversi. «Due velocità, per ricchi e poveri. È questa la conseguenza di una nuova normativa che sta per prendere forma negli Stati Uniti, la nazione che ha dato al mondo l’infrastruttura portante dell’èra digitale». Associazioni dei consumatori in rivolta, col mondo dei media dalla loro parte «nel denunciare la fine imminente di un principio che sembrava sacro: la Net Neutrality, la neutralità della Rete».
-
Tanaticismo: questo regime produce morte. E ci odia
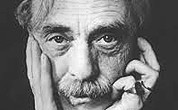 Non so perché continuiamo a chiamarlo capitalismo. È come se ci trovassimo di fronte a una sorta di fallimento o di blocco della funzione poetica del pensiero critico. Anche i suoi adepti non hanno problemi a non chiamarlo più capitalismo. I suoi critici, invece, sembrano essersi ridotti ad aggiungere degli aggettivi: postfordista, neoliberale, oppure il quanto mai ottimista e seducente “tardo” capitalismo. Un termine agrodolce, dal momento che il capitalismo sembra destinato a seppellirci tutti. Mi sono svegliato da un sogno con in testa l’idea che avrebbe più senso chiamare il capitalismo “tanaticismo” – da Thanatos, figlio di Nyx (notte) e Erbos (oscurità), gemello di Hypnos (sonno), come Omero ed Esiodo sembrano più o meno concordare. Ho provato con “tanatismo” su Twitter, e Jennifer Mills mi ha risposto: «Sì, ma penso che siamo di fronte a qualcosa di più entusiasticamente suicida. Tanaticismo?».Questa parola mi sembra pertinente. Tanaticismo, come fanati[ci]smo: una gioiosa ed entusiasta voglia di morire. L’assonanza con “thatcherismo” è di aiuto. Tanaticismo: un ordine sociale che subordina la produzione di valori d’uso ai valori di scambio, a tal punto che la produzione di valori di scambio minaccia di estinguere le condizioni di esistenza dei valori d’uso. Come definizione approssimativa potrebbe funzionare. Bill McKibben ha suggerito che gli esperti di clima dovrebbero andare in sciopero. Il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico ha fatto recentemente uscire il suo report per il 2013. Il documento più o meno ricalca quello del 2012, ma con maggiori prove, maggiori dettagli e con peggiori previsioni. Tuttavia non sembra accadere nulla che possa fermare il tanaticismo. Perché fare uscire un altro report? Non è la scienza che ha fallito, ma la scienza politica. O forse l’economia politica.Nella stessa settimana, Bp ha fatto presente la sua intenzione di dare fondo alle riserve di carbone di cui detiene i diritti. Gran parte del valore di questa azienda, dopotutto, consiste nel valore di quei diritti. Non estrarre, succhiare o fratturare il carbone per ottenere benzina sarebbe un suicidio per l’azienda. Tuttavia trasformare il carbone in benzina per poi bruciarla, rilasciando il carbone nell’aria, mette seriamente a rischio il clima. Ma questo non conta nulla nella produzione di valori di scambio. Il valore di scambio srotola la sua logica intrinseca sino alla fine: l’estinzione di massa. La coda (il capitale) fa scodinzolare il cane (la Terra). Forse non è un caso che la privatizzazione dello spazio fa capolino all’orizzonte come opportunità di investimento proprio in questo momento in cui la Terra è un cane sotto il controllo del capitale.I nostri governanti stanno coscientemente contribuendo all’esaurimento della Terra. È per questo che stanno sognando di costruire degli hotel nello spazio. Non vogliono essere toccati dall’esaurimento della Terra e vogliamo continuare a sviluppare grandi progetti. In questo quadro è ovvio che agenzie come la Nsa spiino chiunque. I governanti sono coscienti di essere i nemici dell’intera specie a cui apparteniamo. Sono i traditori della nostra specie. Per questo vivono nel panico e nella paranoia. Immaginano che siamo tutti là fuori pronti a catturarli. Quindi lo Stato diventa un agente di sorveglianza collettiva e una forza armata in difesa della proprietà. Il ruolo dello Stato non è più quello di amministrare il biopotere. Lo Stato è sempre meno interessato al benessere delle popolazioni. La vita è una minaccia per il capitale ed è trattata come tale.Il ruolo dello Stato non è di amministrare il biopotere ma di amministrare il tanatopotere. Chi sono i primi a cui va negato il sostegno alla vita? Quali popolazioni dovrebbero marcire e scomparire per prime? Innanzitutto quelle che non possono essere usate come forza lavoro o come consumatori, e che hanno smesso di essere fisicamente e mentalmente adatte per servire nell’esercito. Molte di quelle popolazioni non hanno più il diritto di voto. A breve perderanno il diritto ad avere i buoni pasto e altre forme di supporto biopolitico. Solo chi vorrà e saprà difendersi dalla morte avrà il diritto alla vita. Questo per quanto riguarda il mondo sovra-sviluppato. Mentre nel resto del mondo centinaia di milioni di persone vivono attualmente in condizioni di pericolo dovute all’innalzamento del livello dei mari, alla desertificazione e ad altre gravi fratture metaboliche fra società e ambiente. Tutti lo sappiamo: quelle popolazioni sono trattate come dispensabili.Tutti sappiamo che le cose non possono continuare ad andare avanti così come sono. È semplicemente ovvio. A nessuno, però, piace pensarlo. Tutti amiamo le nostre distrazioni. Tutti ci facciamo adescare dal fascino del clic. Ma davvero: lo sappiamo tutti. E tuttavia c’è chi trae vantaggi dal mettersi a servizio della morte. Ogni accenno di scusa in favore del tanaticismo viene riempito da cascate di elogi. Da tempo non possiamo più contare sulla figura dell’intellettuale pubblico; siamo però pieni di pubblici idioti. Chiunque abbia una storia da raccontare o un’idea su come “cambiare le cose” può avere un po’ di attenzione mediatica, nella misura in cui riesce a distogliere l’attenzione dal tanaticismo – o meglio, a giustificarlo. Perfino il migliore dei pubblici idioti di quest’epoca, alla fine, si rivela per ciò che è, ossia un venditore di auto usate. Non è certo un gran periodo per le arti retoriche.È chiaro che l’università, per come la conosciamo, sparirà. Le scienze naturali, le scienze sociali e le discipline umanistiche, ciascuna nei propri modi, lottavano per accrescere i nostri saperi. Ma è molto difficile, a prescindere dalla disciplina, evitare di approdare alla conclusione che il regime oggi vigente sia il tanaticismo. Tutto ciò che le discipline tradizionali possono fare è focalizzarsi su qualche piccolo problema assai circoscritto, su qualche dettaglio, al fine di evitare il quadro generale. E questo non è più sufficiente. Tuttavia, quelle forme di produzione di conoscenza che si concentrano su questioni minori o sussidiarie sono ancora pericolose. Esse stanno iniziando a scoprire ovunque tracce di tanaticismo all’opera. Di conseguenza, l’università deve essere distrutta. Al suo posto, un’apoteosi di ogni forma di non-conoscenza.Stanno già emergendo tante nuove discipline, come le discipline inumane o le scienze antisociali: i loro oggetti di indagine non sono i problemi dell’umanità o delle società. Il loro oggetto è il tanaticismo: la sua descrizione, la sua giustificazione. È necessario identificarsi con (e celebrare) tutto ciò che si oppone alla vita. Un insieme di credenze così poco plausibile e disfunzionale necessita, per imporsi, di cancellare qualunque rivale. Tutto ciò è deprimente. Ma la depressione, d’altronde, è sussidiaria al tanaticismo. È previsto che tu sia depresso, ed è previsto che tu ritenga di esserlo per via di un tuo problema o di una tua carenza individuale. Il tuo brillante e illusorio mondo fantastico cade di colpo in mille pezzi, ed ecco che ti appare la nuda realtà tanatica – e tu pensi che sia per colpa tua. È colpa tua perché hai smesso di crederci. Vai da uno strizzacervelli. Prendi un po’ di psicofarmaci. Oppure fatti un po’ di shopping-terapia.Il tanaticismo cerca anche di assimilare coloro i quali sollevano dubbi su questo modo di governare, ma lo fanno attraverso una cosmesi della loro critica. Esso li trasforma in nuove iterazioni di produzione tanatica. «Comprati una macchina ecologica!», «Fa’ la raccolta differenziata! No, cazzo, falla bene! Separa quella merda!». Ancora una volta, come nel caso della depressione, tutto si riduce alle tue virtù e alla tua responsabilità personale. È colpa tua se il tanaticismo vuole distruggere il mondo. È colpa tua perché sei tu che consumi, ma d’altronde non hai scelta. «Anche le nostre civilizzazioni sanno di essere mortali», scrisse Paul Valéry nel 1919. In quegli anni, dopo la più feroce e inutile tra le guerre mai verificatesi, una considerazione del genere appariva in tutta la sua chiarezza. Ma noi abbiamo perso quella chiarezza. Quindi faccio una modesta proposta. Chiamiamo almeno le cose con il loro nome. Questa è l’era del tanaticismo: il modo di produzione della non-vita. Svegliatemi quando sarà finito.(McKenzie Wark, “Nascita del Tanaticismo”, da “Lavoro culturale” del 23 aprile 2014).
Non so perché continuiamo a chiamarlo capitalismo. È come se ci trovassimo di fronte a una sorta di fallimento o di blocco della funzione poetica del pensiero critico. Anche i suoi adepti non hanno problemi a non chiamarlo più capitalismo. I suoi critici, invece, sembrano essersi ridotti ad aggiungere degli aggettivi: postfordista, neoliberale, oppure il quanto mai ottimista e seducente “tardo” capitalismo. Un termine agrodolce, dal momento che il capitalismo sembra destinato a seppellirci tutti. Mi sono svegliato da un sogno con in testa l’idea che avrebbe più senso chiamare il capitalismo “tanaticismo” – da Thanatos, figlio di Nyx (notte) e Erbos (oscurità), gemello di Hypnos (sonno), come Omero ed Esiodo sembrano più o meno concordare. Ho provato con “tanatismo” su Twitter, e Jennifer Mills mi ha risposto: «Sì, ma penso che siamo di fronte a qualcosa di più entusiasticamente suicida. Tanaticismo?».Questa parola mi sembra pertinente. Tanaticismo, come fanati[ci]smo: una gioiosa ed entusiasta voglia di morire. L’assonanza con “thatcherismo” è di aiuto. Tanaticismo: un ordine sociale che subordina la produzione di valori d’uso ai valori di scambio, a tal punto che la produzione di valori di scambio minaccia di estinguere le condizioni di esistenza dei valori d’uso. Come definizione approssimativa potrebbe funzionare. Bill McKibben ha suggerito che gli esperti di clima dovrebbero andare in sciopero. Il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico ha fatto recentemente uscire il suo report per il 2013. Il documento più o meno ricalca quello del 2012, ma con maggiori prove, maggiori dettagli e con peggiori previsioni. Tuttavia non sembra accadere nulla che possa fermare il tanaticismo. Perché fare uscire un altro report? Non è la scienza che ha fallito, ma la scienza politica. O forse l’economia politica.Nella stessa settimana, Bp ha fatto presente la sua intenzione di dare fondo alle riserve di carbone di cui detiene i diritti. Gran parte del valore di questa azienda, dopotutto, consiste nel valore di quei diritti. Non estrarre, succhiare o fratturare il carbone per ottenere benzina sarebbe un suicidio per l’azienda. Tuttavia trasformare il carbone in benzina per poi bruciarla, rilasciando il carbone nell’aria, mette seriamente a rischio il clima. Ma questo non conta nulla nella produzione di valori di scambio. Il valore di scambio srotola la sua logica intrinseca sino alla fine: l’estinzione di massa. La coda (il capitale) fa scodinzolare il cane (la Terra). Forse non è un caso che la privatizzazione dello spazio fa capolino all’orizzonte come opportunità di investimento proprio in questo momento in cui la Terra è un cane sotto il controllo del capitale.I nostri governanti stanno coscientemente contribuendo all’esaurimento della Terra. È per questo che stanno sognando di costruire degli hotel nello spazio. Non vogliono essere toccati dall’esaurimento della Terra e vogliamo continuare a sviluppare grandi progetti. In questo quadro è ovvio che agenzie come la Nsa spiino chiunque. I governanti sono coscienti di essere i nemici dell’intera specie a cui apparteniamo. Sono i traditori della nostra specie. Per questo vivono nel panico e nella paranoia. Immaginano che siamo tutti là fuori pronti a catturarli. Quindi lo Stato diventa un agente di sorveglianza collettiva e una forza armata in difesa della proprietà. Il ruolo dello Stato non è più quello di amministrare il biopotere. Lo Stato è sempre meno interessato al benessere delle popolazioni. La vita è una minaccia per il capitale ed è trattata come tale.Il ruolo dello Stato non è di amministrare il biopotere ma di amministrare il tanatopotere. Chi sono i primi a cui va negato il sostegno alla vita? Quali popolazioni dovrebbero marcire e scomparire per prime? Innanzitutto quelle che non possono essere usate come forza lavoro o come consumatori, e che hanno smesso di essere fisicamente e mentalmente adatte per servire nell’esercito. Molte di quelle popolazioni non hanno più il diritto di voto. A breve perderanno il diritto ad avere i buoni pasto e altre forme di supporto biopolitico. Solo chi vorrà e saprà difendersi dalla morte avrà il diritto alla vita. Questo per quanto riguarda il mondo sovra-sviluppato. Mentre nel resto del mondo centinaia di milioni di persone vivono attualmente in condizioni di pericolo dovute all’innalzamento del livello dei mari, alla desertificazione e ad altre gravi fratture metaboliche fra società e ambiente. Tutti lo sappiamo: quelle popolazioni sono trattate come dispensabili.Tutti sappiamo che le cose non possono continuare ad andare avanti così come sono. È semplicemente ovvio. A nessuno, però, piace pensarlo. Tutti amiamo le nostre distrazioni. Tutti ci facciamo adescare dal fascino del clic. Ma davvero: lo sappiamo tutti. E tuttavia c’è chi trae vantaggi dal mettersi a servizio della morte. Ogni accenno di scusa in favore del tanaticismo viene riempito da cascate di elogi. Da tempo non possiamo più contare sulla figura dell’intellettuale pubblico; siamo però pieni di pubblici idioti. Chiunque abbia una storia da raccontare o un’idea su come “cambiare le cose” può avere un po’ di attenzione mediatica, nella misura in cui riesce a distogliere l’attenzione dal tanaticismo – o meglio, a giustificarlo. Perfino il migliore dei pubblici idioti di quest’epoca, alla fine, si rivela per ciò che è, ossia un venditore di auto usate. Non è certo un gran periodo per le arti retoriche.È chiaro che l’università, per come la conosciamo, sparirà. Le scienze naturali, le scienze sociali e le discipline umanistiche, ciascuna nei propri modi, lottavano per accrescere i nostri saperi. Ma è molto difficile, a prescindere dalla disciplina, evitare di approdare alla conclusione che il regime oggi vigente sia il tanaticismo. Tutto ciò che le discipline tradizionali possono fare è focalizzarsi su qualche piccolo problema assai circoscritto, su qualche dettaglio, al fine di evitare il quadro generale. E questo non è più sufficiente. Tuttavia, quelle forme di produzione di conoscenza che si concentrano su questioni minori o sussidiarie sono ancora pericolose. Esse stanno iniziando a scoprire ovunque tracce di tanaticismo all’opera. Di conseguenza, l’università deve essere distrutta. Al suo posto, un’apoteosi di ogni forma di non-conoscenza.Stanno già emergendo tante nuove discipline, come le discipline inumane o le scienze antisociali: i loro oggetti di indagine non sono i problemi dell’umanità o delle società. Il loro oggetto è il tanaticismo: la sua descrizione, la sua giustificazione. È necessario identificarsi con (e celebrare) tutto ciò che si oppone alla vita. Un insieme di credenze così poco plausibile e disfunzionale necessita, per imporsi, di cancellare qualunque rivale. Tutto ciò è deprimente. Ma la depressione, d’altronde, è sussidiaria al tanaticismo. È previsto che tu sia depresso, ed è previsto che tu ritenga di esserlo per via di un tuo problema o di una tua carenza individuale. Il tuo brillante e illusorio mondo fantastico cade di colpo in mille pezzi, ed ecco che ti appare la nuda realtà tanatica – e tu pensi che sia per colpa tua. È colpa tua perché hai smesso di crederci. Vai da uno strizzacervelli. Prendi un po’ di psicofarmaci. Oppure fatti un po’ di shopping-terapia.Il tanaticismo cerca anche di assimilare coloro i quali sollevano dubbi su questo modo di governare, ma lo fanno attraverso una cosmesi della loro critica. Esso li trasforma in nuove iterazioni di produzione tanatica. «Comprati una macchina ecologica!», «Fa’ la raccolta differenziata! No, cazzo, falla bene! Separa quella merda!». Ancora una volta, come nel caso della depressione, tutto si riduce alle tue virtù e alla tua responsabilità personale. È colpa tua se il tanaticismo vuole distruggere il mondo. È colpa tua perché sei tu che consumi, ma d’altronde non hai scelta. «Anche le nostre civilizzazioni sanno di essere mortali», scrisse Paul Valéry nel 1919. In quegli anni, dopo la più feroce e inutile tra le guerre mai verificatesi, una considerazione del genere appariva in tutta la sua chiarezza. Ma noi abbiamo perso quella chiarezza. Quindi faccio una modesta proposta. Chiamiamo almeno le cose con il loro nome. Questa è l’era del tanaticismo: il modo di produzione della non-vita. Svegliatemi quando sarà finito.(McKenzie Wark, “Nascita del Tanaticismo”, da “Lavoro culturale” del 23 aprile 2014).Non so perché continuiamo a chiamarlo capitalismo. È come se ci trovassimo di fronte a una sorta di fallimento o di blocco della funzione poetica del pensiero critico. Anche i suoi adepti non hanno problemi a non chiamarlo più capitalismo. I suoi critici, invece, sembrano essersi ridotti ad aggiungere degli aggettivi: postfordista, neoliberale, oppure il quanto mai ottimista e seducente “tardo” capitalismo. Un termine agrodolce, dal momento che il capitalismo sembra destinato a seppellirci tutti. Mi sono svegliato da un sogno con in testa l’idea che avrebbe più senso chiamare il capitalismo “tanaticismo” – da Thanatos, figlio di Nyx (notte) e Erbos (oscurità), gemello di Hypnos (sonno), come Omero ed Esiodo sembrano più o meno concordare. Ho provato con “tanatismo” su Twitter, e Jennifer Mills mi ha risposto: «Sì, ma penso che siamo di fronte a qualcosa di più entusiasticamente suicida. Tanaticismo?».
