Ceronetti, quel genio italiano troppo scomodo per gli italiani
Scritto il 14/9/18 • nella Categoria:
segnalazioni
I cosiddetti “grandi italiani”, ebbe a dire l’autore televisivo Diego Cugia, sono personaggi che normalmente gli italiani neppure conoscono: la maggior parte della popolazione non sa neppure chi siano, che faccia abbiano, per quale ragione debbano essere ricordati. Per molti, i “grandi italiani” diventano tali, all’improvviso, solo quando muoiono: come nel caso dell’immenso letterato Guido Ceronetti, spentosi il 13 settembre all’età di 91 anni. Sul “Corriere della Sera”, Paolo Di Stefano lo rievoca con le parole di Ernesto Ferrero, tratte da “I migliori anni della nostra vita”, dove si vede l’allora quarantenne Ceronetti aggirarsi nei corridoi dell’Einaudi: «Avvolto in impermeabili sdruciti, in baschi da cui spuntavano capelli spiritati che ricordavano quelli di Artaud. Magro, anzi secco, con un naso alla Voltaire che spioveva su una bocca piegata all’ingiù, da cui uscivano riflessioni sapienziali, aforismi, profezie apocalittiche». Per ottenere il ritratto di Ceronetti, scrive Di Stefano, basta aggiungere «la erre arrotata, l’autoironia, lo strascicato accento piemontese, la voce sottile, quasi femminea. E le ossessioni vegetariane: invitato al ristorante, anche nel migliore, immancabilmente tirava fuori dalla cartella il suo olio e le sue tisane, mangiava semi di chissà che, grani di miglio».
In quell’aspetto di uccello rapace (agli amati barbagianni aveva dedicato un libro di aforismi) si riassumeva il suo stesso carattere, che consisteva – scrive sempre Di Stefano – nel tenersi fuori dalla mischia «per comparire inaspettatamente con il suo becco ricurvo e ritirarsi di nuovo nella sua casa di Cetona, in Valdichiana, con la moglie Erica Tedeschi, insieme alla quale aveva fondato nel 1970 ad Albano Laziale il Teatro dei Sensibili». Nato ad Andezeno (Torino) nel 1927, «da sempre estraneo alla cultura marxista einaudiana della sua generazione», nel 1968 fu però accolto all’Einaudi come poeta, dopo le prove d’esordio del decennio precedente. «Nessuno avrebbe immaginato allora che fosse destinato a rimanere regolarmente escluso dalle storie letterarie e dalle antologie grandi e piccole». Con il suo spirito distaccato e beffardo, anche ludico, riusciva a farsene un vanto: «Finora è andata bene», disse nel 1989 in un’intervista alla “Frankfurter Rundschau”: «In Italia non mi hanno ancora schedato tra i poeti del Novecento, un colombario triste dove non si portano, per risparmio, che fiori di plastica, dove si sta disgiunti per sempre dal cuore dei vivi».
Del resto, aggiunge Di Stefano, Ceronetti definiva le proprie poesie «ideogrammi di compassione, di ricordo e di desiderio della luce, in forma di grido ritmato». Più di cinquemila versi, dai giovanili “Nuovi Salmi” (1955) fino a “La ballata dell’angelo ferito” (2008), non inseribili dentro la tradizione novecentesca italiana e «alimentati piuttosto dalla grande cultura dell’irregolare che si avvaleva della conoscenza del francese, del tedesco, dell’ebraico e delle lingue classiche, probabilmente imparate da solo». Memorabile la sua traduzione del Qohélet biblico, l’Ecclesiaste: pagine da cui emerge, in modo marmoreo, il “male di vivere” che poi sarà declinato in mille modi dalla letteratura novecentesca. Di Stefano rende bene l’idea del personaggio: viaggiatore, esploratore infaticabile della realtà e della letteratura, attore, marionettista, traduttore geniale e spesso eversivo. Ancora: autore di aforismi e di cronache, epistolografo, decoratore di cartoline che inviava agli amici. E poi saggista e giornalista, non solo per necessità economiche (nel 2008 avrebbe ottenuto il sostegno della Legge Bacchelli). Pochi ricordano il coraggio civile mostrato da Ceronetti nel giugno 2011: osò avventurarsi a Chiomonte, dove la polizia aveva appena  sgomberato i dimostranti NoTav, per farne un esemplare reportage su “La Stampa”. Non pago, offrì ai NoTav anche una serata di letture poetiche pochi giorni dopo, nella valle di Susa “assediata” dai reparti antisommossa.
sgomberato i dimostranti NoTav, per farne un esemplare reportage su “La Stampa”. Non pago, offrì ai NoTav anche una serata di letture poetiche pochi giorni dopo, nella valle di Susa “assediata” dai reparti antisommossa.
Niente di strano, in fondo: per Ceronetti, lo spettro di una maxi-infrastruttura come l’alta velocità Torino-Lione non era che l’ennesima maschera della Tecnica, il mostro tecnologico disumanizzante, capace di trasformarsi da strumento in dittatura, da servo in padrone. Una visione irriducilmente antimoderna, nella quale risuona l’amore per l’eresia medievale dei Catari, brutalmente repressa dalla Chiesa in Occitania con la Crociata Albigese del 1200: non a caso, in punto di morte, Ceronetti si è fatto somministrare il “consolamentum”, cioè il “battesimo” dei Catari – religione cristiano-dualista di ascendenza zoroastriana (il mondo visto come creazione “dannata” del Dio Straniero, che diede origine alla materia dopo essersi ribellato al Padre Celeste, signore della luce). «Ceronetti è stato sempre un eretico», scrive Di Stefano sul “Corrirere”: un “matto”, lo chiamava Giulio Einaudi, «capace di usare la lingua ora come una sciabola ora come una piuma». Sfuggiva ad ogni “allineamento” ideologico, «indifferente com’era ai giudizi del comune senso politico-civile per far valere il suo tratto sferzante o sapienziale».
Ha lasciato molti libri, riconosce Di Stefano, che varrebbe la pena inserire nelle nostre personali antologie. A cominciare dalle diverse scelte di articoli (“La carta è stanca”, Adelphi; “Ti saluto mio secolo crudele”, Einaudi) e proseguendo con il “Viaggio in Italia” del 1983, raccolta di prose che l’autore definì «collages d’impurità e stranezze», collezionati su treni, su corriere, su battelli, in taxi o a piedi viaggiando da Milano a Catania, da Trieste a Roma a Palermo. Un reportage per luoghi banali o per siti impervi, zone centrali o periferiche, l’Italsider di Bagnoli dove «ogni visitatore deve mettersi l’elmetto», sul lido ghiaioso di Quarto («io sono vestito tra gente nuda»), nella sua Torino, dove «molta gente è posseduta» dagli spiriti maligni. Altrettanto folgorante il secondo diario di viaggio, “Albergo Italia”, in cui l’autore regala uno sguardo assolutamente sorprendente sulla vera identità, geografica e spirituale, della nostra penisola. Un viaggio riproposto nel 2014, che assume i colori della satira, dell’indignazione, dello sconforto, del divertimento, della comicità a volte irresistibile mescolata con il gusto del tragico, del  macabro, della solennità sublime e vaticinante, dello scatto metafisico: «Tutti i tratti tipici della variabile attitudine stilistica di Ceronetti», sottolinea Di Stefano.
macabro, della solennità sublime e vaticinante, dello scatto metafisico: «Tutti i tratti tipici della variabile attitudine stilistica di Ceronetti», sottolinea Di Stefano.
«Capace di guardare con occhio disincantato il male, l’eccentrico, i margini, di visitare i cunicoli del passato e del presente, di spaziare nella cronaca giudiziaria (il caso di Rosa Vercesi del 1930), nell’arte (i ritratti di Bosch, Munch, Rops), di infiammarsi per un paesaggio ferito dai “grandi serpenti cloacali”, Ceronetti ha subito goduto di un gruppo di lettori devoti che negli anni sono andati crescendo (anche grazie all’attività frenetica del marionettista), senza mai arrivare però alle folle richieste dal bestseller», scrive il “Corriere”. È sempre rimasto un autore per pochi, intollerante com’era della semplificazione anche nelle vesti del “giornalista”, sia pure sui generis: «L’arte suprema della parola – ha scritto – è illuminare senza farsi troppo capire». Per Di Stefano, Ceronetti era un intellettuale che divideva il pubblico, per le sue opinioni di “barbagianni” – ma persino le sue traduzioni potevano suscitare irritazione, «come quelle trasgressive di Catullo o quelle dei testi sacri, che non solo gli specialisti guardavano con diffidenza per la troppa libertà inventiva». Tantissimi gli autori rivisitati: Eraclito e Machado, Kavafis, Döblin. E poi Shakespeare, Racine, Seferis, Blake. E Rimbaud, Marziale, Mallarmé, Rilke, Orazio. Era, per sua stessa ammissione, «un modo non disonesto di guadagnarsi il pane e un’investitura separatrice», la presa di distanze da una contemporaneità decisamente aborrita, ma anche una via d’accesso per altri percorsi intellettuali: un «ininterrotto filosofare, interpretare, girare e rigirare per i meandri di un’ascetica filologia». Un aiuto, aggiungeva Ceronetti, a pensare «la bellezza della parola e dell’immagine invaselinando l’accesso difficile al sepolcrale segreto dei mondi che il verso contiene».
La sua altera radicalità antimoderna gli ha fatto guadagnare la fama di apocalittico. Ma lui protestava: “apocalittico”, diceva, «è un aggettivo che va radiato dal dizionario». Meglio un quasi-sinonimo come “nichilista”? Macché: «C’è una mostruosa improprietà nel linguaggio, viene quasi da ridere». Ma pazienza: «I luoghi comuni, non le parole, sono la mia bestia nera». Semmai, scrive Antonio Carioti sempre sul “Corriere”, Ceronetti era un accanito antimoderno: detestava le tecnologie, quelle digitali quanto quelle meccaniche, rifiutandosi di usare l’automobile come il computer. Era innanzitutto pervaso da un profondo senso tragico che derivava dalla sua sfiducia nell’uomo, da lui definito «l’arma più pericolosa che sia stata inventata». Andava oltre la derisione verso le «magnifiche sorti e progressive» del suo amato Giacomo Leopardi: in certe invettive ostentava una misantropia degna dell’altrettanto amato Jonathan Swift, temperata però dalla forte compassione, che considerava «il più elevato sentimento umano». Figlio di un artigiano specializzato in pitture e decorazioni, esordì come editorialista avviando la sua storica collaborazione con “La Stampa”, dopo aver pubblicato con Rusconi il libro “Difesa della luna” (1971), in cui prendeva di mira l’esplorazione dello spazio, presentata come  «un’impresa assurda, massima espressione della smisurata vanità umana». Molti anni dopo, in piena coerenza – aggiunge Carioti – rivolgerà i suoi strali feroci contro un personaggio popolare come l’astronauta Samantha Cristoforetti.
«un’impresa assurda, massima espressione della smisurata vanità umana». Molti anni dopo, in piena coerenza – aggiunge Carioti – rivolgerà i suoi strali feroci contro un personaggio popolare come l’astronauta Samantha Cristoforetti.
«D’altronde, l’ostilità al progresso di Ceronetti va ben oltre la critica ai viaggi nel cosmo. Con la sua prosa estrosa e disturbante deplora la motorizzazione di massa, il traffico impazzito, il sovraffollamento delle città, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, lo stravolgimento del paesaggio rurale. Rigorosamente vegetariano, non nasconde il suo orrore per il consumo di carne, i mattatoi, gli allevamenti intensivi». Un formidabile intellettuale “contro”: «Si scaglia ovviamente contro la sperimentazione sugli animali, ma non risparmia la procreazione assistita, l’accanimento terapeutico, la donazione d’organi, in generale la medicina moderna». La sua “ballata dell’angelo ferito” è dedicata a Eluana Englaro, tenuta in vita artificialmente. «Particolarmente severa è la sua penna affilata nel fustigare le cattive abitudini degli italiani, l’incuria e la negligenza verso il patrimonio architettonico e paesaggistico, saccheggiato e deturpato senza alcun ritegno», scrive Carioti. Sempre apocalittico è il tono dei suoi diari di viaggio, fino al recente “Per le strade della Vergine” (Adelphi, 2016). «L’italiano – scrive – è italofago. Non lascerà nulla di vivo in questa penisola. Macella massacra divora tutto».
Per Ceronetti, la politica è solo «un vecchio vampiro». Definiva il nostro paese «una democrazia strangolata sul nascere da tre poteri con il verme totalitario, democristiano, comunista e sindacale». A Silvia Truzzi, che nel 2014 sul “Fatto Quotidiano” lo interpellò su Berlusconi e Renzi, rispose: «Una somma di zeri mentali farà sempre zero». E i 5 Stelle? «Con Grillo scendiamo ancora». Memorabile la sua presa di posizione contro il voto ai diciottenni. I partiti, denunciava Ceronetti, «vogliono truppa fresca da stordire con pensieri fissi e da corrompere con seggi, stipendi, illusioni di potere». D’altronde, aggiunge sempre Carioti sul “Corriere”, la politica gli appariva del tutto asservita «all’economia dello sviluppo», un meccanismo infernale che «trasforma le società umane in aggregazioni di schiavi di un produrre che non conserva ma assassina la vita». Ultimamente, Ceronetti riteneva “folle” la dipendenza dal digitale: nel pamphlet “Per non dimenticare la memoria” (Adelphi, 2016) aveva bollato il web come «uno sterminato luna park senz’anima», che ai suoi utenti «dà a succhiare mammelle sataniche». Considerava letale per la memoria anche l’aver  cancellato la liturgia cattolica in latino. Si teneva alla larga dalla teologia cristiana, ma in un carteggio con Sergio Quinzio (“Un tentativo di colmare l’abisso”, pubblicato da Adelphi nel 2014) si era dichiarato «fedele a qualche lampo di metafisica gnostico-cataro-manichea, per la quale la creazione è opera essenzialmente maligna».
cancellato la liturgia cattolica in latino. Si teneva alla larga dalla teologia cristiana, ma in un carteggio con Sergio Quinzio (“Un tentativo di colmare l’abisso”, pubblicato da Adelphi nel 2014) si era dichiarato «fedele a qualche lampo di metafisica gnostico-cataro-manichea, per la quale la creazione è opera essenzialmente maligna».
Un pensiero, quello della metafisica gnostica da opporre – come forma resistenza – alle aberrazioni della post-modernità, è scolpito in modo indelebile nel piccolo capolavoro “Pensieri del tè”, uscito per Adelphi nel 1987. «Fummo una Legione che perdeva il proprio sangue, senza versarne d’altri», scrive Ceronetti, in onore della Legione Sacra tebana sacrificata nell’epica battaglia di Cheronea, nel 338 avanti Cristo: la civiltà greca travolta dallo strapotere militare di Filippo il Macedone. Specularmente, Ceronetti ripropone la stessa dicotomia evocata da Simone Weil ne “I Catari e la civiltà mediterranea”: da una parte l’Occitania catara, ultimo riflesso della cultura ateniese (il culto della bellezza), e dall’altra la barbarie della forza, i Crociati, eredi dell’Impero Romano. Uno scontro – tra giustizia illuminata e potere brutale, concepito in forma di dominio – che Ceronetti riconduce a quell’antico disastro del IV secolo avanti Cristo. Scrive, impersonando un reduce: «Anche per tutti quei miei commilitoni tragici, accasermati nell’invisibile, parla la pietra sepolcrale dei caduti di Cheronea. La parola, il pensiero che si fa parola o figua, è la nostra Ellade sacra».
Articoli collegati
- Jack Folla: italiani mediocri e cialtroni come questi politici
- La lotteria dell'universo e i numeri sbagliati del pianeta
- La sfida dell'eresia, dai Catari al mondo del pensiero unico
- Ceronetti: delusione Obama, utile idiota degli Illuminati?
- Ceronetti con la Decrescita: e si scordino il Tav in val Susa
- Ceronetti: schiavi del dannato cellulare, la pulce-elefante
- Tav, Ceronetti: la val Susa contro l'impero della schiavitù
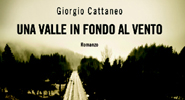
 Jack Folla: italiani mediocri e cialtroni come questi politici
Jack Folla: italiani mediocri e cialtroni come questi politici La sfida dell'eresia, dai Catari al mondo del pensiero unico
La sfida dell'eresia, dai Catari al mondo del pensiero unico Ceronetti: delusione Obama, utile idiota degli Illuminati?
Ceronetti: delusione Obama, utile idiota degli Illuminati? Ceronetti con la Decrescita: e si scordino il Tav in val Susa
Ceronetti con la Decrescita: e si scordino il Tav in val Susa
Personaggio d’altri tempi che ha espresso concetti fuori da ogni tempo … un genio incompreso
Sono d’accordo con Diego Cugia su quanto scrive di Ceronetti, quest’ultimo sostanzialmente custodisce due iperbolici difetti: non ha la tessera del PD e non professa il cattolicesimo, mondato di questi sarebbe perfetto.
Poi farsi capire dagli italiani è una battaglia persa in partenza considerando la quasi totale mancanza di erudizione che come un manto incista la gente del bel paese.