Francesco e la rivoluzione, 50 anni dopo il “Papa buono”
Sta’ a vedere che il Papa argentino farà la rivoluzione. A giudicare dalle sue prime mosse, inequivocabili e fortemente simboliche, l’anziano religioso che ha adottato il nome di Francesco d’Assisi potrebbe archiviare il prudente conservatore Jorge Bergoglio e togliere improvvisamente dal freezer lo slancio democratico del Concilio Vaticano II. Era quello che chiedeva il più dissidente dei cardinali, Carlo Maria Martini, che proprio su Bergoglio aveva puntato già nel conclave del 2005, opponendolo a Ratzinger per porre fine alla “grande glaciazione” imposta da Wojtyla e ben mascherata dal suo sorriso carismatico. «Fin dalle sue prime espressioni, la cerimonia d’insediamento di Papa Francesco conferma che i suoi gesti e le sue parole non erano casuali ma ben meditate», rileva Gad Lerner. «La situazione è in grande movimento, anche la storia può mettersi a correre e grandi sorprese non sono da escludersi».
«Presentandosi come semplice vescovo di Roma e spogliandosi di ogni esteriorità regale – osserva Lerner – Jorge Mario Bergoglio persegue il  disegno ecumenico della riunione con gli ortodossi e i luterani che mal sopportarono una pratica gerarchica del ministero petrino». Clamorosa la presenza a Roma del patriarca di Costantinopoli, a quasi mille anni dallo scisma della Chiesa d’Oriente. Mezzo secolo fa, ricorda Lerner in un intervento pubblicato da “Vanity Fair” e ripreso dal suo blog, il Concilio Vaticano II aveva tentato di rovesciare nei fatti il dogma dell’infallibilità papale: dogma voluto da Pio IX alla vigilia della breccia di Porta Pia, quando il pontefice avvertiva la fine imminente del potere temporale della Chiesa. Incoraggiati dalla libertà di dibattito concessa loro da Giovanni XXIII, i padri conciliari «osarono
disegno ecumenico della riunione con gli ortodossi e i luterani che mal sopportarono una pratica gerarchica del ministero petrino». Clamorosa la presenza a Roma del patriarca di Costantinopoli, a quasi mille anni dallo scisma della Chiesa d’Oriente. Mezzo secolo fa, ricorda Lerner in un intervento pubblicato da “Vanity Fair” e ripreso dal suo blog, il Concilio Vaticano II aveva tentato di rovesciare nei fatti il dogma dell’infallibilità papale: dogma voluto da Pio IX alla vigilia della breccia di Porta Pia, quando il pontefice avvertiva la fine imminente del potere temporale della Chiesa. Incoraggiati dalla libertà di dibattito concessa loro da Giovanni XXIII, i padri conciliari «osarono  proporre una nuova dottrina sul tema controverso del primato papale, già motivo delle divisioni scismatiche insorte fra i cristiani».
proporre una nuova dottrina sul tema controverso del primato papale, già motivo delle divisioni scismatiche insorte fra i cristiani».
Suscitando lo scandalo della curia tradizionalista, nel documento “De Ecclesia” si avanzò l’idea di un esercizio collegiale dell’autorità, ridimensionando il Papa a “primum inter pares”. Le conferenze dei vescovi, riuniti per aree geografiche, dovevano avere voce in capitolo sulle decisioni fondamentali della Chiesa alle prese col tempo contemporaneo. Ma non basta: nel documento “Lumen gentium”, sempre il Concilio Vaticano II riconosceva il sacerdozio universale dei fedeli, chiamando i laici a partecipare della guida della Chiesa e quindi sottraendo potere alla mediazione gerarchica dei preti. «Sappiamo bene che nel mezzo secolo successivo queste deliberazioni conciliari sono rimaste largamente inapplicate», osserva Lerner. Fino ad arrivare addirittura all’ostracismo nei confronti di chi, come Martini, «sollecitava l’apertura a una visione orizzontale anziché verticale del magistero, aperta alle domande dei laici pure in materia di sessualità e matrimonio».
Per questo, «al di là della straordinaria simpatia umana e del programma francescano di adesione alla vita dei poveri», di Papa Bergoglio colpisce «la sapiente innovazione teologica rispetto ai suoi due predecessori». Ovvero: «L’avere parlato di sé come vescovo prima che come Papa; la richiesta al popolo-sacerdote di benedirlo prima ancora di impartire lui dall’alto la sua benedizione. Lo spogliarsi dai residui segni esteriori di regalità temporale, quali le croci-gioiello (lasciamole alla Madonna intesa come cantante), i paramenti lussuosi, i mezzi di trasporto e il seguito vistosi». Secondo Lerner, «tutto converge nel delineare un’accelerazione forte e improvvisa dello spirito conciliare dopo gli anni della restaurazione gerarchica, i cui  cattivi frutti è stato Benedetto XVI per primo a riconoscere, dapprima con parole di fuoco e poi col gesto inaudito delle dimissioni».
cattivi frutti è stato Benedetto XVI per primo a riconoscere, dapprima con parole di fuoco e poi col gesto inaudito delle dimissioni».
Secondo Lerner, a questo punto tutto è possibile: «Perfino che Papa Francesco usi la sua vecchiaia per gettare il cuore oltre l’ostacolo rappresentato dalla crisi della Chiesa, convocando un altro Concilio». O che, di fronte al ridimensionamento da lui così fortemente evidenziato del primato papale sugli altri vescovi, dia frutti (insperati fino a ieri) il dialogo ecumenico con i non-cattolici, fino alla riunificazione dei cristiani nella fede comune. «Tendiamo a dimenticarcelo, ma nei duemila anni della sua storia la Chiesa ha già vissuto cambiamenti strutturali e dottrinali enormi, così come si è modificato nel tempo il ruolo del Papa». L’uomo che ha scelto di farsi chiamare Francesco autorizza a sperare in una specie di miracolo politico: ci crede anche Leonardo Boff, uno dei fondatori della “teologia della liberazione”, emarginato da Wojtyla e Ratzinger.
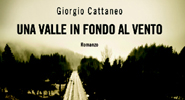
 L'immenso tesoro del Papa e il custode venuto da Sydney
L'immenso tesoro del Papa e il custode venuto da Sydney Odifreddi: contro la mafia, la vuota scomunica del Papa
Odifreddi: contro la mafia, la vuota scomunica del Papa Tutti salvi, solo in un mondo senza più vincitori né vinti
Tutti salvi, solo in un mondo senza più vincitori né vinti Scisma silenzioso: cristiani sempre più lontani dalla Chiesa
Scisma silenzioso: cristiani sempre più lontani dalla Chiesa Caso Bergoglio: esagerazioni, ipocrisie e disinformazione
Caso Bergoglio: esagerazioni, ipocrisie e disinformazione