Petrolio, dollari e potere: così Gheddafi ha perso la Libia
Buona parte della Libia si è rivoltata contro Gheddafi, cogliendo al volo il vento della Tunisia e quello dell’Egitto, quando il regime del raìs è entrato in crisi: avendo aperto la sua economia al capitalismo globalizzato, Tripoli ha accusato il colpo del crac finanziario mondiale del 2008, vedendo crollare i propri ricavi petroliferi. Ad aggiungere tensione sociale, l’enorme afflusso di lavoratori stranieri – forse due milioni – su una popolazione che raggiunge appena i sei milioni di abitanti. Questo lo scenario di crisi su cui ha avuto mano libera la rivolta, ispirata dalla Cirenaica e appoggiata dai clan tribali: l’occasione giusta per tentare di sbarazzarsi del Colonnello, protagonista di quarant’anni di feroce repressione, come del resto quasi tutti gli altri paesi petroliferi dell’area.
Lo sostiene Sergio Cararo, direttore di “Contropiano”, in una analisi ripresa da “Megachip” nella quale cerca di approfondire lo scenario libico oggi  sconvolto dalla violenza della guerra civile e dall’intervento militare internazionale. Cararo mette in guardia i lettori dalle semplificazioni mediatiche: chi è il “popolo libico” che si è rivoltato contro il dittatore? «La manifestazione del 15 febbraio – scrive – era stata repressa duramente, come purtroppo è la norma in Libia e in tutti i paesi del Medio Oriente». Ma appena due giorni dopo, circolavano già manifestanti armati contro la polizia di Gheddafi: «Una tempistica rapidissima e bruciante che non ha avuto neanche il tempo di manifestarsi come rivolta popolare di piazza per diventare subito una guerra civile».
sconvolto dalla violenza della guerra civile e dall’intervento militare internazionale. Cararo mette in guardia i lettori dalle semplificazioni mediatiche: chi è il “popolo libico” che si è rivoltato contro il dittatore? «La manifestazione del 15 febbraio – scrive – era stata repressa duramente, come purtroppo è la norma in Libia e in tutti i paesi del Medio Oriente». Ma appena due giorni dopo, circolavano già manifestanti armati contro la polizia di Gheddafi: «Una tempistica rapidissima e bruciante che non ha avuto neanche il tempo di manifestarsi come rivolta popolare di piazza per diventare subito una guerra civile».
E’ vero, sono stati i giovani – come in Tunisia e in Egitto – a scatenare la protesta, e avevano tutte le ragioni per farlo; ma dietro i giovani libici, scrive Cararo, hanno preso subito la situazione in mano gli uomini del vecchio apparato di regime, «in rotta con il leader e ansiosi di ridefinire gli equilibri interni sconvolti dalla crisi finanziaria del 2008-2009 e dalle misure “liberiste ma non liberali” introdotte da Gheddafi nel 2003». Proprio sulla leva economica insiste Cararo per spiegare la rottura dell’equilibrio su cui si fondava il potere di Gheddafi: repressione, certo, ma anche denaro. «L’errore più grave che Gheddafi ha commesso – scrive l’analista palestinese Abd al Bari Atwan, direttore dell’autorevole quotidiano arabo “Al Quds Al Arabi” – è stato quello di fare all’Occidente tutte le concessioni che  quest’ultimo gli chiedeva, e di non fare invece alcuna concessione al suo popolo che gli chiedeva libertà, democrazia e una vita dignitosa».
quest’ultimo gli chiedeva, e di non fare invece alcuna concessione al suo popolo che gli chiedeva libertà, democrazia e una vita dignitosa».
Secondo Atwan, Gheddafi è caduto in una sorta di trappola: riaprendo la Libia all’Occidente si è disarmato, e alla prima crisi è stato tradito. «Il Colonnello – scrive Cararo – si è disperato perché i suoi nuovi amici occidentali non lo hanno aiutato mentre i ribelli di Bengasi lo stavano accerchiando». L’illusione del leader libico, aggiunge Atwan, derivava dalle concessioni fatte a Usa e Gran Bretagna nel 2000 e che nel 2003 lo hanno portato fuori dalla lista nera degli “stati canaglia”, e quindi lontano dai bersagli della “guerra infinita” scatenata da Bush nel 2001. «Washington e Londra – prosegue Atwan – hanno utilizzato l’esca della “normalizzazione” e della riabilitazione del regime libico, che avrebbe aperto la strada al suo ritorno nella comunità internazionale in cambio della sua rinuncia alle armi di distruzione di massa».
La smilitarizzazione sostanziale della Libia, avvenuta del 2003, è stata presentata come un successo collaterale della (disastrosa) campagna in Iraq contro Saddam Hussein. Gheddafi si è lasciato convincere: «Dopo averlo spogliato delle armi di distruzione di massa, lo hanno adescato spingendolo a porre le sue riserve di denaro nelle banche americane e ad aprire nuovamente il territorio libico alle compagnie petrolifere britanniche ed americane, ancora più che in passato». Investimenti stranieri, in cambio del ritiro delle sanzioni economiche a cui la Libia era sottoposta da anni. Non solo: nel 2003 il Colonnello ha privatizzato 360 imprese statali. Nel paese, scrive l’osservatorio web “Medarabnews”, sono affluiti capitali italiani, inglesi, americani, turchi e cinesi. «Nel 2003 la Libia era diventata una delle nuove  frontiere della globalizzazione del continente, il nuovo Eldorado per molte società europee e americane».
frontiere della globalizzazione del continente, il nuovo Eldorado per molte società europee e americane».
Mentre la produzione petrolifera è rimasta bloccata dalle quote imposte dall’Opec (ma con significativi aumenti del prezzo del petrolio), tra il 2003 e il 2007 la produzione di gas naturale libico è praticamente triplicata. Non solo: la qualità e i costi di recupero del greggio libico, relativamente bassi, rendono la Libia un importante attore del settore energetico globale. «La Libia – osserva Cararo – si è trovata così a disporre di una enorme liquidità finanziaria da investire – tramite il boom dei fondi sovrani sviluppatisi nei paesi petroliferi – in banche e attività nei maggiori paesi capitalisti. Da qui l’entrata in Unicredit, Finmeccanica, Eni o la permanenza nel capitale della Fiat».
Per il regime di Gheddafi, sono stati dieci anni d’oro dopo la stagione dell’embargo e dell’ostracismo; dopo gli incontri con Condoleezza Rice, con Berlusconi ma anche con Prodi, sono stati siglati trattati bilaterali per proteggere l’Europa dalle sue paure principali: restare senza petrolio ed essere invasa da ondate migratorie. Così, Gheddafi diventa il garante della tranquillità europea. Qualche giorno prima degli incidenti di Bengasi, continua Cararo, lo stesso Fondo Monetario Internazionale il 9 febbraio rilasciava una valutazione quasi entusiastica del nuovo corso libico: «Un ambizioso programma per privatizzare banche e sviluppare il settore  finanziario è in sviluppo. Le banche sono state parzialmente privatizzate, liberati i tassi di interesse e incoraggiata la concorrenza».
finanziario è in sviluppo. Le banche sono state parzialmente privatizzate, liberati i tassi di interesse e incoraggiata la concorrenza».
A sconquassare la “Belle Epoque” libica, così come il resto del mondo legato al ciclo economico del capitalismo euro-statunitense, è arrivata la crisi finanziaria e globale del 2008-2009. Anche secondo il “Corriere della Sera”, il punto di rottura è stato proprio questo: «La crisi finanziaria tra il 2008 e il 2009 ha ridotto del 40% i ricavi dei pozzi di petrolio, intaccando il rapporto tra il capo e le tribù, che con la ribellione stanno rompendo il patto economico e d’onore». E’ la crisi globale, dunque, la stessa crisi sistemica che sta squassando i capitalismi negli Usa e in Europa, a spezzare l’equilibrio raggiunto tra Gheddafi e le varie componenti, economiche e tribali, su cui si è retto per 41 anni il regime libico. Ma non c’è solo questo: oltre all’insofferenza per la repressione, a destabilizzare il Colonnello è stata anche la crisi sociale della nuova Libia multinazionale messa a disposizione del capitale globalizzato.
«La svolta panafricana di Gheddafi nel 1997, che porta alla rottura definitiva con l’ipotesi panaraba perseguita fino ad allora, apre le frontiere della Libia ad una enorme immigrazione dall’Africa che destabilizza gli equilibri nella popolazione, nel mercato del lavoro e nella distribuzione delle rendite petrolifere», spiega Cararo. Su una popolazione libica di 6,5 milioni di abitanti, per “Medarabnews”si tratta di «circa un milione e mezzo (forse due milioni, nessuno conosce la cifra esatta)» di lavoratori provenienti da paesi come il Mali, il Niger, la Nigeria, Il Sudan, l’Etiopia e la Somalia, che «forniscono manodopera a bassissimo costo per l’industria petrolifera, il settore edile, quello dei servizi, l’agricoltura». Così, l’apertura delle frontiere libiche all’Africa sub-sahariana «suscita gravi tensioni nel paese a causa dell’enorme afflusso di immigrati». Persino Amnesty International e Human  Rights Watch mettono in guardia da una vera e propria «esplosione di violenza razziale, mai prima registrata in un paese nordafricano».
Rights Watch mettono in guardia da una vera e propria «esplosione di violenza razziale, mai prima registrata in un paese nordafricano».
La rottura del patto con Gheddafi, sostiene Roberto Aliboni su “Affari Internazionali”, farebbe emergere in Libia «l’esistenza di una élite di funzionari civili e filo-occidentali che in queste ore sta prendendo le distanze dalla carneficina scatenata da “cane matto”». Altri analisti, rileva Cararo, preferiscono alimentare lo schema secondo cui la rivolta libica è stata in tutto simile a quelle della Tunisia e dell’Egitto, con un ruolo preponderante dei giovani, proiettati nella modernità ed estranei alle eredità tribali della struttura sociale libica, che invece resta la chiave di lettura di altri osservatori, spesso interessati ad alimentare – senza validi elementi – il fantasma del fondamentalismo islamico, prendendo a pretesto la rivolta di Bengasi del 2006, scatenata dalle provocazioni anti-islamiche del ministro italiano Calderoli e repressa da Gheddafi tra gli applausi di America, Europa e arabi “moderati”.
Se non manca chi paventa infiltrazioni di Al Qaeda, c’è chi segnala che proprio la struttura tribale della Libia ha permesso al paese di non precipitare in uno scenario come quello della Somalia. Secondo Frank Anderson, studioso del Medio Oriente ed ex agente della Cia nella regione, le tribù contano molto, anzi sono «decisive» nella guerra civile in atto in Libia: «Dopo essere state per quarant’anni obbligate a ubbidire ai desideri del Colonnello e della sua tribù, che è molto piccola, ora vedono la possibilità di rovesciare l’equilibrio delle forze, prendendosi molte rivincite». Il network tribale conterebbe 140 clan, a cui apparterrebbe l’85% dei libici. Negli anni  ’90, spiega Cararo, Gheddafi aveva rinnovato la propria alleanza con i leader tribali, promossi a garanti dei valori sociali, culturali e religiosi del paese.
’90, spiega Cararo, Gheddafi aveva rinnovato la propria alleanza con i leader tribali, promossi a garanti dei valori sociali, culturali e religiosi del paese.
In particolare, il Colonnello strinse un’alleanza con la tribù Warfalla, il principale clan della Tripolitania, che conta circa un milione di appartenenti. I posti chiave dei servizi di sicurezza, continua Cararo, vennero affidati ai membri delle tribù Qadhafha e Maqariha: la prima è quella dello stesso Gheddafi, alla seconda appartiene invece l’ex delfino Jalloud defenestrato più di vent’anni fa; entrambe erano il nucleo centrale della “rivoluzione” del 1969, il colpo di Stato col quale il Colonnello prese il potere. «Se è vero che con la crisi finanziaria del 2008-2009 c’è stata una severa riduzione della torta da spartire nel patto tra le tribù – osserva Cararo – l’ipotesi che questo abbia coinciso con lo scontro interno al gruppo  dirigente libico e determinato la guerra civile, appare estremamente plausibile».
dirigente libico e determinato la guerra civile, appare estremamente plausibile».
Un evidente riflesso di questo aspetto (probabilmente inevitabile, in una dittatura come quella libica) è rappresentato dalla presenza di uomini del vecchio regime alla testa dei “ribelli” di Bengasi: il presidente del Consiglio di Transizione è l’ex ministro della giustizia libico Mustafà Abdel Jalil, bengasino come l’ex ministro degli interni, il generale Abdul Fattah Younes, dirigente militare passato con i ribelli alla fine di febbraio, dopo una lunga carriera all’ombra di Gheddafi, insieme al quale i due hanno amministrato repressione e “giustizia”. Gerarchi che, secondo Cararo, «hanno approfittato della congiuntura favorevole derivata dalle rivolte popolari in Tunisia ed Egitto», mandando avanti i giovani: fallita la spallata al raìs, hanno ripiegato sulla guerra civile, sperando nell’intervento internazionale. Se Gheddafi cade, si realizza il “piano-A”; se  invece resiste, scrive Cararo, si passerà al “piano-B”, la secessione: proprio la Cirenaica è infatti la regione più ricca di petrolio e di gas.
invece resiste, scrive Cararo, si passerà al “piano-B”, la secessione: proprio la Cirenaica è infatti la regione più ricca di petrolio e di gas.
Emblematico di questa competizione soprattutto energetica, scrive Cararo, è il ruolo giocato contro la Libia, in seno alla Lega Araba, dalle monarchie petrolifere del Golfo: collaborando all’attacco militare «hanno ottenuto che nessun membro della “comunità internazionale” mettesse becco sulla repressione contro le rivolte popolari in Yemen e Bahrein, dove c’è stato addirittura l’intervento militare diretto dell’Arabia Saudita». Per non parlare del Qatar, che oltre a inviare bombardieri in Libia ha affidato alla tv satellitare Al Jazeera il compito di scatenare un fortissimo attacco mediatico contro Gheddafi, insieme all’altra rete satellitare, Al Arabiya, che è sotto controllo saudita. Le monarchie del Golfo inoltre garantiscono forniture petrolifere in grado di rimpiazzare quelle libiche e per di più pagate sempre in dollari: «Un enorme assist per l’economia Usa alle prese con un debito pubblico stellare». Tramonta così la paura peggiore per gli americani: il timore che produttori come Iran, Venezuela, Russia e Libia potessero dar vita a una sorta di “Opec separata”, con transazioni petrolifere pagare in Euro o in Yuan cinese (info: www.megachip.info).
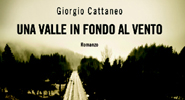
 Tank e bombe, made in Italy l'arsenale del Colonnello
Tank e bombe, made in Italy l'arsenale del Colonnello Fortress Europe: fra i morti di Bengasi, ringraziando l'Onu
Fortress Europe: fra i morti di Bengasi, ringraziando l'Onu Le ipocrisie sulla Libia e il crimine dell'indifferenza
Le ipocrisie sulla Libia e il crimine dell'indifferenza Fratelli d'Italia e di Gheddafi, il nostro eroe impresentabile
Fratelli d'Italia e di Gheddafi, il nostro eroe impresentabile Libia, Cecenia, Bosnia e Ruanda: non-ingerenza e genocidio
Libia, Cecenia, Bosnia e Ruanda: non-ingerenza e genocidio