Addio a Nico Orengo, terso cantore del Ponente
«Nico Orengo se ne è andato in fretta. Non voleva seguitare a vivere ridotto come l’aveva ridotto il male. Se ne è andato in fretta e con quella leggerezza che profilava il suo tratto umano. La leggerezza del poeta». Così “Il Giornale” saluta lo scrittore Nico Orengo, spentosi improvvisamente a Torino, il 30 maggio, all’età di 67 anni. Narratore tra i più originali in Italia, ma anche poeta e giornalista culturale che, come scrive “La Stampa”, «sapeva polemizzare acutamente senza tuttavia ferire, grazie a una ironia soffusa di malinconie e di nostalgia», Orengo era molto legato all’estremo Ponente ligure, ai confini con la Francia, teatro di gran parte dei suoi romanzi.
Aveva lavorato alla casa editrice Einaudi dal 1964 al 1977, entrando successivamente a “La Stampa” di cui diresse il settimanale “Tuttolibri” fino al  2007. Ha pubblicato i suoi libri da Einaudi: da “Ribes” a “Le rose di Evita”, “La guerra del basilico”, “Dogana d’amore”, “Il salto dell’acciuga”, “La curva del latte”, “Di viole e liquirizia” (ambientato nelle Langhe), “Hotel d’Angletterre”, “Islabonita” (uscito pochi mesi fa). «Sapeva raccontare come pochi altri», scriove “La Stampa”. «Del romanziere di razza, che si fa amare dal suo pubblico, aveva la facilità e la limpidezza di scrittura, la capacità di ideare trame avvincenti e mai banali, l’abilità di giostrare tra passato e presente, tra personaggi minori, dimenticati, locali, e protagonisti della Storia (come nel caso di Evita Peròn, all’epoca del suo passaggio a Bordighera)».
2007. Ha pubblicato i suoi libri da Einaudi: da “Ribes” a “Le rose di Evita”, “La guerra del basilico”, “Dogana d’amore”, “Il salto dell’acciuga”, “La curva del latte”, “Di viole e liquirizia” (ambientato nelle Langhe), “Hotel d’Angletterre”, “Islabonita” (uscito pochi mesi fa). «Sapeva raccontare come pochi altri», scriove “La Stampa”. «Del romanziere di razza, che si fa amare dal suo pubblico, aveva la facilità e la limpidezza di scrittura, la capacità di ideare trame avvincenti e mai banali, l’abilità di giostrare tra passato e presente, tra personaggi minori, dimenticati, locali, e protagonisti della Storia (come nel caso di Evita Peròn, all’epoca del suo passaggio a Bordighera)».
Il paesaggio ligure, i marinai e i mercanti del sale, i pescatori e alcune seducenti figure di donne dal passato misterioso, innervano le sue narrazioni, in cui si fondono bene il registro comico e quello triste. Nel 1992, ne “Gli spiccioli di Montale”, ricorda il quotidiano torinese, aveva espresso la sua amarezza e la sua indignazione civile per la speculazione edilizia che stava deturpando la costa rivierasca. «Amava i pittori e i colori, il buon cibo e il buon vino, le sigarette eterne come quelle del salgariano Yanez, e il mare della Mortola e dei Balzi Rossi, i caffè di Marina San Giuseppe di Ventimiglia, i racconti per i bambini per i quali aveva scritto delle bellissime filastrocche».
Da Sciascia e Soldati ad Arpino e Calvino, da Rigoni Stern e Fruttero & Lucentini a Celati e Tondelli, da Bertolucci e Moravia a Del Buono e Meneghello, fino a Soriano, Puig, Dürrenmatt, Burgess: decine gli scrittori intervistati da Nico Orengo, in colloqui raccolti nel volume “L’inchiostro delle voci” (“La Stampa”, 1992). L’ultimo libro di Orengo, “Islabonita”, racconta di un’anguilla arrivata dal Mar dei Sargassi, una donna un po’ maga e un intrigo alla Ambler: è l’ultimo romanzo di Nico Orengo, nella Liguria anni ‘20. «Una Liguria – ha scritto su “Tuttolibri” Carlo Fruttero – per cui Orengo da sempre porta un amore totale, raccontandone con straordinaria evidenza e poesia i sassi, gli arbusti,gli odori, i sentieri, le onde».
Estremamente affettuoso il commiato che gli dedica “Il Giornale”: Orengo, scrive la redazione, «si cimentò in altri aspetti dell’attività intellettuale, fu narratore, giornalista e responsabile di “Tuttolibri”, quando l’inserto culturale della “Stampa” era all’apice della popolarità e del consenso. In quella veste Orengo detenne per lungo tempo un notevole potere – riferito al villaggio delle patrie lettere, s’intende – che tuttavia gestì con parsimonia». Il suo orizzonte letterario era «volutamente chiuso fra Torino e un fazzoletto di terra ligure di confine che pennellava lo scenario di ogni suo romanzo: la Mortola, Montegrosso Pian Latte, i giardini Hanbury, Dolceacqua, le alture che si spingono ai Balzi Rossi: tutto lì il mondo, tutta lì la favola di Nico Orengo».
Cresciuto all’Einaudi di Giulio Einaudi, aggiunge “Il Giornale”, sembrava destinato a ingrossare le fila «degli intellettuali élitari e altezzosi che quella casa editrice allevava». Forse, agli inizi della carriera «inalberò pure la spocchia, ma fece presto a disfarsene senza tuttavia rinunciare al registro culturalmente aristocratico che era degli einaudiani». La sua, aggiunge il quotidiano, «era una scrittura all’apparenza libera, eppure molto attenta al ritmo musicale delle parole e alla armonia della frase. Anche in prosa, scriveva da poeta e da poeta si lasciava prendere dal comico e dal patetico, dal dolce e dall’amaro di un’esistenza vissuta come nel sogno».
«Ebbe in sorte d’essere amato», conclude “Il Giornale”, con dolcezza, ricordandone la fedeltà negli affetti e gli ottimi rapporti coi quattro figli e con le donne che hanno con lui diviso la vita e che fino all’ultimo hanno avuto, per lui, «parole di affetto e di malinconica dolcezza non certo dettate dalle circostanze, ma scaturite da un sentimento uscito indenne dalle tribolazioni che la vita riserva. Lo stesso che lascerà a quanti l’hanno conosciuto, ora che con la leggerezza e l’innocenza del poeta Nico Orengo ha raggiunto i pascoli del cielo».
Straziato dal lutto l’amico Lorenzo Mondo, a lungo vicedirettore della “Stampa”. «Ricordo dell’uomo la signorilità del tratto, la sorridente docilità del carattere, l’intelligenza irrequieta», dice, nella traccia audio registrata per il sito web del quotidiano torinese. «E richiamo alla memoria turbata la sequenza dei suoi libri, che narrano con una tersa, poetica scrittura, genti e paesi della sua Liguria, di cui resta il più accreditato cantore. E’ un lascito prezioso, un’amicizia che continua, per chiunque sappia apprezzare il bene della lettura».
NICO ORENGO IS DEAD - Nico Orengo, 67, is dead in Turin, may 30. Journalist and poet, he was one of the most appreciated Italian writers. He wrote little stories of little people, through forgotten lands between Piedmont and France, the Alps and the Sea.
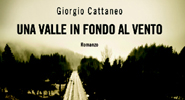
 Fruttero e Lucentini: segreti e perfidia di una coppia geniale
Fruttero e Lucentini: segreti e perfidia di una coppia geniale Addio a Sanguineti, era il cielo in versi
Addio a Sanguineti, era il cielo in versi Alda Merini: lascerei Milano solo per il Paradiso
Alda Merini: lascerei Milano solo per il Paradiso Fernanda Pivano: grazie ragazzi, non smettete di sognare
Fernanda Pivano: grazie ragazzi, non smettete di sognare Diario: nella casbah di Torino, per vincere la paura
Diario: nella casbah di Torino, per vincere la paura